Il cinema, nella sua forma più pura, è un atto di ribellione. È la visione di un artista che si scontra con le convenzioni. Ci sono i grandi classici che hanno definito il cinema drammatico – e li troverete qui – ma il cuore del cinema batte spesso anche in quest’anima ribelle: film che rifiutano di essere contenuti in una formula.
Questa non è una semplice lista, ma un percorso che unisce i pilastri fondamentali, dai film più famosi al cinema indipendente più sconosciuto. Opere che, attraverso la loro visione, hanno ridefinito i confini del cinema drammatico, offrendo sguardi indimenticabili sulla complessità della condizione umana.
Il panorama del cinema drammatico è vasto. Per aiutarti a orientarti, abbiamo analizzato le correnti vitali del genere, guidandoti verso il tipo specifico di esperienza emotiva che stai cercando.
🆕 I Migliori Drammi Recenti
L’Innocenza (Monster) (2023)
Quando il piccolo Minato inizia a comportarsi in modo strano, sua madre intuisce che qualcosa non va a scuola e accusa l’insegnante Hori di averlo maltrattato. La storia sembra chiara: un caso di abuso scolastico. Ma il film riavvolge il nastro e ci racconta gli stessi eventi da tre punti di vista diversi: quello della madre, quello dell’insegnante e infine quello del bambino. Ogni cambio di prospettiva ribalta completamente la verità, svelando una storia segreta di amicizia, incomprensione e pregiudizio.
Il maestro giapponese Hirokazu Kore-eda (Un affare di famiglia) firma un dramma a incastri (“alla Rashomon”) che è un pugno nello stomaco emotivo. Con la musica postuma del leggendario Ryūichi Sakamoto, il film è un’indagine delicata e straziante su come gli adulti proiettino i loro “mostri” sui bambini, ignorando la purezza e la complessità dei loro sentimenti. Un film che ti costringe a ripensare a ogni giudizio che hai dato.
Il male non esiste (Evil Does Not Exist) (2024)
Takumi e sua figlia vivono una vita modesta e in armonia con i cicli della natura in un villaggio vicino a Tokyo. La pace viene minacciata quando una compagnia di spettacolo di Tokyo decide di costruire un lussuoso sito di “Glamping” (campeggio glamour) proprio nel loro bosco, ignorando l’impatto devastante che avrà sulle falde acquifere e sulla comunità. Quello che inizia come un dramma ecologico si trasforma, con una lentezza inesorabile, in qualcosa di molto più oscuro e misterioso.
Il maestro giapponese Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car) realizza un film ipnotico, fatto di silenzi, alberi e sguardi. Non è un film ambientalista banale, ma una meditazione filosofica sulla violenza intrinseca nella natura e nell’uomo. Il finale, enigmatico e scioccante, è uno dei momenti di cinema puro più discussi dell’anno. Per chi ama il cinema lento che entra sotto pelle.
Vermiglio (2024)
In un remoto villaggio di montagna del Trentino, nel 1944, la guerra sembra lontana ma onnipresente. La vita della numerosa famiglia del maestro del paese viene sconvolta dall’arrivo di Pietro, un soldato disertore siciliano che si nasconde nella loro casa. La figlia maggiore, Lucia, si innamora di lui, innescando una serie di eventi che cambieranno per sempre l’equilibrio della comunità.
Vincitore del Leone d’Argento a Venezia, questo è il cinema italiano al suo meglio: rigoroso, dialettale, visivamente pittorico (ricorda l’Olmi de L’albero degli zoccoli). Maura Delpero racconta un dramma rurale senza nostalgia, mostrando la durezza della vita di montagna, le dinamiche familiari soffocanti e il peso della storia sulle spalle delle donne. Un film di una bellezza austera e commovente.
Il seme del fico sacro (The Seed of the Sacred Fig) (2024)
Iman è un giudice istruttore nella Teheran contemporanea, alle prese con le proteste politiche che infiammano il paese. Mentre la pressione del regime per condannare i manifestanti aumenta, la sua pistola di servizio scompare misteriosamente da casa. Il sospetto di Iman ricade immediatamente sulla moglie e sulle due figlie, trasformando la casa in una prigione di paranoia, interrogatori e sfiducia reciproca che rispecchia la dittatura esterna.
Il regista Mohammad Rasoulof ha girato questo film in clandestinità prima di fuggire dall’Iran per evitare il carcere. È un dramma politico che si traveste da thriller domestico. La tensione è insostenibile: la famiglia diventa la metafora di una nazione intera che si sta sgretolando sotto il peso della menzogna e della repressione. Un film urgente, coraggioso e devastante.
Una visione curata da un regista, non da un algoritmo
In questo video ti spiego la nostra visione
All We Imagine as Light (Amore a Mumbai) (2024)
Prabha e Anu sono due infermiere che vivono insieme a Mumbai. Prabha è bloccata nel ricordo di un matrimonio combinato con un uomo che l’ha lasciata per andare in Germania; Anu vive una storia d’amore segreta e proibita con un ragazzo musulmano. Le loro vite, fatte di lavoro notturno e luci al neon sotto la pioggia, cambiano quando decidono di fare un viaggio verso una città costiera, dove la foresta mistica permette ai loro desideri repressi di manifestarsi.
Vincitore del Grand Prix a Cannes (il primo film indiano in concorso dopo 30 anni), è un’opera di una poesia visiva rara. Payal Kapadia dipinge un ritratto femminile delicato e sensuale, lontano dai cliché di Bollywood. È un film sull’amicizia femminile, sulla luce e sull’acqua, con un’atmosfera onirica che ricorda il cinema di Wong Kar-wai. Per chi cerca un’esperienza emotiva avvolgente e luminosa.
Altin in città

Film drammatico, thriller, di Fabio Del Greco, Italia, 2017.
Altin, aspirante scrittore albanese sbarcato in Italia a bordo di un grande traghetto negli anni ’90, lavora in una macelleria quando viene selezionato ad un provino di un reality per scrittori e vede finalmente la possibilità di avere successo con il suo libro “il viaggio di Ismail”. È invece il momento in cui iniziano le sue disavventure che lo porteranno a conoscere la vendetta, la solitudine, la povertà, fino al lato oscuro della ricchezza e del successo.
La tematica di Altin in città non deve indurre a pensare che sia solo la storia di un giovane immigrato che cerca di integrarsi. In realtà, È un racconto in cui avidità, sete di potere e successo, cinismo e arrivismo si intrecciano, creando una sorta di Faust moderno e un nuovo "patto col diavolo" appartenente al XXII secolo, che potremmo sintetizzare come: show business. Il reality-show diventa la Mecca, la chiave di volta e il trampolino per chi desidera raggiungere il successo senza sforzo. Del Greco ci presenta questo mondo con una sottile ironia, caratterizzata da sfumature kitsch e toni parodistici. Tuttavia, il successo senza sforzo ha un prezzo: Altin ha venduto la sua anima al diavolo e, da facile preda dello showbiz televisivo, presto diventerà vittima di se stesso.
LINGUA: italiano
SOTTOTITOLI: inglese, spagnolo, francese, tedesco
Perfect Days (2023)
Hirayama è un uomo di poche parole che lavora come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. La sua vita è scandita da una routine perfetta e apparentemente monotona: si sveglia, lavora con dedizione meticolosa, mangia un panino al parco osservando gli alberi, legge libri usati e ascolta vecchie cassette rock nel suo furgone. Dietro questa semplicità monastica, però, si nasconde un passato complesso e una scelta consapevole di vivere nel “qui e ora”, cercando la bellezza nelle piccole cose che il mondo moderno ignora.
Wim Wenders torna al suo cinema più puro con un’opera zen che è un balsamo per l’anima. Non c’è una trama tradizionale, ma una sequenza di giorni che diventano una meditazione sulla dignità del lavoro e sulla pace interiore. Kōji Yakusho offre una performance monumentale fatta di soli sguardi e sorrisi accennati (premiata a Cannes), trasformando un film sulla solitudine in un inno alla gioia di esistere. Un capolavoro di sottrazione.
Estranei (All of Us Strangers) (2023)
Adam (Andrew Scott), uno sceneggiatore solitario che vive in un grattacielo quasi vuoto a Londra, inizia una relazione con il misterioso vicino Harry (Paul Mescal). Contemporaneamente, decide di visitare la sua casa d’infanzia in periferia, dove ritrova i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) esattamente come erano trent’anni prima, il giorno in cui morirono in un incidente d’auto. Adam inizia a visitarli regolarmente, parlando con i fantasmi dei suoi genitori per fare coming out e dire tutte le cose che non ha mai potuto dire, mentre la realtà e il sogno iniziano a confondersi.
Andrew Haigh dirige un ghost-story metafisica che è in realtà un dramma psicologico potentissimo sul lutto, la solitudine gay e il bisogno di amore. Non fa paura, ma spezza il cuore. È un viaggio onirico e malinconico che esplora il desiderio impossibile di tornare bambini per essere consolati e capiti. Le performance sono straordinarie e il film lascia un senso di intimità e vulnerabilità raro nel cinema contemporaneo.
Foglie al vento (Fallen Leaves) (2023)
Due anime solitarie nella Helsinki di oggi — Ansa, una cassiera di supermercato licenziata ingiustamente, e Holappa, un operaio metalmeccanico con problemi di alcolismo — si incrociano per caso in un karaoke bar. Cercano di costruire una relazione nonostante le avversità del destino: numeri di telefono perduti, incomprensioni, la depressione e l’ombra della guerra in Ucraina che risuona costantemente dalle radio.
Il maestro finlandese Aki Kaurismäki torna con una tragicommedia minimalista che è un piccolo miracolo di umanità. Con il suo stile inconfondibile (colori saturi, recitazione impassibile, umorismo laconico), racconta una storia d’amore proletaria tra due persone che la vita ha calpestato ma che non si arrendono. È un film essenziale, breve e poetico, che celebra la solidarietà e la dignità degli “ultimi” con un calore e una speranza inaspettati.
Il Dramma Indie e d’Autore
Lontano dai cliché e dai lieto fine forzati di Hollywood, il dramma indipendente è il luogo dove il cinema torna a essere specchio fedele della realtà. Qui troverai storie che non hanno paura del silenzio, dell’imperfezione e della complessità umana. Sono film liberi, spesso realizzati con budget ridotti ma con un cuore enorme, capaci di raccontare relazioni, crisi e rinascite con una sincerità disarmante che colpisce dritto allo stomaco.
👉 ESPLORA IL CATALOGO: Guarda i Drammi Indipendenti in Streaming
Charlie says

Drammatico, di Mary Harron, Stati Uniti, 2019.
Karlene Faith è una assistente sociale che lavora nel carcere femminile dove sono rinchiuse Leslie Van Houten, detta Lulu, Patricia Krenwinkel detta Katie e Susan Atkins detta Sadie. Sono tre "Manson's Girls", le ragazze della setta di Charles Manson, colpevoli di aver partecipato a crimini efferati, condannate alla pena di morte per l'assassinio di nove persone, compresa l’attrice Sharon Tate. Dopo diversi anni le 3 ragazze sono ancora succubi della personalità di Manson, nonostante la reclusione. Una sorta di lavaggio del cervello che è penetrato nella loro mente in forma di dogmi esistenziali. Karlene tenta di deprogrammare la loro mente. Le ragazze non sembrano affatto dei mostri, delle assassine psicopatiche. Ad inquietare davvero è la loro normalità: è come se vivessero in "un altro mondo", sotto una profonda ipnosi dalla quale non riescono a svegliarsi. Non riescono a prendere di coscienza di quello che hanno fatto.
La sceneggiatrice Guinevere Turner scrive una storia molto sentita, partendo da un'esperienza personale della sua adolescenza in cui lei e la sua famiglia si trovarono a partecipare ad un culto nella comunità di Mel Lyman, i cui adepti aspiravano ad andare a vivere sul pianeta Venere. La regista Mary Harron non descrive Charles Manson come la personificazione del male, un personaggio enigmatico e maledetto. Lo tratteggia invece come un uomo mediocre, razzista, un fallito che non è riuscito a realizzare il suo sogno di diventare musicista e sfoga la sua rabbia repressa e le sue frustrazioni umiliando altri, in un crescendo di follia e di violenza. Charlie says racconta la figura di Charlie Manson in modo più realistico, da un punto di vista femminile. La pena di morte delle 3 donne fu in seguito convertita in ergastolo.
LINGUA: italiano
I Grandi Classici del Dramma
Prima degli effetti speciali e dei ritmi frenetici moderni, il cinema si basava su una sola cosa: la potenza della scrittura e dell’interpretazione. In questa sezione celebriamo i pilastri della settima arte, quelle opere intramontabili che hanno definito cosa significa “dramma” sul grande schermo. Dal bianco e nero dell’età dell’oro di Hollywood al Neorealismo, questi sono i film che ogni appassionato dovrebbe vedere almeno una volta nella vita per capire le radici del linguaggio cinematografico.
👉 VAI ALLA SELEZIONE: Film Classici Drammatici
Film Biografici: Vite Straordinarie
Non c’è sceneggiatore più creativo della vita stessa. Il Biopic non è semplice cronaca o imitazione di personaggi celebri; è l’arte di distillare l’essenza di un’esistenza in due ore. Dai grandi leader agli artisti maledetti, queste opere ci permettono di camminare nelle scarpe di qualcun altro, esplorando le luci e le ombre di chi ha lasciato un segno indelebile nella storia. Qui non si giudica, si comprende l’uomo dietro il mito.
👉 VAI ALLA SELEZIONE: Film Biografici
Il Dramma Storico
Il passato è uno specchio in cui leggere il presente. Il Dramma Storico usa costumi d’epoca e grandi eventi per raccontare passioni universali che non invecchiano mai. Che si tratti di intrighi di corte, rivoluzioni sociali o epopee antiche, questo genere unisce la grandiosità visiva all’intimità emotiva. È il cinema che ci ricorda da dove veniamo e come i grandi sconvolgimenti della Storia abbiano sempre, al centro, un cuore umano che batte.
👉 VAI ALLA SELEZIONE: Film Storici
Il Cinema della Memoria (La Shoah)
Ci sono eventi che il cinema ha il dovere morale di raccontare, non per intrattenere, ma per testimoniare. I film sull’Olocausto rappresentano una delle vette più alte e dolorose del genere drammatico. Sono opere necessarie, spesso difficili da guardare, che trasformano l’orrore indicibile della Storia in un monito per il futuro. Qui il dramma si fa documento, memoria e resistenza contro l’oblio.
👉 VAI ALLA SELEZIONE: Film sulla Shoah
Corona days

Film drammatico, di Fabio Del Greco, Italia, 2020.
Un uomo resta in casa solo, a causa delle misure d'emergenza Corona virus. La solitudine, il tempo e lo spazio diventano i suoi nemici, l'immaginazione, i ricordi e la voglia di libertà i suoi alleati. Il regista Fabio Del Greco documenta i giorni di isolamento del corona virus in maniera intima e personale, girando gli esterni esclusivamente con uno smartphone. La cronaca di questi strani giorni diventa spunto per una riflessione sulla relatività del tempo e dello spazio e di come la libertà sia qualcosa che può trascendere la realtà per trovare casa nella nostra anima.
In tempi di Corona virus, un regista genuino e istintivo come Del Greco ha raccolto i frutti del suo eccentrico "cinediario" realizzato durante le settimane di quarantena. Ha catturato la sua stessa solitudine da vicino e, da una distanza sicura, quella dei suoi amici e parenti. Soprattutto, ha colto le scarse "ore d'aria" concesse dalle autorità per girare in un mondo svuotato di umanità e sottoposto a rigorosi controlli di polizia. Tutto visto attraverso lo sguardo di un autore che, come consueto, è giocoso, disincantato e sottilmente ironico, anche quando si mette in scena come attore. Procedendo nell'esplorazione della realtà, tra spunti malinconici e lampi di ironia, Fabio Del Greco supera questa iniziale e trasforma il suo lungometraggio in un gioco di scatole cinesi, dove convergono contributi audiovisivi diversificati, cronologicamente difformi ma tutti profondamente stimolanti e carichi di significato. L'intreccio tra presente e passato, abilmente orchestrato anche nel montaggio, crea un cortocircuito in cui il passato non è soltanto un almanacco di ricordi, ma un'altra fuga nel regno dell'immaginario. Mentre emerge una critica socio-politica, pur legittima, il racconto si sposta gradualmente verso un quadro esistenziale più ampio.
LINGUA: italiano
SOTTOTITOLI: inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese
Il Dramma Sociale e le Dipendenze
Un viaggio al termine della notte. I film sulla droga e sulle dipendenze esplorano la fragilità umana senza filtri, mostrandoci la discesa agli inferi e, talvolta, la risalita. È un cinema crudo, spesso indipendente e stilisticamente audace, che non cerca di fare la morale ma di mostrare la realtà della condizione umana quando è spogliata di ogni difesa. Storie di autodistruzione, ma anche di disperata ricerca di vita.
👉 VAI ALLA SELEZIONE: Film sulla Droga
Cinema di Denuncia: La Violenza sulle Donne
Il dramma diventa strumento di consapevolezza. Questa sezione raccoglie le opere che hanno avuto il coraggio di rompere il silenzio su temi urgenti e dolorosi. Non sono film che cercano la pietà dello spettatore, ma la sua indignazione e la sua empatia. Storie di sopravvivenza, di lotta e di dignità che usano la potenza del linguaggio cinematografico per dare voce a chi, troppo spesso, non viene ascoltato.
👉 VAI ALLA SELEZIONE: Film sulla Violenza sulle Donne
Il Dramma Sportivo
Non è mai solo una questione di punteggio. Il film sportivo usa la competizione atletica come metafora perfetta della vita: la caduta, il sacrificio, l’allenamento e il riscatto. Che si tratti di boxe, corsa o scacchi, queste storie toccano le corde più profonde della resilienza umana. È il cinema degli “underdog”, degli svantaggiati che combattono contro i propri limiti prima ancora che contro l’avversario.
👉 VAI ALLA SELEZIONE: Film Sportivi
Film drammatici anni ’30 e ’40
I film drammatici degli anni ’30 e ’40 riflettono due decenni segnati da profondi sconvolgimenti sociali, economici e politici. Dagli effetti della Grande Depressione agli orrori della Seconda Guerra Mondiale, il dramma cinematografico si fece più realistico, intenso e psicologicamente profondo, raccontando storie di resilienza, perdita e speranza attraverso personaggi complessi.
I bambini di Hiroshima
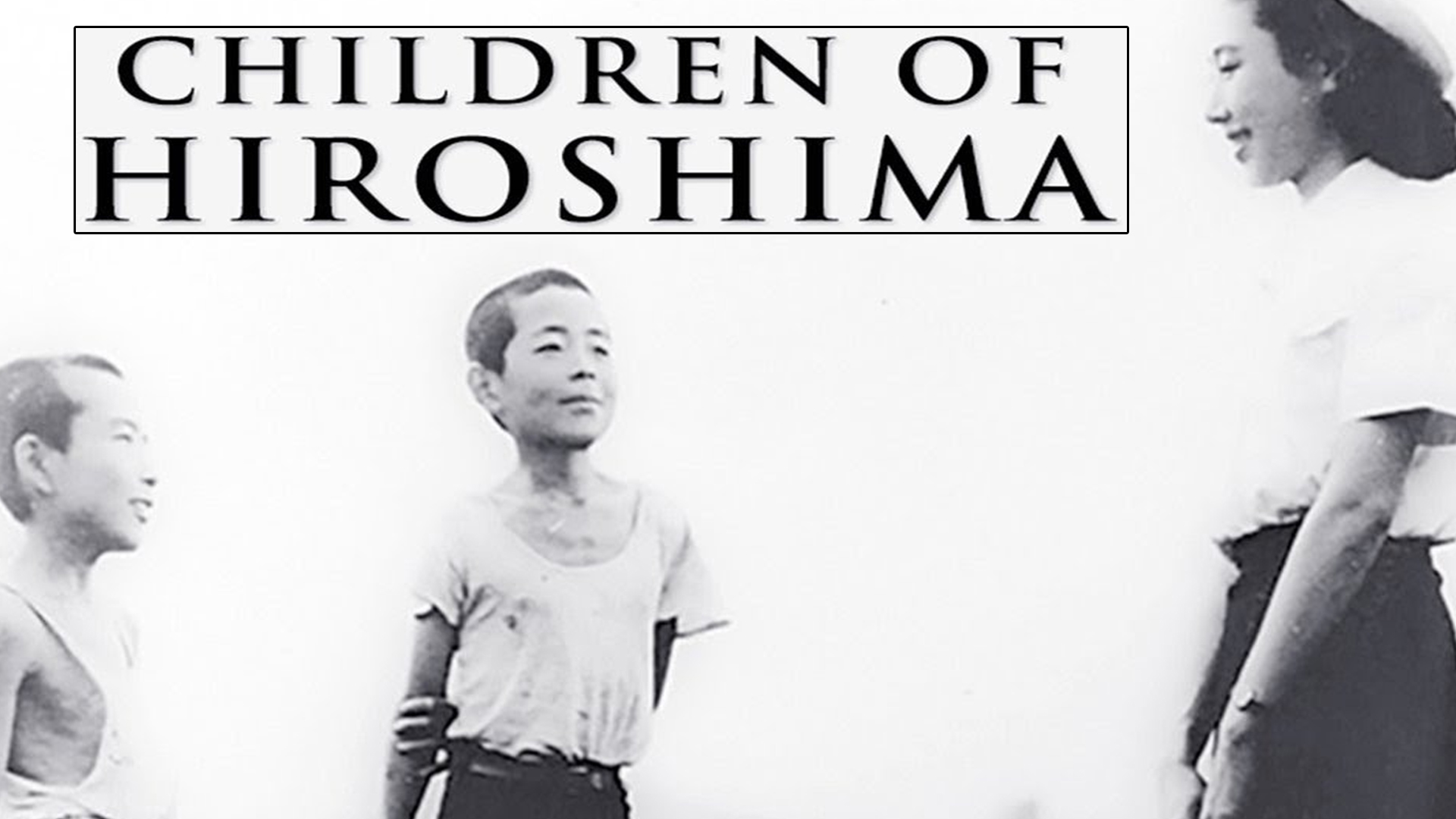
Dramma, di Kaneto Shindō, Giappone, 1952.
Takako Ishikawa è un insegnante al largo della costa di Hiroshima e non è tornato nella sua città colpita dalla bomba atomica da 4 anni. Il suo viaggio a Hiroshima diventa un viaggio nella sua patria distrutta, alla ricerca di vecchi amici sopravvissuti. La città è stata quasi ricostruita, ma la tragedia è ancora molto presente: i volti sfigurati, le membra rattrappite, le donne sterili e i bambini minorati senza allegria. In un vecchio cieco accompagnato dal nipote Taro Takako riconosce il servitore della propria famiglia, distrutta con la casa.
Film girato con sobrietà, mostra la tragedia della bomba solo in un breve flashback dalla protagonista in pochi secondi di immagini allucinanti. La breve scena però rimane sempre presente nella mente di lei come nella mente dello spettatore. Il tono di Kaneto Shindo non è quello di un resoconto storico ma quello di un'emozione lirica intensa e trattenuta, che cerca la sua essenza nei dettagli. Nel cielo, finalmente, un aereo passa: gli occhi della maestra sono colmi d'angoscia, quelli del bambino sono soltanto puri e curiosi. In concorso al Festival di Cannes del 1953, girato nel dopoguerra quando il dolore era ancora fresco, ricco di atmosfere cupe e realistiche. Shindo, morto a 100 anni nel 2012, meno conosciuto in Occidente di Mizoguchi, Kurosawa, realizza il suo capolavoro con questo film.
LINGUA: giapponese
SOTTOTITOLI: italiano, inglese
M (1931)
Il primo capolavoro sonoro di Fritz Lang non è solo un thriller procedurale, ma un trattato sociologico sulla paranoia e sulla giustizia sommaria che anticipa con agghiacciante precisione il collasso della Repubblica di Weimar. Lang utilizza il sonoro non come orpello decorativo, ma come elemento drammaturgico primario, sfruttando il silenzio e il fuori campo per creare una tensione insostenibile. Il fischio di “In the Hall of the Mountain King” (Nell’antro del re della montagna) di Edvard Grieg non è solo un leitmotiv musicale, è la manifestazione uditiva della pulsione omicida che Hans Beckert non può controllare, un marchio sonoro che lo condanna prima ancora delle prove fisiche. Il film smantella la struttura classica del protagonista eroico; il vero protagonista è la città di Berlino, un organismo vivente malato, labirintico e soffocante, dove le distinzioni morali tra la polizia e il crimine organizzato sfumano fino a scomparire completamente.
La grandezza di Peter Lorre nel ruolo di Beckert risiede nella sua capacità di trasformare un mostro in una figura di patetica impotenza. Nel monologo finale, di fronte al “tribunale” dei criminali organizzati che lo hanno catturato perché la sua presenza disturbava i loro affari, Lang costringe lo spettatore a una posizione scomoda e insostenibile: riconoscere l’umanità disperata di un assassino di bambini. Beckert urla “Non posso farne a meno!”, contrapponendo la sua follia patologica alla scelta deliberata del male compiuta dai criminali che lo giudicano. Visivamente, il film è un ponte tra l’espressionismo tedesco degli anni Venti e il futuro film noir americano, utilizzando ombre allungate, inquadrature dall’alto e composizioni geometriche claustrofobiche per suggerire che il male non è un’anomalia esterna, ma una componente intrinseca della struttura sociale. La caccia all’uomo diventa una metafora della sorveglianza totale e della mobilitazione di massa contro il “diverso”, un tema che risuonerà tragicamente negli anni successivi con l’ascesa del nazismo.
Limite (1931)
Unico lungometraggio del brasiliano Mário Peixoto, quest’opera è rimasta per decenni un oggetto misterioso, quasi mitologico, della cinematografia mondiale. Venerata da figure come Orson Welles e Walter Salles, ma raramente vista dal grande pubblico a causa della difficoltà di reperire copie in buone condizioni fino ai restauri recenti, Limite è un poema visivo sulla prigionia esistenziale e sulla futilità dell’azione umana. La trama, deliberatamente eterea e non lineare, segue due donne e un uomo alla deriva in una barca, le cui storie passate emergono attraverso flashback frammentati che non spiegano, ma evocano sensazioni di perdita e disperazione. Non c’è una narrazione aristotelica, ma un flusso di coscienza visivo che anticipa le sperimentazioni europee di decenni successivi.
Peixoto lavora ossessivamente sul concetto di “limite” visivo e fisico, ispirato da una fotografia di André Kertész vista a Parigi che ritraeva mani ammanettate attorno al collo di una donna. La cinepresa indugia su mani che non riescono ad afferrare, recinti, orizzonti irraggiungibili e movimenti circolari che non portano a nulla. L’influenza delle avanguardie sovietiche (nel montaggio) e dell’impressionismo francese (nella fotografia) è evidente, ma il tono è unicamente brasiliano nella sua malinconia tropicale, una saudade visiva che permea ogni fotogramma. Il film è un’esperienza sensoriale dove l’acqua e il tempo corrodono la volontà dei personaggi; la colonna sonora, che include le Gymnopédies di Erik Satie, accentua il senso di stasi e sospensione temporale. La sua recente restaurazione ha permesso di riaffermare la sua posizione come pietra miliare del cinema sperimentale latinoamericano, un’opera che rifiuta la logica della drammaturgia borghese per abbracciare una purezza cinematografica assoluta, dove l’immagine precede e supera la parola.
L’Atalante (1934)
Jean Vigo, morto tragicamente giovane di tubercolosi poco dopo l’uscita di questo film, ci ha lasciato con L’Atalante un testamento di vitalità anarchica e romanticismo febbrile. Apparentemente la storia è semplice e quasi banale: il matrimonio tra Jean, il capitano di una chiatta, e Juliette, una ragazza di villaggio, e la loro vita lungo i canali francesi verso Parigi. Tuttavia, Vigo trasforma questo spunto narrativo in un’esplorazione onirica dell’amore, del desiderio e della noia coniugale. La chiatta diventa un microcosmo galleggiante, sospeso tra la realtà grigia della depressione economica e la magia surreale evocata dall’eccentrico Père Jules. Interpretato da un Michel Simon in stato di grazia, Jules è un accumulatore di cianfrusaglie e memorie, un personaggio grottesco e tenero che rappresenta l’anima anarchica e disordinata del mondo, in contrasto con la rigidità della vita sulla terraferma.
La sequenza sottomarina, in cui Jean si tuffa nel fiume e vede il volto dell’amata fluttuare nell’acqua come un’apparizione spettrale, è uno dei momenti più alti del realismo poetico francese e dimostra la capacità di Vigo di fondere il documentario sociale con l’avanguardia surrealista. Vigo suggerisce che l’amore vero è una forma di allucinazione condivisa, capace di trasfigurare la realtà più squallida. Non c’è sentimentalismo, ma un’erotica della quotidianità; la sporcizia, la nebbia, i gatti randagi e gli spazi angusti della chiatta sono trattati con la stessa reverenza dei sentimenti dei protagonisti. L’Atalante è un film che respira, che pulsa di una libertà formale che ignora le regole della continuità classica per privilegiare l’intensità emotiva dell’istante, influenzando profondamente registi futuri come François Truffaut e il movimento della Nouvelle Vague.
Make Way for Tomorrow (1937)
Spesso citato da Orson Welles come il film “che farebbe piangere una pietra”, il capolavoro di Leo McCarey è una disamina devastante della disgregazione familiare causata dalle pressioni economiche della Grande Depressione. Mentre Hollywood vendeva sogni di rivalsa e commedie sofisticate (genere in cui McCarey stesso eccelleva), qui il regista guardava in faccia la realtà della vecchiaia, dell’obsolescenza e della dipendenza economica. La storia di Bark e Lucy Cooper, una coppia anziana costretta a separarsi perché nessuno dei cinque figli può o vuole ospitarli entrambi dopo che la banca ha pignorato la loro casa, è trattata senza il minimo ricorso al melodramma manipolativo. La crudeltà dei figli non nasce da una malvagità da cartone animato, ma da un egoismo pragmatico e moderno; essi rappresentano una generazione che vede gli anziani come un problema logistico da risolvere piuttosto che come una risorsa morale.
La regia di McCarey è invisibile e per questo potentissima, lasciando spazio alle performance strazianti di Victor Moore e Beulah Bondi. L’influenza di questo film su Yasujirō Ozu e il suo Viaggio a Tokyo è palese e documentata, ma la versione americana possiede una disperazione specifica legata all’individualismo occidentale e al crollo del sogno americano. Le ultime scene, in cui la coppia trascorre qualche ora finale insieme a New York prima di una separazione che sanno essere definitiva, sono un tributo alla dignità umana che persiste anche di fronte all’indifferenza sociale. È un atto d’accusa verso una società capitalista che, nella corsa al progresso e all’efficienza, ha dimenticato il valore della memoria e della gratitudine, trattando le persone come beni ammortizzabili.
Il lamento sul sentiero

Drammatico, di Satyajit Ray, India, 1955.
Negli anni '10 a Nischindipur, nella zona rurale del Bengala, Harihar Roy guadagna quasi nulla come sacerdote, ma sogna una carriera migliore come poeta e drammaturgo. La moglie Sarbajaya si prende cura dei loro figli, Durga e Apu, e della zia più anziana di Harihar, Indir Thakrun. Durga ama Indir e di solito le offre i frutti presi dal frutteto di un ricco vicino. Un giorno, la moglie del vicino accusa Durga di aver preso un ciondolo di perline e accusa Sarbajaya per aver sollecitato la sua propensione a rubare. Come sorella maggiore Durga si prende cura di Apu con affetto materno, ma non risparmia le occasioni per prenderlo in giro. Un giorno, corrono in campagna per osservare il treno, ma trovano Indir morta al ritorno a casa. Non essendo in grado di guadagnarsi da vivere nel villaggio, Harihar si reca in città per cercare un lavoro migliore.
Il lamento sul sentiero è un adattamento dell'omonimo romanzo bengalese del 1929 di Bibhutibhushan Bandyopadhyay e segnò anche l'esordio alla regia di Ray. Il lamento sul sentiero è il primo film della trilogia di Apu, e racconta i travagli infantili del personaggio principale Apu e di sua sorella maggiore Durga nel mezzo della dura vita del villaggio con i loro poveri genitori. La produzione ha avuto problemi di finanziamento e ci sono voluti quasi tre anni per completare il film. Lo stile del film è stato influenzato dal neorealismo italiano e dalle opere del regista francese Jean Renoir. Definito da molti critici autorevoli e registi famosi un capolavoro.
LINGUA: bengali
SOTTOTITOLI: italiano
La Grande Illusione (1937)
Jean Renoir realizza, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, il più grande film contro la guerra mai prodotto, paradossalmente senza mostrare quasi mai il campo di battaglia. La Grande Illusione è un film sulle frontiere: quelle visibili delle nazioni e quelle invisibili, ma molto più rigide, delle classi sociali. Il rapporto tra l’aristocratico francese capitano de Boieldieu (Pierre Fresnay) e l’ufficiale tedesco von Rauffenstein (un Erich von Stroheim indimenticabile con il suo busto ortopedico e il monocolo) dimostra che l’affinità di classe e cultura supera l’inimicizia nazionale. Entrambi sanno di essere dinosauri in via di estinzione, rappresentanti di un vecchio ordine europeo che sta per essere spazzato via, rimpiazzato da una nuova Europa borghese e proletaria rappresentata dai personaggi di Maréchal (Jean Gabin) e Rosenthal (Marcel Dalio).
Il titolo stesso è polisemico: l’illusione che la guerra possa risolvere i conflitti, l’illusione che le barriere sociali possano resistere alla storia, o forse l’illusione, diffusa all’epoca, che la guerra del 1914-18 sarebbe stata l’ultima. Renoir utilizza la profondità di campo e lunghi piani sequenza per enfatizzare la connessione spaziale tra i personaggi e il loro ambiente, rifiutando il montaggio frenetico che frammenta l’azione e separa gli individui. È un film profondamente umanista che non demonizza il nemico, ma osserva con malinconia la fine di un’era e l’incertezza di quella successiva. La fuga finale verso la Svizzera, attraverso una distesa di neve dove i confini sono invisibili finché non vengono tracciati dall’uomo, rimane una delle metafore visive più potenti sulla natura arbitraria delle divisioni politiche.
La Regola del Gioco (1939)
Se La Grande Illusione guardava al passato con malinconia, La Regola del Gioco guarda al presente con ferocia satirica. Realizzato proprio mentre l’Europa precipitava nel baratro della Seconda Guerra Mondiale, il film fu inizialmente un fiasco colossale, odiato dal pubblico e dalla critica al punto da essere bandito dal governo francese per essere “demoralizzante”. Renoir orchestra una commedia di costumi in una tenuta di campagna, La Colinière, che si trasforma in una danza macabra. Aristocratici, aviatori eroi e servitori sono intrappolati in un gioco di ruoli, menzogne e tradimenti dove l’unica colpa imperdonabile è la sincerità o la rottura dell’etichetta.
La celebre frase del personaggio di Octave (interpretato dallo stesso Renoir), “La cosa terribile di questo mondo è che ognuno ha le sue ragioni”, è la chiave di volta etica del film. Renoir non giudica i suoi personaggi, li osserva dibattersi nella loro frivolezza mentre il mondo brucia. La sequenza della caccia, dove animali innocenti vengono massacrati per sport in una frenesia di spari che anticipa la guerra imminente, è una delle metafore più potenti della brutalità insita nella civiltà europea dell’epoca. Tecnicamente, l’uso della profondità di campo qui raggiunge vette ineguagliate, permettendo a diverse azioni e registri narrativi (farsa, tragedia, romanticismo) di coesistere nella stessa inquadratura, riflettendo il caos controllato di una società sull’orlo dell’abisso, incapace di distinguere tra il teatro e la vita reale.
Via col Vento (1939)
Un’imponente epopea romantica ambientata sullo sfondo della Guerra Civile Americana e della successiva Ricostruzione. Il film segue la viziata ma indomabile figlia di un proprietario di piantagioni della Georgia, Rossella O’Hara. Attraverso la distruzione di Atlanta, la fame e la perdita della sua casa, Tara, Rossella lotta per la sopravvivenza. La sua ossessione per il flemmatico Ashley Wilkes la acceca al suo tumultuoso e appassionato rapporto con il cinico Rhett Butler.
Sotto la superficie scintillante del melodramma e del Technicolor, Via col Vento è un dramma spietato sulla sopravvivenza. Il motore narrativo del film non è l’amore, ma la terra. Il momento catartico non è un bacio, ma il giuramento di Rossella tra i campi devastati di Tara: “Dio mi è testimone, non soffrirò mai più la fame”.
Rossella O’Hara è una delle più grandi antieroine del cinema. È egoista, manipolatrice, anaffettiva e straordinariamente moderna. Il suo dramma personale è lo scontro tra il suo pragmatismo spietato e il codice d’onore di un mondo (il Vecchio Sud) che sta morendo davanti ai suoi occhi.
Il vero conflitto drammatico non è tra il Nord e il Sud, ma tra Ashley Wilkes, simbolo del passato idealizzato e debole, e Rhett Butler, l’incarnazione del futuro realista e capitalista. La tragedia di Rossella è che lei, pur essendo lei stessa una donna moderna, si aggrappa alla fantasia romantica di Ashley, riconoscendo il suo vero partner, Rhett, solo quando è troppo tardi e lui ha smesso di amarla.
Quarto Potere (1941)
Alla sua morte nella vasta e isolata tenuta di Xanadu, il magnate dell’editoria Charles Foster Kane pronuncia un’unica, enigmatica parola: “Rosebud” (Rosabella). Un giornalista viene incaricato di scoprire il significato di questo termine, indagando sulla vita del magnate. Attraverso interviste ai suoi vecchi soci e alla sua ex moglie, il film compone, tramite flashback frammentati e contraddittori, il puzzle di un’esistenza segnata da ricchezza, potere e una profonda solitudine.
Quarto Potere non è solo un film drammatico; è il film che ha insegnato al dramma cinematografico un nuovo linguaggio. Orson Welles, al suo debutto, ha infranto ogni regola narrativa e tecnica. L’uso innovativo della profondità di campo non è un semplice virtuosismo, ma uno strumento drammatico essenziale: serve a mostrare l’isolamento di Kane, la distanza emotiva tra i personaggi intrappolati nella stessa inquadratura ma separati da abissi psicologici.
Il dramma centrale è un’indagine fallita sull’identità umana. Il film è una meditazione sulla perdita. Kane ottiene il mondo ma perde la sua anima nel momento esatto in cui viene strappato dalla sua infanzia e da quella slitta. Il suo potere e la sua ricchezza sono solo tentativi disperati di compensare quella perdita originaria, di costringere il mondo ad amarlo.
La struttura narrativa frammentata è il vero tema del film. Dimostra che è impossibile conoscere veramente una persona; la nostra vita è solo la somma delle narrazioni, spesso contraddittorie, che gli altri raccontano su di noi. “Rosebud” non è la chiave per capire Kane; è il simbolo di tutto ciò che è andato perduto e che non può essere recuperato. Il cartello finale “NO TRESPASSING” (Vietato l’accesso) è la tesi del film: l’animo umano è, in ultima analisi, inaccessibile.
Il poeta perduto

Dramma, di Fabio Del Greco, Italia, 2024.
Dante Mezzadri vuole rivedere un vecchio amico, soprannominato l'Iguana, che ha perso di vista da molti anni, e che è riuscito a far diventare la loro comune passione giovanile per la poesia in un lavoro, diventando scrittore e poeta famoso. L'uomo fugge dalla sua vita borghese e dalla moglie per vivere senza fissa dimora sul litorale romano, stampa e tenta di vendere le sue raccolte poetiche. La notte dorme in un parco di vecchi carri allegorici di carnevale, dentro carro armato di cartapesta, e attende l'occasione per incontrare il vecchio amico, il quale però non si presenta mai agli appuntamenti nei luoghi che frequentavano da giovani, ora in rovina. I libretti di poesia di Dante non interessano nessuno e per sostentarsi è costretto a "cambiare prodotto": inizia a vendere per conto di giovani spacciatori la famigerata "pillola del cannibale", una nuova droga che va a ruba e che provoca estasi sensoriali e consumistiche. Si rende conto però che questa potente droga è molto pericolosa per chi la assume, entra in conflitto con la sua coscienza etica e butta tutte le pillole in mare. Gli spacciatori però vogliono riscuotere i loro soldi.
Girato nell'arco di 2 anni, il film è una riflessione sulle macerie culturali ed artistiche della società in cui vive il protagonista, in un mondo sempre più meccanizzato, consumista e arido. Dante Mezzadri è l'ennesimo essere umano che ha rinunciato alla sua ispirazione ed alla sua creatività, ma al contrario di molti non è disposto a regalare la propria vita ad un sistema che lo allontana dalla sua vera identità. Il mondo fisico che lo circonda, però, sembra costruito in modo che sembra impossibile fuggire da questa "gabbia invisibile". L'entusiasmo delle persone che incontra si accende solo di fronte all'appagamento sensoriale, alle visioni irreali dell'affermazione personale e del successo, ai "metaversi" che offrono una fuga in una realtà illusoria e distruttiva. La casa del poeta sul litorale, dove si incontrava da giovane con i suoi amici, è solo un cumulo di macerie abbandonate. Che fine hanno fatto tutti quelli che volevano diventare poeti e sono finiti nel diventare qualcos'altro? Esistono forze interiori con cui quella casa può essere "ricostruita"?
LINGUA: italiano
Casablanca (1942)
Nella Casablanca controllata dal regime di Vichy durante la Seconda Guerra Mondiale, l’espatriato americano Rick Blaine gestisce il night club più popolare della città, mantenendo un cinico distacco dalla politica e dai conflitti. Il suo mondo viene sconvolto quando la sua ex amante, Ilsa Lund, riappare con il marito, l’eroe della Resistenza Victor Laszlo. Braccati dai nazisti, hanno disperatamente bisogno dei visti in possesso di Rick per fuggire in America.
Casablanca è la definizione stessa di dramma romantico, un film perfetto nella sua sceneggiatura, che bilancia magistralmente cinismo e idealismo. È un film sulla rinascita morale. Il dramma centrale non è solo il triangolo amoroso, ma la scelta tra la felicità personale e il bene comune. Rick Blaine è l’allegoria dell’America pre-bellica: isolazionista, ferito e determinato a non farsi coinvolgere (“I stick my neck out for nobody“).
L’arrivo di Ilsa lo costringe a fare i conti con il passato e, soprattutto, a scegliere da che parte stare nel presente. Il conflitto non è solo tra Rick e i nazisti, ma tra il Rick che era e il Rick che deve diventare.
Prodotto e distribuito nel pieno della guerra, il film è una parabola universale sul sacrificio. Non è un’opera realistica, è mitologica. Rick che “inventa una narrazione” per convincere Ilsa a salire su quell’aereo con Laszlo (“Forse non oggi, forse non domani, ma presto e per il resto della tua vita te ne pentirai”) è il film stesso che inventa una narrazione per convincere un’intera nazione che, di fronte a un male assoluto, il sacrificio personale non è solo giusto, ma necessario.
Meshes of the Afternoon (1943)
In netto contrasto con le produzioni industriali di Hollywood, Maya Deren e il marito Alexander Hammid realizzano con Meshes of the Afternoon l’opera seminale del cinema d’avanguardia americano e del psicodramma, girata con un budget irrisorio nella loro casa di Los Angeles. Girato in muto (la musica di Teiji Ito fu aggiunta successivamente nel 1959) e in 16mm, il film esplora l’inconscio femminile attraverso una struttura circolare e ripetitiva che sfida ogni logica spaziale e temporale aristotelica. Elementi quotidiani — una chiave, un coltello da pane, un fiore, un telefono staccato — diventano totem carichi di minaccia sessuale e violenta, simboli freudiani di un’alienazione domestica.
Deren non recita una parte nel senso tradizionale, ma performa uno stato mentale, muovendosi attraverso lo spazio con una coreografia onirica. L’uso del montaggio per collegare spazi impossibili (un passo sulla sabbia che diventa un passo sull’erba, poi sul tappeto) anticipa le discontinuità della modernità cinematografica e rompe la geografia filmica convenzionale. La figura incappucciata con uno specchio al posto del volto è una delle immagini più inquietanti e potenti del secolo, simbolo di una morte che riflette il sé o di un’identità frammentata che non può essere afferrata. Il film è un’indagine viscerale sulla natura instabile della percezione soggettiva e sul desiderio femminile represso, ponendo le basi per tutto il cinema sperimentale, femminista e indipendente a venire, dimostrando che il cinema poteva essere uno strumento di indagine interiore profonda e non solo di narrazione esterna.
La Fiamma del Peccato (1944)
Billy Wilder, collaborando con il romanziere hard-boiled Raymond Chandler alla sceneggiatura, porta il noir alla sua perfezione stilistica e tematica con Double Indemnity. Qui non ci sono detective privati o gangster professionisti, ma persone comuni — un assicuratore e una casalinga — corrotte dalla lussuria e dall’avidità nel soleggiato e banale squallore di Los Angeles. Fred MacMurray, attore noto per ruoli leggeri, e Barbara Stanwyck, con la sua parrucca bionda deliberatamente artificiale (“sleazy”), creano una chimica tossica basata non sull’amore, ma sulla complicità criminale. Wilder sfida apertamente il Codice Hays, riuscendo a suggerire un erotismo intenso e morboso pur senza mostrare nulla di esplicito.
Il film è rivoluzionario per come costringe il pubblico a identificarsi con gli assassini, sperando che riescano a farla franca mentre il cerchio si stringe attorno a loro, manipolati dall’investigatore Barton Keyes (Edward G. Robinson). La narrazione in flashback, dettata a un dittafono da un uomo morente, permea ogni scena di un senso di fatalità ineluttabile; sappiamo fin dall’inizio che Walter Neff è condannato. Visivamente, il direttore della fotografia John Seitz utilizza la “venetian blind lighting” (le ombre delle tapparelle) per ingabbiare i personaggi nel loro destino, trasformando le case della borghesia californiana in prigioni morali striate di luce e ombra. Wilder smaschera il marcio sotto la superficie rispettabile dell’America, suggerendo che il crimine non è un’aberrazione, ma una transazione commerciale andata male.
Roma Città Aperta (1945)
Girato mentre le truppe tedesche stavano ancora lasciando l’Italia e utilizzando pellicola scaduta di diversi formati recuperata al mercato nero, il film di Roberto Rossellini è l’atto di nascita del Neorealismo e un documento storico di potenza inaudita. Rossellini porta la cinepresa fuori dagli studi, nelle strade ferite di Roma, mescolando attori professionisti (Anna Magnani, Aldo Fabrizi) con gente comune. Il risultato è un’opera che annulla la distanza tra arte e vita, tra finzione e cronaca, catturando l’atmosfera di paura, fame e speranza della fine della guerra.
La sequenza della corsa e della morte di Pina (Magnani), falciata dai mitra tedeschi mentre rincorre il camion che porta via il suo uomo, è un momento che ha strappato via l’innocenza al cinema mondiale; non c’è rallentatore, non c’è musica enfatica, solo la brutalità secca e improvvisa della violenza reale. Il film unisce la resistenza comunista e quella cattolica in un fronte comune umanista contro l’oppressione nazifascista, simboleggiato dall’alleanza tra l’ingegnere Manfredi e Don Pietro. Nonostante la crudezza delle scene di tortura, c’è una speranza profonda che risiede nella solidarietà e nel sacrificio per le generazioni future. Roma Città Aperta ha insegnato al mondo che si poteva fare cinema con niente, purché si avesse un’urgenza morale da comunicare, influenzando generazioni di registi dal Brasile all’India alla Francia.
Il tempo del raccolto del grano

Dramma, di Yasujirō Ozu, Giappone, 1951.
Noriko, una segretaria di Tokyo, risiede a Kamakura con la sua famiglia insieme ai suoi genitori Shūkichi e Shige, suo fratello maggiore Kōichi, un medico, sua moglie Fumiko e i loro 2 ragazzi Minoru e Isamu. Gli amici di Noriko sono divisi in 2 gruppi, gli sposati ed i single, che si prendono in giro costantemente, con Aya Tamura che è la sua stretta alleata nel gruppo single. La famiglia di Noriko fa pressioni su Noriko affinché accetti il matrimonio proposto da Satake, concordando sul fatto che è tempo per lei di sposarsi e pensando che il matrimonio sia perfetto per qualcuno della sua età. Quando la madre di Yabe, Tami, chiede impulsivamente a Noriko di sposare Yabe e di seguirli nel loro trasferimento di residenza a nord, Noriko accetta la proposta. La famiglia accetta la decisione di Noriko con rassegnazione e, prima che se ne vada, scattano una foto insieme. Splendido dramma sull'unità della famiglia che fa parte della trilogia tematica di Ozu che viene definita La trilogia di Noriko: Tarda primavera, Il tempo del raccolto del grano e Viaggio a Tokyo, tutti con Setsuko Hara nei panni di un personaggio di nome Noriko, sul tema della famiglia sull'orlo di un grande cambiamento.
Spunto di riflessione
L’amore non sospetta mai, non è mai geloso. L’amore non interferisce mai nella libertà dell’altro. L’amore non impone mai nulla all’altro. L’amore dona libertà, e la libertà può esistere solo se esiste spazio. L’amore dovrebbe essere un dono dato e preso in libertà, ma non dovrebbe esistere alcuna pretesa. Se potete avere al tempo stesso la libertà e l’amore, non avrete bisogno più di altro. Avrete ottenuto ogni cosa, tutto ciò per cui si vive vi sarà stato dato.
LINGUA: giapponese
SOTTOTITOLI: italiano, inglese
I Migliori Anni della Nostra Vita (1946)
Mentre l’Europa faceva i conti con le macerie fisiche, l’America doveva affrontare le macerie psicologiche dei reduci. William Wyler realizza un’epopea intima di quasi tre ore sul ritorno a casa di tre veterani: un capitano di mezza età (Fredric March), un ufficiale dell’aeronautica tormentato dagli incubi (Dana Andrews) e un marinaio che ha perso entrambe le mani (Harold Russell). Quest’ultimo ruolo, interpretato dal vero veterano e non-attore Harold Russell, conferisce al film un’autenticità documentaria straziante che nessun effetto speciale avrebbe potuto replicare. Wyler rifiuta il trionfalismo patriottico per mostrare la difficoltà di reinserirsi in una società che vuole dimenticare la guerra e tornare alla normalità del consumismo il più presto possibile.
L’uso della profondità di campo da parte di Gregg Toland (lo stesso direttore della fotografia di Citizen Kane) permette a Wyler di costruire scene complesse dove le reazioni dei personaggi sullo sfondo sono importanti quanto l’azione in primo piano. Un esempio magistrale è la scena nel bar in cui Homer (Russell) suona il piano con i suoi ganci, mentre sullo sfondo Al (March) e Fred (Andrews) hanno una conversazione cruciale; lo spettatore è libero di scegliere dove guardare, aumentando il realismo della scena. Il film affronta temi come il disturbo da stress post-traumatico (allora non diagnosticato), l’alcolismo e la crisi dell’identità maschile in un mondo cambiato. È un ritratto malinconico e maturo di un paese che ha vinto la guerra ma ha perso la sua innocenza.
Ladri di Biciclette (1948)
Vittorio De Sica e lo sceneggiatore Cesare Zavattini portano il Neorealismo alla sua essenza più pura: una storia minima (il furto di una bicicletta) che diventa una tragedia universale. Nell’Italia del dopoguerra, devastata dalla disoccupazione, una bicicletta non è un oggetto di svago, ma l’unico mezzo di sostentamento per l’attacchino Antonio Ricci e la sua famiglia. La ricerca della bicicletta attraverso una Roma indifferente diventa un’odissea urbana che rivela l’inadeguatezza delle istituzioni, della chiesa, dei sindacati e della folla verso il dramma del singolo individuo. Lamberto Maggiorani, un operaio non professionista, presta il volto ad Antonio, incarnando la disperazione di una classe intera.
La presenza del piccolo Bruno, il figlio che osserva il padre durante tutta la ricerca, è il vero cuore morale del film. Attraverso i suoi occhi, vediamo il crollo della figura paterna, dall’eroismo quotidiano all’umiliazione finale. La scena in cui Antonio, spinto dalla disperazione, tenta a sua volta di rubare una bicicletta e viene colto sul fatto e quasi linciato dalla folla, è devastante perché mostra come la povertà estrema possa corrodere l’integrità morale di chiunque. Il finale, con la mano del bambino che stringe quella del padre in mezzo alla folla mentre entrambi piangono, non offre soluzioni economiche o politiche, ma riafferma la necessità del legame umano e della pietà come unico rifugio contro un mondo ostile.
Il Terzo Uomo (1949)
Carol Reed, in collaborazione con Orson Welles (che qui recita ma la cui presenza influenza pesantemente lo stile) e lo scrittore Graham Greene, crea un noir britannico ambientato in una Vienna spettrale, divisa in quattro zone di occupazione e ridotta in macerie dai bombardamenti. La città è un labirinto di ombre espressioniste, angoli olandesi (inquadrature inclinate) e strade bagnate, riflettendo il totale disorientamento morale del dopoguerra e l’inizio della Guerra Fredda. La celebre colonna sonora di cetra di Anton Karas, allegra e nevrotica allo stesso tempo, crea un contrasto ironico e straniante con la cupezza della trama e i crimini orribili che vengono svelati.
Il personaggio di Harry Lime (Welles) è l’incarnazione del male carismatico del XX secolo: un uomo che giustifica la vendita di penicillina diluita (che uccide o rende invalidi i bambini) con una logica nichilista che riduce le persone a “puntini” insignificanti visti dall’alto di una ruota panoramica. Il famoso monologo improvvisato da Welles sull’orologio a cucù svizzero e il Rinascimento italiano è una cinica apologia dell’egoismo creativo e del caos come motore della storia. Il finale nelle fogne di Vienna è una discesa negli inferi letterali e metaforici, e la lunghissima camminata finale di Anna (Alida Valli), che ignora il protagonista Holly Martins, è uno dei rifiuti più eleganti e definitivi della storia del cinema, sigillando il film in un pessimismo romantico senza redenzione.
Tarda Primavera (1949)
. Primo della cosiddetta “Trilogia di Noriko” (con Inizio d’estate e Viaggio a Tokyo), il film racconta una storia scarna: una figlia devota (Setsuko Hara, musa di Ozu) non vuole sposarsi per non lasciare solo il padre vedovo (Chishū Ryū), il quale deve fingere di volersi risposare per spingerla a crearsi una vita propria. Ozu utilizza qui il suo stile trascendentale pienamente formato: la “tatami shot” (cinepresa bassa, all’altezza di una persona seduta), la rottura della regola dei 180 gradi nel campo-controcampo, e i “pillow shots” (inquadrature di paesaggi o oggetti statici come un vaso) per creare un ritmo contemplativo che invita lo spettatore a riflettere sulla transitorietà delle cose (mono no aware).
Il dramma qui non è fatto di urla o conflitti aperti, ma di sorrisi che nascondono il dolore e di silenzi carichi di significato. Ozu documenta con delicatezza straziante il passaggio del Giappone da un’etica collettivista a una più individualista. La scena in cui il padre sbuccia una mela alla fine del film, dopo che la figlia se n’è andata in viaggio di nozze, e la sua testa cade per un attimo in avanti per la stanchezza e la solitudine, è un vertice di pathos minimalista. La sua solitudine è accettata come parte naturale e inevitabile del ciclo della vita, non come una tragedia da combattere, ma come un destino da accogliere.
I musici di Gion

Drammatico, di di Kenji Mizoguchi, Giappone, 1953.
La storia si svolge a Kyoto e segue Eiko, una giovane che vuole diventare geisha e chiede alla più anziana Miyoharu di insegnarle il mestiere. Uno dei suoi primi clienti cerca di violentarla ma Eiko si difende con violenza e lo manda all'ospedale. Dopo che anche Miyoharu rifiuta un cliente, le due donne sono bandite dal quartiere di Gion; tuttavia Miyoharu accetterà di sacrificarsi per preservare il futuro della sua giovane amica.
Remake di uno dei primi film di successo di Mizoguchi del 1936. Uno degli ultimi film di Mizoguchi e uno dei più riusciti sulla condizione delle geisha, spesso vittime di esistenze drammatiche. E' anche un racconto di grande solidarietà femminile: mentre la giovane Eiko si ribella, la più anziana Miyoharu si è ormai rassegnata alla sua condizione. È una vicenda drammatica, scandita da tempi dilatati e lunghi piani-sequenza e con una macchina da presa che resta lontana e distaccata dai personaggi: il risultato è commuovente, rigoroso dal punto di vista estetico, recitato in modo straordinario. Probabilmente uno dei migliori mai realizzati sul tema dell'amicizia femminile.
LINGUA: giapponese
SOTTOTITOLI: italiano
Film drammatici anni ’50
I film drammatici degli anni ’50 riflettono un’epoca di profonde trasformazioni sociali, tensioni postbelliche e nuove sensibilità emotive. In questo decennio il dramma cinematografico si fece più maturo, più introspettivo, spesso segnato da personaggi tormentati e storie che scavano nelle fragilità dell’animo umano.
Viale del tramonto (1950)
Il film è narrato da Joe Gillis, uno sceneggiatore squattrinato che troviamo morto, a faccia in giù in una piscina, all’inizio del film. Gillis racconta in flashback come, fuggendo dai creditori, sia finito per caso nella villa fatiscente di Norma Desmond, una diva dimenticata dell’era del cinema muto. Lei lo assume per scrivere la sceneggiatura del suo grande “ritorno”, trascinandolo in un rapporto tossico fatto di illusioni, follia e tragedia.
Viale del tramonto è il più grande e spietato dramma meta-cinematografico mai realizzato. È Hollywood che punta la telecamera su sé stessa e racconta la propria crudeltà, il modo in cui crea miti e poi li divora.
È un dramma gotico. La villa di Norma è una tomba; lei è un fantasma del passato del cinema che cerca di vampirizzare il presente (incarnato da Joe, lo sceneggiatore). L’uso geniale di Billy Wilder di vere icone del muto (Gloria Swanson, Erich von Stroheim, Buster Keaton che interpreta sé stesso) rende il dramma ancora più potente e veritiero.
Il film è un noir fatalista. La narrazione di un uomo morto ci dice fin dall’inizio che non c’è speranza. Il dramma non è “cosa succederà?”, ma “come siamo arrivati a questo punto inevitabile?”. La discesa di Norma nella follia culmina nella sua battuta finale, mentre scende lo scalone verso la polizia e le telecamere: “Sono pronta per il mio primo piano”. È il momento in cui l’illusione del cinema diventa, tragicamente, la sua unica realtà.
Viaggio a Tokyo (1953)
Yasujirō Ozu riprende i temi di Make Way for Tomorrow e li sublima in un’opera di purezza cristallina, spesso votata dai registi come il miglior film di tutti i tempi. Una coppia di anziani genitori viaggia dalla provincia per visitare i figli a Tokyo, solo per scoprire di essere diventati un fastidio nelle loro vite frenetiche e moderne. I figli li spediscono in una spa economica per liberarsene; solo la nuora vedova, Noriko (Setsuko Hara), mostra loro gentilezza e devozione vera. Ozu non demonizza i figli; mostra semplicemente come il tempo, il lavoro e la distanza sociale erodano inevitabilmente i legami affettivi. La delusione è la condizione umana predefinita nel cinema di Ozu.
Lo stile è rigoroso, quasi matematico, ma l’effetto emotivo è devastante. Ozu ci costringe a guardare il passare del tempo attraverso dettagli apparentemente banali e inquadrature fisse. Il tema dei treni e dei viaggi sottolinea la distanza fisica ed emotiva che separa le generazioni nel Giappone del dopoguerra. La morte della madre non è mostrata come un evento melodrammatico, ma come un fatto che lascia un vuoto silenzioso. Il film è una meditazione sull’impermanenza e sull’accettazione della solitudine finale. .
Salt of the Earth (1954)
Questo film occupa un posto unico e controverso nella storia del cinema americano: è l’unica pellicola statunitense ufficialmente inserita nella lista nera durante il periodo del Maccartismo. Realizzato da un team di artisti banditi da Hollywood perché sospettati di comunismo — il regista Herbert J. Biberman (uno dei “Hollywood Ten”), lo sceneggiatore Michael Wilson e il produttore Paul Jarrico — il film racconta lo sciopero reale dei minatori di zinco messicano-americani dell’Empire Zinc Company nel New Mexico. La produzione fu ostacolata in ogni modo: vigilantes spararono sul set, l’attrice protagonista messicana Rosaura Revueltas fu deportata prima della fine delle riprese, e i laboratori si rifiutarono di sviluppare la pellicola.
Ciò che rende Salt of the Earth rivoluzionario, oltre alla sua audace politica sindacale e antirazzista, è il suo femminismo radicale. Quando un’ingiunzione del tribunale (la legge Taft-Hartley) proibisce agli uomini di picchettare, sono le mogli a prendere il loro posto sulla linea del fronte, affrontando la polizia e gli sceriffi. Questo costringe i mariti a rimanere a casa a badare ai figli e alle faccende domestiche, portando a una dolorosa ma necessaria presa di coscienza maschile sulla doppia oppressione (di classe e di genere) subita dalle donne. Utilizzando veri minatori come attori accanto a pochi professionisti, l’opera è un esempio potente di neorealismo americano, un monumento alla dignità operaia e alla solidarietà intersezionale che ha anticipato di decenni le lotte per i diritti civili.
Lady Cobra - Una killer in blues

Drama, di Fabio Giovinazzo, Italia, 2025.
Una donna, veterana di guerra, alterna il lavoro di fioraia a quello di killer a pagamento. Vestita di rosa, riceve i suoi clienti in un cimitero e guida una potente Cobra degli anni ’60, la leggendaria spider 427. Considerata la migliore, è conosciuta nell’ambiente oscuro con il nome di Lady Cobra e porta sempre a termine ogni incarico con la sua infallibile Smith & Wesson. Psicodramma intimo che abbraccia un forte senso di alienazione, è il ritratto enigmatico di una donna che cade senza fiato nell’abisso della solitudine, oscillando definitivamente sul confine della sanità mentale.
Biografia del regista – Fabio Giovinazzo
Fabio Giovinazzo è un artista italiano, regista e autore. Lavora su progetti complessi e insoliti. Le sue parole chiave sono ispirazione e lirismo, immagini vivide, pragmatismo onirico, nomadismo culturale, trasgressione intelligente. Documenta persone e vite marginali, forme di narrazione eretiche e paradossi creativi.
LINGUA: italiano
SOTTOTITOLI: inglese
I Sette Samurai (1954)
Akira Kurosawa inventa il moderno film d’azione non come semplice spettacolo cinetico, ma come profondo dramma umanista e studio sociologico. La trama è archetipica e diverrà la base per innumerevoli remake (incluso I Magnifici Sette): un villaggio di contadini poveri, minacciato dai banditi che rubano il raccolto, assolda sette samurai senza padrone (ronin) per difendersi. Kurosawa usa questa premessa per esplorare le dinamiche di classe (la diffidenza tra guerrieri e contadini), il sacrificio, e la natura dell’eroismo in un’epoca di caos sociale (il periodo Sengoku). Ogni samurai è caratterizzato con precisione, rappresentando diverse sfaccettature dell’ethos guerriero, dal saggio leader Kambei al giovane discepolo, fino al contadino che finge di essere samurai, Kikuchiyo (Toshiro Mifune), che funge da ponte tra le due classi.
Visivamente, Kurosawa rivoluziona il cinema con l’uso di teleobiettivi che schiacciano la prospettiva portando lo spettatore dentro l’azione, l’uso di più macchine da presa simultanee per non perdere la spontaneità, e un montaggio frenetico che immerge nel caos della battaglia. La pioggia e il fango non sono solo elementi atmosferici, ma ostacoli fisici, tattili, che rendono lo scontro brutale e realistico. Il finale è amarissimo e anti-retorico: i samurai vincono la battaglia ma perdono la guerra sociale. “Ancora una volta siamo sopravvissuti,” dice Kambei, “E ancora una volta abbiamo perso. I vincitori sono loro, i contadini, non noi.” I guerrieri sono destinati a scomparire, utili solo in tempi di crisi, mentre la vita ciclica della terra continua.
Fronte del Porto (1954)
Elia Kazan realizza un film di potenza viscerale che è, al contempo, un capolavoro del “Method Acting” e una controversa allegoria politica personale. Marlon Brando, nel ruolo dello scaricatore di porto ed ex pugile Terry Malloy, ridefinisce la recitazione cinematografica: la sua performance è fatta di mormorii, esitazioni, tic fisici e improvvisazioni (come la celebre scena del guanto con Eva Marie Saint) che portano una naturalezza psicologica e una vulnerabilità mai vista prima sullo schermo. Il film affronta la corruzione sindacale nelle banchine di New York e Hoboken, dipingendo un mondo dove la legge del silenzio (omertà) regna sovrana.
Tuttavia, è impossibile ignorare il sottotesto politico: Kazan, che aveva testimoniato davanti alla HUAC (Comitato per le attività antiamericane) nominando colleghi comunisti, usa la storia di Terry (che sceglie di testimoniare contro i boss mafiosi corrotti) per giustificare la propria scelta come un atto di coraggio morale contro il conformismo del gruppo. Indipendentemente dalla lettura politica divisiva, la regia di Kazan è magistrale, immergendo i personaggi in un ambiente urbano freddo e ostile, magnificamente fotografato da Boris Kaufman. La “coscienza” diventa il campo di battaglia centrale. La frase iconica di Brando, “Avrei potuto essere qualcuno, invece di un fallito, quale sono” (“I coulda been a contender”), è diventata l’epitaffio universale di ogni sogno infranto e del potenziale sprecato.
Pather Panchali (1955)
L’esordio di Satyajit Ray mette l’India sulla mappa del cinema d’autore mondiale, allontanandosi radicalmente dai musical e dai melodrammi di Bollywood per abbracciare un realismo lirico ispirato a De Sica e Renoir. Primo capitolo della “Trilogia di Apu”, il film racconta l’infanzia del piccolo Apu in un villaggio povero del Bengala. La povertà è onnipresente e tangibile, ma Ray non la spettacolarizza né la usa per pietismo; la mostra come il tessuto stesso della vita quotidiana, intrecciata indissolubilmente con la meraviglia della scoperta naturale, i giochi dei bambini e le piccole gioie.
La colonna sonora di Ravi Shankar (sitar) e la fotografia in bianco e nero di Subrata Mitra creano un’atmosfera ipnotica e contemplativa. La celebre scena in cui Apu e sua sorella Durga corrono attraverso un campo di kash (erba alta bianca) per vedere passare un treno lontano è una delle metafore più potenti del cinema: il treno rappresenta la modernità, la distanza, un mondo promesso e irraggiungibile che taglia attraverso la stasi rurale, lasciando dietro di sé solo fumo. La morte della sorella Durga sotto la pioggia monsonica è trattata con una crudezza straziante che evita il melodramma per concentrarsi sul dolore muto della famiglia. Pather Panchali è un film sensoriale: si sente quasi l’odore della terra bagnata e il ronzio degli insetti, celebrando la resilienza dello spirito umano attraverso la bellezza estetica del dolore.
Il Settimo Sigillo (1957)
Ingmar Bergman cristallizza le ansie dell’era atomica in un’allegoria medievale visivamente sbalorditiva. Un cavaliere, Antonius Block (Max von Sydow), torna dalle Crociate in una Svezia devastata dalla peste e, incontrando la Morte sulla spiaggia, la sfida a una partita a scacchi per guadagnare tempo e trovare un senso all’esistenza o una prova di Dio prima di morire. Il film è un’indagine filosofica sul “silenzio di Dio”: perché Dio non risponde di fronte alla sofferenza umana e all’orrore? La peste è un chiaro parallelo con la minaccia della bomba nucleare che incombeva sugli anni Cinquanta, una forza distruttrice invisibile, arbitraria e inevitabile.
Nonostante la gravità dei temi teologici ed esistenziali, il film è ricco di un umorismo macabro e di un’umanità calda, rappresentata soprattutto dalla famiglia di attori girovaghi (Jof e Mia) che riesce a sopravvivere, simboleggiando l’arte, l’innocenza e l’amore semplice come uniche forze capaci di sfuggire, almeno temporaneamente, alla fine. L’iconografia del film — la Morte con il volto bianco e il mantello nero, la partita a scacchi, la danza macabra finale sulla collina in controluce — è entrata nell’immaginario collettivo globale, parodiata e citata infinite volte. Bergman usa il cinema per porre domande che non hanno risposta razionale, trasformando l’angoscia metafisica in immagini di bellezza austera e indimenticabile.
La signora Oyû

Dramma, di Kenji Mizoguchi, Giappone, 1951.
Lo scapolo Shinnosuke si innamora di Miss Oyu, accompagnatrice di sua sorella minore Shizu che gli fa visita come futura sposa. Il tabù familiare impedisce a Shinnosuke di sposare Oyu. Sposa Shizu senza consumare il loro matrimonio in modo che Shinnosuke possa rimanere fedele all'inconsapevole Oyu. L'l'impegno della coppia per le apparenze ha però un costo. La mancanza di sessualità e le dicerie malevoli sul ménage-a-trois porta a recriminazioni, separazione e ulteriore dolore. La signora Oyu è una radicale rielaborazione di Mizoguchi e del suo sceneggiatore Yoshikata Yoda della novella di Junichiro Tanizaki The Reed Cutter (1932). E' un film si muove nell'aura dell'alta arte e del buon gusto: titoli di testa con dipinti di nubi, composizioni di capolavori dell'arte cinese e giapponese, interni decorati con raffinati arredi e oggetti d'arte, recital di musica classica giapponese e canzoni derivate dalla poesia giapponese, riferimenti al costume, alla storia e alla letteratura Heian, bellezze storiche e naturali; rituali giapponesi come ikebana, bonsai e cerimonie del tè. Una grande rappresentazione di cultura giapponese esotica e pittoresca, La signora Oyu è stato il primo dei drammi in costume degli anni '50 che avrebbe fatto diventare famoso Mizoguchi fuori dal Giappone.
LINGUA: giapponese
SOTTOTITOLI: italiano, inglese
La parola ai giurati (1957)
In un’afosa giornata estiva, dodici giurati si ritirano in una stanza chiusa per deliberare sul caso di un giovane ragazzo di un quartiere povero, accusato di aver ucciso il padre. Il verdetto sembra scontato e la condanna a morte certa. Undici uomini votano “colpevole”. Solo uno, il Giurato 8, vota “non colpevole”, chiedendo semplicemente di “parlare”, innescando un teso dramma che smonta le prove e, soprattutto, svela i pregiudizi personali di ciascun uomo.
Il capolavoro di Sidney Lumet è un dramma processuale unico, che non si svolge in un’aula di tribunale ma interamente in una stanza. Il protagonista del film non è un avvocato, ma il dubbio ragionevole.
L’antagonista non è un singolo uomo, ma il pregiudizio stesso. Il film è un drammatico smascheramento dei pregiudizi sociali, economici e razziali che guidano le decisioni degli uomini. La regia di Lumet è magistrale: la stanza si restringe e il caldo diventa soffocante man mano che la tensione sale, trasformando l’ambiente in una pentola a pressione che fa emergere le vere motivazioni dei giurati.
Questo film non è un dramma su chi “ha ragione”, ma sull’importanza del processo razionale. È una difesa dell’Illuminismo. Il film non prova che il ragazzo è innocente; prova solo che l’accusa non ha superato il ragionevole dubbio. È la vittoria del metodo socratico (il Giurato 8 che fa domande) sull’impulso emotivo, un dramma ottimista che crede ancora che la ragione, se usata correttamente, possa salvare una vita.
La Donna che Visse Due Volte (1958)
Vertigo di Alfred Hitchcock è, sotto la superficie lucida di un thriller in Technicolor, un’esplorazione perversa, tragica e profondamente personale dell’ossessione maschile e della natura illusoria del cinema stesso. James Stewart interpreta Scottie Ferguson, un ex detective che soffre di acrofobia, incaricato di pedinare la misteriosa Madeleine (Kim Novak). Quando lei muore (apparentemente), Scottie incontra Judy, una donna che le somiglia, e inizia a trasformarla ossessivamente nell’immagine della morta, cambiandole vestiti, capelli e trucco. È un film necrofilo, dove l’amore è possibile solo con un fantasma o con una proiezione mentale, mai con una donna reale.
Hitchcock inventa qui lo “zolly” (zoom in avanti e carrello all’indietro simultanei) per visualizzare la vertigine, che nel film è sia una condizione fisica che psicologica: la vertigine di cadere nell’abisso del desiderio irrazionale e della perdita di sé. L’uso del colore è fondamentale: il verde spettrale del neon che illumina Judy la trasforma in una figura spettrale, mentre il rosso segnala il pericolo e la passione. La colonna sonora wagneriana di Bernard Herrmann, circolare e irrisolta, crea un’atmosfera onirica e sospesa. Il film, inizialmente non compreso e considerato un passo falso, è ora considerato uno dei vertici assoluti dell’arte cinematografica (spesso al primo posto nelle classifiche della critica) per come decostruisce il meccanismo della visione, del controllo maschile e della costruzione dell’identità: Scottie è il regista che vuole plasmare la realtà, ma finisce distrutto dalla sua stessa creazione.
Ombre (1959)
John Cassavetes rompe violentemente con tutte le convenzioni narrative, tecniche e produttive di Hollywood con Shadows, un film che segna la nascita ufficiale del cinema indipendente americano moderno. Girato con un budget inesistente, in 16mm, per le strade di una New York jazz e notturna, il film esplora le vite di tre fratelli afroamericani (di cui due, Ben e Lelia, hanno la pelle abbastanza chiara da poter passare per bianchi) nella Beat Generation. Sebbene il film termini con la dicitura “Il film che avete appena visto è stato un’improvvisazione”, la realtà è più complessa: frutto di anni di workshop di recitazione, è una scrittura che simula l’improvvisazione per catturare una verità emotiva grezza che il cinema commerciale aveva perso.
Cassavetes rifiuta la trama strutturata con inizio, centro e fine per concentrarsi sui momenti di incertezza, imbarazzo, noia e connessione mancata. La cinepresa a mano è nervosa, sempre addosso ai volti degli attori, catturando l’energia e la confusione della gioventù senza filtri. Il tema razziale è trattato con una sottigliezza inaudita per l’epoca: non ci sono grandi discorsi sui diritti civili, ma micro-aggressioni e crisi di identità dolorose (come la scena straziante in cui il fidanzato bianco di Lelia scopre che lei è nera incontrando suo fratello dalla pelle scura). La colonna sonora di Charles Mingus sottolinea il ritmo sincopato di un film che cerca di afferrare la vita mentre accade, imperfetta e vibrante, aprendo la strada a registi come Scorsese e Jarmusch.
I 400 Colpi (1959)
Se Shadows apre la strada all’indie americano, I 400 Colpi di François Truffaut fa esplodere la Nouvelle Vague francese, cambiando per sempre il linguaggio del cinema europeo. Truffaut, ex critico feroce dei “Cahiers du Cinéma”, passa dietro la macchina da presa per raccontare la propria infanzia difficile attraverso l’alter ego Antoine Doinel (un giovanissimo Jean-Pierre Léaud). Il film è un atto di ribellione contro il “cinéma de papa”, il cinema di qualità francese, ingessato, letterario e girato in studio. Truffaut porta la cinepresa ad altezza di bambino, senza sentimentalismo, mostrando l’incomprensione sistematica e l’ipocrisia del mondo adulto (genitori, insegnanti, legge) verso l’adolescenza.
La vitalità del film risiede nella sua libertà stilistica assoluta: riprese in esterni a Parigi (la città è co-protagonista), dialoghi naturali, ellissi narrative e un senso di movimento continuo. La famosa scena del colloquio con la psicologa, improvvisata da Léaud, offre una verità documentaria rara. La corsa finale di Antoine verso il mare, un lungo piano sequenza che culmina in uno dei primi e più famosi “fermo immagine” (freeze-frame) della storia, rompe la quarta parete: lo sguardo di Antoine in macchina interpella direttamente lo spettatore, lasciando il suo futuro in sospeso e interrogandoci sulla nostra responsabilità. Non è solo la storia di un ragazzo difficile, è la dichiarazione di indipendenza di un nuovo modo di fare cinema, personale, urgente e libero dalle regole accademiche.
La stagione del sole

Drammatico, di Ko Nakahira, Giappone, 1959.
La dolce vita dei ricchi giovani giapponesi della sottocultura Sun Tribe che si ispirava allo stile di vita occidentale alla fine degli anni '50, tra lussuria e violenza, sci d'acqua e motoscafi. Una storia di amore, passione e tradimento. Due fratelli si innamorano della stessa ragazza, che però nasconde la sua vera vita. La passione morbosa per la ragazza diventa ingestibile e il conflitto tra i due fratelli sempre più drammatico. Capolavoro quasi sconosciuto in Occidente, fece scandalo all'epoca della sua uscita. E' il film che apre la strada e ispira la Nouvelle Vague giapponese. Il regista Ko Nakahira non sopportava il modello di produzione industriale della Nikkatsu e iniziò ad abusare di alcool. Alla fine, ha dovuto espatriare in Cina e utilizzare uno pseudonimo per realizzare i suoi film successivi.
Spunto di riflessione
Ogni volta che provi attrazione sessuale verso qualcuno, può nascere la gelosia perché non sei innamorato. Se sei davvero innamorato, la gelosia non compare mai. Hai paura perché il sesso non è in realtà una vera relazione, hai paura che l'altra persona possa andare da qualcun altro. Questa paura diventa gelosia. Se c'è una relazione autentica è impossibile trovare quella ricchezza da qualche altra parte.
LINGUA: giapponese
SOTTOTITOLI: italiano
Film drammatici anni ’60
I film drammatici degli anni ’60 incarnano un decennio di rivoluzioni culturali, sperimentazioni artistiche e nuove libertà espressive. In questi anni il dramma si fece più audace, più psicologico, più disposto a sfidare tabù e convenzioni narrative. Registi visionari portarono sullo schermo storie intense e spesso scomode, capaci di riflettere le inquietudini di un mondo in cambiamento.
Lawrence d’Arabia (1962)
L’epopea biografica dell’enigmatico ufficiale britannico T.E. Lawrence. Durante la Prima Guerra Mondiale, Lawrence viene inviato nel deserto arabo dove, contro gli ordini dei suoi superiori, unisce le tribù beduine in una guerriglia contro i turchi. La sua impresa lo trasforma in un eroe leggendario, ma il suo trionfo è segnato dal conflitto tra la sua identità britannica e la sua adozione della cultura araba, e dalla sua stessa, pericolosa megalomania.
David Lean ha diretto il più grande dramma psicologico mai mascherato da film epico. L’immensità del deserto non è uno sfondo; è un personaggio, uno specchio psicologico vuoto e assoluto che costringe Lawrence a confrontarsi con la domanda “Chi sei tu?”.
Il cuore del dramma è il tentativo di Lawrence di “scrivere” il proprio destino, come dice al suo alleato arabo: “Niente è scritto”. È un film sull’autocreazione, sulla costruzione del proprio mito, e sulla tragedia di diventare prigionieri di quel mito.
È un dramma sull’idealismo corrotto. Lawrence crede sinceramente di “dare la libertà” agli arabi, ma alla fine è solo una pedina inconsapevole nel gioco imperialista. Il famoso match-cut – il fiammifero che Lawrence spegne con le dita che si trasforma nel sole accecante del deserto – è la tesi drammatica del film. È l’ambizione di un uomo di trasformare la sua piccola volontà (il fiammifero) in un destino assoluto (il sole). Finirà bruciato e consumato dal deserto e dalla guerra che lui stesso ha scatenato.
Film drammatici anni ’70
I film drammatici degli anni ’70 rappresentano uno dei momenti più fertili e rivoluzionari della storia del cinema. Fu un decennio segnato da un realismo più duro, da nuove libertà creative e da autori pronti a sfidare convenzioni estetiche e sociali. Il dramma si fece più cupo, più politico, più intimo.
Wanda (1970)
Wanda di Barbara Loden si erge come un monumento unico alla marginalità e alla passività femminile. Girato in 16mm con uno stile influenzato dal cinéma vérité, il film segue Wanda, una casalinga della classe operaia della Pennsylvania, che abbandona la sua famiglia per un profondo senso di inadeguatezza e si ritrova alla deriva, legandosi a un piccolo criminale. Loden, che scrisse, diresse e interpretò il film, rifiuta la nobilitazione femminista o la catarsi narrativa, mostrando una vita ai margini squallida e priva di glamour.
A differenza di altre narrazioni sulla criminalità giovanile, Wanda non romanticizza l’atto ribelle, ma espone la vulnerabilità e la mancanza di direzione della sua protagonista in una società che offre poche vie di fuga alle donne. La scelta estetica di un realismo così crudo e documentaristico fu un atto di resistenza contro il cinema patinato di Hollywood, anticipando temi e tecniche che avrebbero influenzato decenni di cinema indipendente americano. La sua battuta, “Sono solo una brava a nulla,” incapsula l’alienazione di un’epoca.
L'uomo dal braccio d'oro

Film drammatico, noir, di Otto Preminger, Stati Uniti, 1955.
Frankie Machine (Frank Sinatra), un ex tossicodipendente che cerca di rimettersi in sesto dopo essere uscito di prigione. Tuttavia, Frankie è un bravissimo suonatore di batteria e viene continuamente tentato a riprendere l'abitudine della droga per poter suonare ancora meglio. La sua vita viene ulteriormente complicata dalle pressioni della moglie Zosch (Eleanor Parker), che cerca di trattenere Frankie nel loro giro criminale, e della sua vecchia fiamma Molly (Kim Novak), che cerca di aiutarlo a eliminare la dipendenza dall'eroina ed a cambiare vita suonando la batteria in una band.
Il film è stato molto acclamato dalla critica per la performance di Sinatra, che gli è valsa una nomination all'Oscar come miglior attore protagonista. Inoltre, la colonna sonora di Elmer Bernstein, che presenta un tema principale triste e malinconico, è considerata una delle migliori della storia del cinema. Il film è anche noto per essere stato uno dei primi film di Hollywood ad affrontare senza filtri il tema della tossicodipendenza, con una forte critica alla società che crea le condizioni per la dipendenza dalle droghe. Preminger ha dovuto lottare con la censura per far approvare il film, a causa degli argomenti considerati tabù negli anni '50. Sinatra ha lavorato duramente per prepararsi al ruolo di Frankie, imparando a suonare il tamburo e la batteria e studiando il comportamento dei tossicodipendenti. La Novak e la Parker, entrambe all'apice della loro carriera, hanno fornito performance indimenticabili. Il film guadagnò oltre 4 milioni di dollari dell'epoca al botteghino. Oggi è considerato uno dei capolavori di Preminger e uno dei migliori film di Sinatra.
LINGUA: inglese
SOTTOTITOLI: italiano
Il Conformista (1970)
Bernardo Bertolucci, influenzando profondamente la nascente New Hollywood, racconta la storia di Marcello Clerici, un uomo che aderisce fanaticamente al fascismo nell’Italia degli anni ’30 per disperato bisogno di “normalità” e per sopprimere un trauma infantile. Marcello si ritrova coinvolto nell’assassinio del suo ex professore, un dissidente politico, nel tentativo di conformarsi al regime.
La grandezza del film risiede nella fotografia di Vittorio Storaro e nelle scenografie che creano “gabbie visive” e un senso di claustrofobia psicologica intorno al protagonista. L’uso squisito e simbolico del colore – ad esempio, il rosso che rappresenta l’imprigionamento e il blu per Parigi – e le composizioni Art Déco non sono solo estetici, ma riflettono la frammentazione della psiche di Clerici. Il Conformista è un dramma politico che trasforma l’ideologia in patologia individuale, esplorando la connessione tra la repressione sessuale e l’autoritarismo.
L’Ultimo Spettacolo (1971)
L’Ultimo Spettacolo (The Last Picture Show) di Peter Bogdanovich cattura la malinconia e la stasi della vita in una piccola città del Texas, Anarene, all’inizio degli anni ’50. Il film segue un gruppo di adolescenti mentre affrontano l’amore, il sesso, l’amicizia e la crescente disintegrazione della loro comunità.
Girato in uno splendido bianco e nero che evoca il cinema classico e la fotografia documentaristica, il film è un’elegia per l’innocenza perduta e per la fine di un’era. La chiusura del cinema locale (l’ultimo spettacolo, appunto) funge da potente metafora per la morte della cultura e dell’immaginazione in un’America rurale che si sta svuotando. La disperazione e la mancanza di prospettive dei personaggi riflettono la disillusione che avrebbe caratterizzato la New Hollywood, anche se il film è ambientato due decenni prima.
Il Padrino (1972)
Nell’America del dopoguerra, Vito Corleone, patriarca di una potente famiglia criminale italo-americana, supervisiona il suo impero con un codice d’onore. Quando un attentato alla sua vita lo mette fuori gioco, il figlio più giovane, Michael, un eroe di guerra che voleva una vita legittima, viene inesorabilmente trascinato negli affari di famiglia. La sua tragica trasformazione in un boss spietato segna il destino della dinastia.
Molto più di un film di gangster, l’opera di Francis Ford Coppola è una tragedia shakespeariana sulla corruzione del Sogno Americano. Il dramma centrale non è la violenza, ma la discesa di Michael Corleone. Il suo tentativo iniziale di prendere le distanze (“Questa è la mia famiglia, Kay. Non sono io”) si scontra con l’inevitabilità del destino.
L’intero film è costruito sulla tensione tra due concetti inconciliabili che i personaggi tentano disperatamente di separare: famiglia e affari. La frase cardine di Michael, “Non è personale, sono solo affari”, è la più grande menzogna del film e il meccanismo di autoinganno che gli permette di perdere la propria anima.
La mafia non è presentata come un’antitesi all’America, ma come la sua più oscura metafora capitalistica. La vera tragedia non è che Michael diventi un criminale, ma che, nel tentativo di salvare la sua famiglia con la logica spietata degli affari, finisca per distruggerla emotivamente e moralmente. L’iconica inquadratura finale, con la porta che si chiude e separa Michael da Kay, è la chiusura fisica di un patto col diavolo che si è consumato.
Aguirre, furore di Dio (1972)
Werner Herzog, con una produzione leggendariamente caotica e girato nella giungla peruviana, realizza un dramma storico-filosofico sul delirio di onnipotenza. Il film segue Lope de Aguirre (Klaus Kinski), un conquistador spagnolo che guida un’infausta spedizione attraverso il Rio delle Amazzoni alla ricerca del mitico El Dorado.
L’ossessione di Aguirre per la conquista e la sua lenta discesa nella follia incarnano l’hubris coloniale e il conflitto titanico tra l’uomo e la natura indifferente. Il film è un’esperienza cinematografica estrema che rende palpabile l’entropia della giungla, culminando con Aguirre solo su una zattera invasa dalle scimmie. Aguirre, furore di Dio è un’opera di un autore radicale che usa il paesaggio e la storia per indagare il cuore di tenebra dell’ambizione umana.
Mancanza - Inferno

Film drammatico, di Stefano Odoardi, Italia, 2014.
Un Angelo, ispirato alle Elegie Duinesi di R.M.Rilke, vaga attraverso le rovine di un Inferno contemporaneo, in una città silenziosa e abbandonata, nella quale è imprigionato un gruppo di dannati (20 abitanti dell’Aquila). Ognuno di loro condividerà i propri pensieri e le proprie disperazioni che, da frustrazioni individuali, diverranno universali. ‘Mancanza-Inferno’ è un viaggio struggente e metaforico che catapulta lo spettatore in una realtà che rimane sempre attuale: quella di un'umanità che sopravvive sulle macerie di eventi distruttivi.
Stefano Odoardi torna a parlare in maniera fortemente allegorica di argomenti tanto delicati quanto profondi; questa volta la sua attenzione va a focalizzarsi sulla tragedia che nel 2009 ha colpito la sua regione, ossia il terremoto dell’Aquila. In ‘Mancanza-Inferno’ tuttavia la catastrofe non viene raccontata ma solamente ripresa per quello che ha lasciato alle spalle, sui luoghi e sulle persone, il tutto con uno stile brillante, deciso e del tutto personale, che rende "Mancanza-Inferno" un’opera di straordinario valore, soprattutto se considerata all’interno del panorama italiano. Un viaggio dentro le macerie di ogni essere umano.
LINGUA: italiano
Sussurri e grida (1972)
Ingmar Bergman, in un dramma da camera ambientato in una villa svedese di fine Ottocento, esplora l’agonia di Agnes, morente di cancro, e la difficile relazione tra le sue sorelle emotivamente distanti, Karin e Maria, in contrasto con la compassione fisica della serva Anna.
Il film è una delle massime espressioni del simbolismo cromatico bergmaniano: il rosso domina quasi ogni scena d’interni, rappresentando “l’interno dell’anima” e agendo come un’allegoria del sangue, del dolore e della membrana organica della vita. Le frequenti transizioni in una schermata rossa pura (dissolvenze) richiamano la fragilità dell’esistenza e l’imminenza della morte. La fotografia, premiata con l’Oscar a Sven Nykvist, cattura l’intimità spietata dei primi piani, registrando ogni sfumatura emotiva delle protagoniste.
Badlands (1973)
Il folgorante debutto di Terrence Malick, ispirato alle gesta criminali di Charles Starkweather e Caril Ann Fugate, è un dramma lirico che segue la fuga omicida di Kit (Martin Sheen) e della sua fidanzata adolescente passiva, Holly (Sissy Spacek), attraverso le pianure del Midwest.
Malick crea un contrasto poetico e disturbante tra l’azione mortale e la bellezza indifferente del paesaggio, filtrando la violenza attraverso la voce fuori campo ingenua e disinteressata di Holly. Gli omicidi sono messi in scena in modo distaccato, quasi senza sangue, a suggerire che la violenza è diventata “un’astrazione oscura” nella psiche americana, riflettendo la disillusione nazionale dell’era Vietnam. Il film è una “favola, fuori dal tempo” che usa il road movie per esplorare l’alienazione e la mitizzazione della violenza giovanile.
La montagna sacra (1973)
La montagna sacra (The Holy Mountain) di Alejandro Jodorowsky è un’opera surrealista e allucinatoria che sfida i confini del cinema convenzionale. Segue un vagabondo che assomiglia a Gesù Cristo in un mondo di avidità e corruzione, il quale viene reclutato da un Alchimista per unirsi a sette “potenti titani” che rappresentano i pianeti e i vizi.
Il gruppo intraprende un viaggio mistico verso la Montagna Sacra per raggiungere l’immortalità, in un percorso che è una satira violenta sul materialismo, la religione organizzata e l’ossessione per il potere. Il film, un capolavoro del cinema psichedelico, è dominato da simbolismi esoterici e immagini grottesche, ed è inteso da Jodorowsky come un’esperienza che induce l’illuminazione, cercando di colmare il divario tra arte e realtà nella mente dello spettatore.
Lo spirito dell’alveare (1973)
Il debutto di Víctor Erice è considerato il più grande film spagnolo del decennio. Ambientato in un piccolo villaggio castigliano nel 1940, all’indomani della Guerra Civile Spagnola e sotto la dittatura di Franco, la storia segue la bambina Ana, ossessionata dal film Frankenstein che ha visto con la sorella.
Il film è una critica velata e allegorica al regime franchista, costretta a ricorrere al simbolismo per eludere la censura. L’alveare che il padre coltiva simboleggia l’ordine e la monotonia della società fascista. La ricerca di Ana dello “spirito” del mostro in una capanna abbandonata diventa una metafora della ricerca di una realtà alternativa, un senso di innocenza o un rifugio dal trauma e dal silenzio imposto dagli adulti. Il film usa una luce color miele e pochissimi dialoghi, concentrandosi sulla forza ipnotica delle immagini.
Mistero di un impiegato

Film drammatico, thriller, di Fabio Del Greco, Italia, 2019.
Qualcuno vuole controllare la vita dell’impiegato Giuseppe Russo: i prodotti che acquista, la sua fede politica e religiosa, la sua vita privata, persino i suoi sogni. Ma farà di tutto per sfuggire al controllo e trovare il suo vero io. Giuseppe è un uomo sui 45 anni, sposato, con un lavoro stabile e una casa di proprietà. La sua vita scorre apparentemente tranquilla, quando incontra un vagabondo misterioso gli consegna delle vecchie videocassette VHS. Giuseppe inizia a vedere i nastri video in cui è filmato in alcuni momenti della sua vita fin da bambino, poi da adolescente e da giovane. Chi ha girato quei video di cui non ricorda nulla? Giuseppe ha la strana sensazione di essere costantemente osservato e inizia a indagare su ciò che sta accadendo. Attraverso la sua indagine, inizia a riscoprire la sua vera identità e a prendere coscienza di chi è veramente.
Mistero di un impiegato è un film mette in luce il pericolo del controllo sociale e mostra una società in cui tutti sono costantemente sorvegliati e condizionati nel loro io più profondo. Il film è anche un'analisi della natura umana e sull'identità. Fabio Del Greco, che interpreta Giuseppe, offre una performance coinvolgente. Altrettanto brava è Chiara Pavoni, nel ruolo di Giada Rubin e Roberto Pensa nel ruolo del vagabondo. Mistero di un impiegato è un film che affronta temi importanti in modo originale, un thriller psicologico che mantiene lo spettatore incollato allo schermo fino alla fine: una metafora della società contemporanea, in cui le persone sono sempre più sorvegliate e condizionate dai media e dalle tecnologie. E' un un'opera coraggiosa e provocatoria, che affronta temi importanti in modo originale.
LINGUA: italiano
SOTTOTITOLI: inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese
La Conversazione (1974)
Francis Ford Coppola diresse questo thriller psicologico, un capolavoro della paranoia, tra i due capitoli de Il Padrino. Il protagonista è Harry Caul (Gene Hackman), un esperto di sorveglianza ossessionato dalla privacy che teme che la sua ultima intercettazione possa portare a un omicidio.
Il film è un’indagine spietata sulla colpa e sulla responsabilità morale nell’era post-Watergate. Il design sonoro di Walter Murch è l’elemento chiave: il suono non è solo un accompagnamento, ma il fulcro della narrazione. La manipolazione di frammenti di conversazione e l’uso ossessivo della tecnica del vococentrismo amplificano l’ansia e la paranoia di Caul, trasformando il thriller in un ritratto psicologico. La suspense è generata non dall’azione, ma dall’ambiguità del suono, culminando nell’autodistruzione mentale di Caul.
Il Padrino – Parte II (1974)
L’ambizioso sequel e prequel di Coppola intreccia due storie parallele. Da un lato, la continua ascesa di Michael Corleone negli anni ’50, mentre cerca di espandere l’impero di famiglia a Las Vegas e Cuba, affrontando nemici politici e un devastante tradimento che proviene dal cuore della sua stessa famiglia. Dall’altro, il prequel delle origini del padre, un giovane Vito Corleone, dal suo arrivo in America come immigrato siciliano alla sua metodica e paziente ascesa a Don rispettato di New York.
Il Padrino – Parte II è uno dei rari casi in cui il sequel è considerato superiore all’originale, perché non si limita a continuare la storia, ma la riesamina criticamente. La struttura a due tempi è la tesi del film: un confronto diretto tra padre e figlio.
È un dramma che mostra due percorsi opposti. Vito CorleDE nIRO) costruisce una famiglia e una comunità; la sua violenza è mirata (l’omicidio di Don Fanucci) e serve a proteggere e creare. Michael (Pacino) distrugge la sua famiglia per proteggere un “business” astratto; la sua violenza (l’omicidio del fratello Fredo) è il cancro che divora tutto dall’interno.
È un dramma sulla corruzione assoluta dell’anima. Il film si conclude con la vittoria totale di Michael sui suoi nemici e la sua completa distruzione come essere umano. L’inquadratura finale di Michael, seduto da solo nel parco della sua villa, consumato dal potere e perso nei ricordi di un tempo in cui la famiglia era unita, è la tragica conclusione del Sogno Americano: un ciclo di violenza che divora sé stesso.
Chinatown (1974)
Nella Los Angeles degli anni Trenta, il detective privato J.J. “Jake” Gittes, specializzato in casi di adulterio, viene assunto da una donna misteriosa per spiare suo marito, l’ingegnere capo del dipartimento idrico della città. Quello che sembra un caso di routine si trasforma in un’indagine mortale che svela una rete di corruzione pubblica, avidità capitalistica e un segreto familiare oscuro e incestuoso.
Chinatown è la quintessenza del neo-noir, un film che prende gli elementi del noir classico e li immerge nel pessimismo cinico degli anni Settanta. Il dramma non riguarda solo un omicidio, ma la corruzione sistemica. L’acqua, non il denaro, è l’oggetto del desiderio, il controllo del “futuro”.
L’eroe, Jake Gittes, fallisce. A differenza di un eroe noir classico, il suo intervento non risolve nulla; peggiora le cose. Il suo tentativo di salvare la femme fatale, Evelyn Mulwray, porta direttamente alla sua morte.
“Chinatown” non è un luogo fisico, è uno stato mentale. È il simbolo del trauma irrisolvibile del passato di Gittes e del limite dell’intervento. La battuta finale del film, sussurrata a Gittes dopo la tragedia – “Lascia perdere, Jake. È Chinatown” – è l’ammissione dell’impotenza totale dell’individuo di fronte a un male sistemico e primordiale. È uno dei finali più cupi e potenti della storia del cinema.
La paura mangia l’anima (1974)
Rainer Werner Fassbinder, figura centrale del Nuovo Cinema Tedesco, realizza un melodramma socio-politico che è un omaggio e un aggiornamento del film Secondo amore di Douglas Sirk. Il film racconta la storia d’amore tra Emmi, una vedova tedesca di sessant’anni, e Ali, un giovane immigrato marocchino.
Fassbinder utilizza questa premessa per denunciare il razzismo e l’ipocrisia della Germania del dopoguerra. Il dramma non deriva da forze esterne, ma dal giudizio e dall’ostracismo di familiari, vicini e colleghi. Lo stile è statico e teatrale, con inquadrature che spesso intrappolano i personaggi in angusti spazi domestici, enfatizzando il loro isolamento e la loro oppressione sociale. Il titolo riflette la verità universale che la paura e il pregiudizio sono forze distruttive che corrodono l’anima.
Mondo folle

Film drammatico, thriller, di Fabio Del Greco, Italia, 2010.
Luca, cameriere precario e squattrinato con una relazione in crisi con la sua ragazza, vive un periodo di vita pieno di dubbi, quando rincontra Chiara, ex collega del corso di laurea in filosofia, che invece si è realizzata ed ha aperto un locale con cui guadagna molto bene. Luca lascia la sua vecchia vita ed inizia una relazione con Chiara: gestisce insieme a lei il locale, grazie al quale, con un giro di escort e cocaina ai politici che lo frequentano, riesce ad uscire dalla sua difficile condizione economica. Chiara però non ottiene l’appalto dell’ex fornace dall'onorevole Saverio e lo ricatta con un video che lo ritrae mentre ha un rapporto sessuale con un trans. Il regista racconta una realtà che conoscono bene in molti: frustrazione, senso di precarietà e sfiducia perenne nelle istituzioni e nella meritocrazia.
Spunto di riflessione
L'idea di guadagnare con metodi sporchi, diventare furbi e senza scrupoli sembra essere l'unica strada che ti premia in una società profondamente malata alla radice, priva di una visione etica. Mentre i lavoratori comuni sono condannati a continue difficoltà ed alla "crisi" senza fine. Ma si può migliorare la propria vita inserendosi in un sistema malato?
LINGUA: italiano
SOTTOTITOLI: inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese
Una moglie (1974)
John Cassavetes, maestro del cinema indipendente americano, con Una moglie (A Woman Under the Influence), esplora la tensione e l’amore turbolento tra Mabel Longhetti (Gena Rowlands) e suo marito Nick (Peter Falk), un operaio edile, quando la mente di Mabel inizia a cedere sotto il peso delle aspettative sociali sul suo ruolo di moglie e madre.
Il film rifiuta il linguaggio cinematografico convenzionale per abbracciare un iper-realismo emotivo. Le scene sono lunghe e improvvisate, girate in ambienti reali, con la macchina da presa costantemente incollata ai volti degli attori per catturare ogni sfumatura di isteria, affetto e confusione. Rowlands offre una performance titanica, rendendo la sua lotta per la “normalità” un commento crudo sulla violenza implicita nelle rigide definizioni di genere e famiglia.
Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975)
Randle P. McMurphy, un delinquente di piccolo calibro, per sfuggire alla prigione si finge pazzo e viene internato in un ospedale psichiatrico. Il suo spirito ribelle, caotico e amante della vita si scontra immediatamente con l’ordine gelido, passivo-aggressivo e repressivo imposto dalla capo infermiera, Mildred Ratched. Inizia così una battaglia di volontà per la libertà e l’anima degli altri pazienti.
Questo è il dramma definitivo sull’individuo contro il sistema. L’ospedale psichiatrico non è un luogo di cura, ma una metafora di una società che impone il conformismo attraverso il controllo. Il film gioca magistralmente sul confine labile tra sanità e follia: McMurphy, il “pazzo”, è l’unica persona veramente sana e vitale; l’infermiera Ratched, l'”autorità”, è un mostro di controllo che usa la vergogna come arma.
McMurphy risveglia la vita negli altri pazienti, insegnando loro a sfidare l’autorità e a riscoprire la propria individualità. Ma il prezzo della loro “cura” è il suo stesso sacrificio.
Il dramma del film è una potente parabola cristologica. McMurphy perde la sua battaglia personale: dopo aver attaccato Ratched, viene lobotomizzato, ridotto a un vegetale. Ma la sua vittoria non è la sua fuga; è il suo martirio. Il Grande Capo, l’indiano che McMurphy ha “risvegliato”, completa la sua missione: soffoca McMurphy per liberarlo e poi usa il lavandino (che McMurphy non era riuscito a sollevare) per sfondare la finestra e fuggire. È un dramma sulla trasmissione della ribellione: un salvatore che deve morire perché lo spirito libero possa finalmente scappare.
Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975)
Il film monumentale di Chantal Akerman è una pietra miliare del cinema strutturalista e femminista. Per oltre tre ore, il film osserva meticolosamente la routine quotidiana di Jeanne Dielman (Delphine Seyrig), una vedova che si occupa della casa, cucina per il figlio e si prostituisce occasionalmente.
Il radicalismo del film risiede nella sua forma: Akerman rifiuta le ellissi temporali, costringendo lo spettatore a confrontarsi con la durata del lavoro domestico. La macchina da presa fissa non giudica, ma registra il peso fisico e psicologico della routine. La minima interruzione di questo ordine meticoloso funge da sismografo per il crollo imminente, trasformando la banalità domestica in un thriller esistenziale. L’opera è una critica potente che politizza lo spazio domestico e contesta lo sguardo maschile.
Nashville (1975)
Robert Altman realizza un affresco corale che decostruisce il mito americano nell’anno che precede il bicentenario, intrecciando le vite di 24 personaggi nella capitale della musica country, Nashville. La trama culmina in una kermesse politica dove musica, fama e ambizione si scontrano in modo caotico.
L’innovazione tecnica centrale è l’uso di microfoni individuali (multitraccia), che permette a Robert Altman di registrare dialoghi sovrapposti e simultanei. Questo “muro sonoro” crea una cacofonia, una dichiarazione tematica sul fatto che nessuno ascolta veramente l’altro in un’America confusa e in cerca di celebrità. Il film anticipa la fusione tra politica e intrattenimento (show business) attraverso la campagna del candidato invisibile Hal Phillip Walker, che si sente stranamente profetica oggi.
Taxi Driver (1976)
Travis Bickle è un ex marine mentalmente instabile e affetto da insonnia cronica, che lavora come tassista notturno in una New York moralmente decadente. La sua alienazione urbana è totale; osserva la “feccia” della città dal suo taxi e scrive un diario dei suoi pensieri violenti. La sua ossessione per “ripulire” le strade lo porta prima a pianificare un omicidio politico, poi a un sanguinoso e ambiguo “salvataggio” di una prostituta dodicenne, Iris.
Questo è il manifesto cinematografico della solitudine urbana. Travis non è solo un personaggio, è un sintomo di una città malata e di una nazione reduce dal trauma del Vietnam. Il famoso monologo allo specchio (“Stai parlando con me?”) è il grido disperato di un uomo che cerca una connessione, un’identità, anche se questa deve essere forgiata nella violenza.
Il dramma esplora il confine labile tra un uomo disturbato e una società altrettanto disturbata. Il finale ambiguo, in cui Travis viene celebrato dai media come un eroe per il suo massacro, è la parte più terrificante e potente del film. La società è così malata da non saper più distinguere un eroe da un sociopatico.
Travis è un anti-eroe che cerca disperatamente uno scopo. La tragedia è che, dopo aver provato a connettersi in modi “normali” (con Betsy) e fallendo, l’unica via d’azione che la società gli offre, e l’unica competenza che l’esercito gli ha lasciato, è la violenza.
Quinto potere (1976)
Quinto potere (Network) di Sidney Lumet, con la sceneggiatura di Paddy Chayefsky, è una satira operistica e profetica sulla televisione e l’informazione. Il film racconta come un network televisivo (UBS) sfrutti cinicamente le crisi di nervi e le invettive di Howard Beale (Peter Finch), un ex conduttore squilibrato, per aumentare gli ascolti.
Il film anticipò con inquietante precisione la deriva dell’informazione verso l’intrattenimento, la mercificazione della rabbia pubblica e l’avvento dei reality show. La frase iconica di Beale, “Sono incazzato nero. E non lo sopporterò più”, diventa il grido di battaglia per una nazione che si sente manipolata. L’opera è una lucida critica al globalismo corporativo, dove le metriche di profitto (gli ascolti) guidano ogni decisione, trasformando il dolore e la rabbia in merce.
Eraserhead – La mente che cancella (1977)
Il lungometraggio d’esordio di David Lynch è un incubo surrealista in bianco e nero, ambientato in un desolato paesaggio post-industriale. Henry Spencer (Jack Nance) tenta di gestire la paternità di un neonato mostruoso e piangente.
Il film è fondamentale per il suo design sonoro, un tappeto incessante di ronzii elettrici, vento e sferragliamenti che genera un’ansia fisica nello spettatore. Nonostante la sua logica onirica e grottesca, Eraserhead è profondamente radicato nelle paure reali della responsabilità genitoriale e della domesticità soffocante. L’opera si impose come capostipite dei “midnight movies” e dimostrò che il cinema poteva abbandonare la logica narrativa per abbracciare un linguaggio puramente sensoriale e psicanalitico.
I giorni del cielo (1978)
I giorni del cielo (Days of Heaven) di Terrence Malick è un dramma pastorale ambientato nelle vaste pianure del Texas nel 1916. Racconta un triangolo amoroso tra due amanti in fuga, Bill (Richard Gere) e Abby, che si fingono fratelli per lavorare in un campo di grano di proprietà di un ricco e malato agricoltore (Sam Shepard).
Questo film è celebrato come un’apice della poesia visiva nel cinema. Malick e il direttore della fotografia Néstor Almendros decisero di girare quasi esclusivamente durante l’ora d’oro (la “magic hour”), utilizzando solo luce naturale o fonti giustificabili come candele e lanterne. Questa scelta estetica conferisce un senso di “bellezza indifferente” al paesaggio, un lirismo che contrasta con la tragedia umana in atto, suggerendo che le passioni e i drammi degli uomini sono trascurabili di fronte ai cicli eterni della natura.
Killer of Sheep (1978)
Charles Burnett, figura chiave del movimento “L.A. Rebellion”, realizzò questo capolavoro del neorealismo afroamericano con un budget limitato e in bianco e nero. Il film osserva la vita quotidiana di Stan, un operaio di un mattatoio nel quartiere di Watts, schiacciato dalla fatica alienante e dall’insonnia.
Il film è spesso paragonato al Neorealismo italiano per la sua attenzione alla classe operaia e per il suo stile documentaristico. Non si concentra su una trama sensazionale, ma sulla dignità silenziosa e sulla resilienza della comunità nera in un ambiente urbano degradato. Le scene del mattatoio, in cui le pecore vengono macellate, creano una metafora potente sulla vulnerabilità e sulla sopravvivenza in un sistema che consuma gli individui. È un film essenziale che rifiuta gli stereotipi della Blaxploitation dell’epoca.
Il Cacciatore (1978)
Il Cacciatore (The Deer Hunter) di Michael Cimino è un dramma epico sulla guerra del Vietnam e sul suo impatto traumatico su una piccola comunità operaia russo-americana della Pennsylvania. La storia segue tre amici (Robert De Niro, Christopher Walken e John Savage) prima, durante e dopo il loro servizio militare nel sud-est asiatico.
La critica è spesso divisa sulla durata della lunghissima sequenza iniziale del matrimonio, ma essa è cruciale per stabilire i riti sacri e i legami comunitari che la guerra violerà e distruggerà. La metafora centrale della roulette russa, sebbene controversa per l’accuratezza storica, funziona come un simbolo potente della casualità della morte e dell’orrore psicologico imposto dal conflitto. Il film è un requiem per l’innocenza americana, concentrandosi sulle devastanti conseguenze emotive e psicologiche della guerra sui sopravvissuti.
Stalker (1979)
Andrej Tarkovskij chiude il decennio con un’opera di fantascienza filosofica che si focalizza sui paesaggi interiori. Stalker segue una guida nota come lo Stalker, che conduce un melanconico Scrittore e un professore Scienziato in un luogo misterioso e proibito chiamato “La Zona”, dove si crede che una stanza esaudisca i desideri più intimi.
Il film combina fantascienza con profondi temi drammatici, psicologici e teologici. La Zona, un paesaggio post-apocalittico e vegetale, diventa un’entità senziente, un luogo di pellegrinaggio spirituale che riflette le paure e i desideri inconsci di chi la attraversa. Il rifiuto degli effetti speciali a favore di lunghi piani sequenza e movimenti di macchina ipnotici rende il film una profonda meditazione sulla fede, sul desiderio e sulla crisi spirituale dell’uomo moderno in un mondo secolarizzato.
Apocalypse Now (1979)
Nel pieno della Guerra del Vietnam, al capitano dei servizi segreti dell’esercito Benjamin Willard viene assegnata una missione segreta e letale: risalire un fiume fino alla Cambogia per trovare ed “eliminare con pregiudizio” il colonnello Walter E. Kurtz. Kurtz, un tempo l’ufficiale più brillante dell’esercito, è impazzito, ha stabilito il proprio dominio su una tribù locale e combatte la sua guerra personale come un dio.
Francis Ford Coppola non ha diretto un film di guerra. Ha diretto un dramma psicologico sulla follia, un’opera esistenziale che usa la guerra come catalizzatore per dissolvere la sanità mentale. Il viaggio di Willard sul fiume è una discesa nel Cuore di Tenebra. Ogni incontro, dalla Cavalcata delle Valchirie di Kilgore al delirio del ponte di Do Lung, è uno stadio progressivo della de-civilizzazione.
Il dramma culmina nell’incontro con Kurtz. Willard, l’assassino inviato dalla “civiltà”, si rende conto che Kurtz non è pazzo nel senso convenzionale. Ha semplicemente “spezzato il guinzaglio” della morale, ha guardato dritto nell'”orrore” della natura umana e lo ha abbracciato.
Il vero dramma del film è la fusione psicologica tra i due. La missione di Willard non è un’eliminazione, ma una successione. La struttura circolare del film, che inizia e finisce con “The End” dei The Doors, implica che Willard, uccidendo Kurtz, ne ha ereditato l’incubo e il fardello. L’orrore non può essere sconfitto; può solo essere trasmesso.
Film drammatici anni ’80
I film drammatici degli anni ’80 riflettono un decennio di contrasti, tra inquietudini sociali, trasformazioni politiche e nuove sensibilità visive. Dal realismo urbano alle storie intime che mettono a nudo le fragilità umane, il dramma in questo periodo ha trovato forme potenti e spesso iconiche.
Toro Scatenato (1980)
Il ritratto biografico, brutale e al contempo poetico, del pugile dei pesi medi Jake LaMotta. Il film segue la sua tumultuosa ascesa al campionato negli anni Quaranta e la sua rovinosa caduta. La stessa rabbia autodistruttiva, la gelosia sessuale quasi psicotica e l’incapacità di articolare i propri sentimenti che lo rendono inarrestabile sul ring, distruggono la sua vita privata e le sue relazioni.
Martin Scorsese non dirige un film sulla boxe; dirige un film sull’autodistruzione. Il dramma è corporeo. La celebre trasformazione fisica di Robert De Niro, che ha messo su oltre 25 chili per interpretare il LaMotta grasso e fallito, non è un vezzo da Metodo, è il testo del film. Il corpo di LaMotta è il palcoscenico della sua tragedia personale, un pezzo di carne da punire.
Il ring non è uno sport, è un purgatorio. Scorsese, che credeva questo sarebbe stato il suo ultimo film, lo infonde di un cattolicesimo quasi penitenziale. LaMotta, incapace di gestire i suoi peccati fuori dal quadrato, cerca attivamente la punizione sul ring, incassando colpi che sono un’espiazione.
L’uso del bianco e nero non è una scelta stilistica, ma etica. Sottrae il film al realismo della biografia sportiva e lo eleva a tragedia astratta, un balletto lirico e straordinariamente violento. La scena cruciale nella cella di prigione, dove LaMotta sbatte la testa contro il muro urlando “Non sono un animale”, è il cuore del dramma: la disperata e tardiva affermazione della propria umanità da parte di un uomo che si è comportato come una bestia per tutta la vita.
The Elephant Man (1980)
Basato sulla vera storia di Joseph Merrick, il film segue la vita di un uomo gravemente deforme nella Londra vittoriana, salvato da un freak show dal dottor Frederick Treves. Merrick, inizialmente considerato ritardato e mostruoso, rivela un’anima gentile, un’intelligenza raffinata e una sensibilità artistica che sfidano i pregiudizi della società aristocratica che lo osserva con un misto di orrore e curiosità.
David Lynch, al suo primo film in studio dopo l’esordio sperimentale di Eraserhead, compie una scelta estetica radicale girando in un bianco e nero contrastato che richiama l’espressionismo e la fotografia medica dell’epoca. Non si limita a narrare una biografia, ma utilizza l’ambientazione della rivoluzione industriale — con i suoi vapori, i rumori metallici ossessivi e le ciminiere fumanti — come metafora visiva della brutalità meccanica che schiaccia l’organico. Il film è un’indagine sulla dialettica dello sguardo: Lynch costringe lo spettatore a confrontarsi con la propria voyeuristica attrazione per il diverso, ribaltando progressivamente la prospettiva fino a farci vedere il mondo attraverso la singola fessura del cappuccio di Merrick.
L’opera trascende il genere del “monster movie” per diventare un trattato filosofico sulla dignità umana. La celebre scena in cui Merrick, braccato dalla folla nella stazione di Liverpool Street, urla “Non sono un animale! Sono un essere umano!”, non è solo un climax drammatico, ma una rivendicazione ontologica che risuona contro ogni forma di disumanizzazione. Lynch evita il sentimentalismo facile mantenendo un’atmosfera onirica e inquietante, suggerendo che la vera mostruosità non risiede nella deformità fisica, ma nella freddezza clinica della scienza e nella crudeltà dello spettacolo sociale.
Das Boot (1981)
Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’equipaggio di un sottomarino tedesco U-Boot affronta la noia logorante della pattuglia nell’Atlantico e il terrore improvviso dei cacciatorpediniere alleati. Il film descrive minuziosamente la vita claustrofobica a bordo, le tensioni tra i marinai e la disperata lotta per la sopravvivenza mentre la macchina bellica nazista inizia a sgretolarsi.
Wolfgang Petersen realizza un capolavoro di ingegneria cinematografica che ribalta la prospettiva del film di guerra tradizionale. Eliminando quasi ogni riferimento ideologico o glorificazione del nazismo, il regista si concentra sulla dimensione fenomenologica della guerra sottomarina. La cinepresa, costretta negli spazi angusti del battello, si muove con frenesia attraverso i corridoi pieni di valvole e tubi, utilizzando lenti grandangolari che deformano i volti sudati dei marinai, trasmettendo allo spettatore una sensazione fisica di soffocamento e pressione.
Il design sonoro gioca un ruolo narrativo primario: il silenzio assoluto, rotto solo dal sinistro “ping” del sonar nemico o dallo scricchiolio dello scafo che cede alla pressione dell’acqua, diventa un’arma di tensione psicologica insopportabile. Das Boot è un’opera esistenzialista sulla futilità della guerra, dove non ci sono eroi, ma solo uomini terrorizzati intrappolati in una bara d’acciaio. Il finale tragico e anticlimatico nega ogni possibilità di catarsi, lasciando solo la devastazione di un destino cinico che colpisce proprio quando la salvezza sembrava raggiunta.
Fanny e Alexander (1982)
Nella Svezia di inizio Novecento, i fratelli Fanny e Alexander vivono un’infanzia felice nella lussuosa e teatrale famiglia Ekdahl. Dopo la morte del padre, la madre si risposa con un vescovo puritano e crudele, trascinando i bambini in un mondo di ascetismo e punizioni. Alexander dovrà usare la sua immaginazione e l’aiuto di forze sovrannaturali (e di un amico ebreo della famiglia) per sfuggire alla prigionia e ritrovare la libertà.
Ingmar Bergman concepisce questo film come il suo testamento artistico, un’opera fluviale e sontuosa che abbandona il minimalismo angoscioso dei suoi drammi da camera per abbracciare la “gioia di raccontare”. La dicotomia visiva è netta: il rosso, l’oro e il velluto della casa degli Ekdahl rappresentano il teatro, l’arte, il cibo e l’amore imperfetto ma vitale; il grigio, il bianco e la nuda pietra della casa del Vescovo simboleggiano la morte dell’anima sotto il peso del dogma religioso. Bergman non ha paura di mescolare il realismo storico con il realismo magico: statue che respirano, fantasmi che dialogano con i vivi e poteri telepatici sono trattati come fatti naturali.
Il film è un inno alla resistenza dell’immaginazione contro l’autoritarismo. Alexander, alter ego del regista, impara che la menzogna artistica è l’unica arma capace di sconfiggere la “verità” oppressiva del potere. Nonostante il lieto fine apparente, Bergman inserisce note oscure: il male non viene mai completamente esorcizzato, ma rimane in agguato (il fantasma del Vescovo che promette di non andarsene mai). È una celebrazione della complessità della vita, che accoglie il mistero e rifiuta le risposte assolute.
Re per una notte (1982)
Rupert Pupkin è un aspirante comico senza talento, ossessionato dal conduttore di talk show Jerry Langford. Convinto di essere destinato alla grandezza, Pupkin, con l’aiuto di un’altra fan squilibrata, rapisce Langford per ricattare il network e ottenere un monologo di apertura in prima serata. La sua esibizione avviene, e il confine tra celebrità e follia si dissolve.
Martin Scorsese realizza quello che è forse il film più profetico del decennio. Abbandonando i movimenti di macchina virtuosi, adotta uno stile visivo piatto, quasi televisivo, che intrappola lo spettatore nella mediocrità della visione del mondo di Pupkin. Robert De Niro offre una performance disturbante per la sua apparente normalità: il suo Pupkin non è un mostro violento, ma un uomo banale, insistente e impermeabile al rifiuto, incarnazione del narcisismo patologico che pretende la fama come diritto inalienabile.
Il film anticipa con precisione chirurgica l’era dei reality show, degli influencer e la cultura della celebrità tossica, dove l’essere conosciuti è più importante dell’avere talento o moralità. Il finale ambiguo — sogno o realtà? — in cui Pupkin diventa una star grazie al suo crimine, suggerisce un cinismo sociale devastante: il pubblico è pronto a perdonare e celebrare qualsiasi atrocità purché sia confezionata come intrattenimento. “Meglio re per una notte che buffone per sempre” non è solo la battuta finale, ma la condanna di un’epoca.
C’era una volta in America (1984)
L’epopea di David “Noodles” Aaronson e dei suoi amici ebrei nel Lower East Side di New York attraversa quarant’anni di storia, dal proibizionismo agli anni ’60. Tra amicizie virili, tradimenti imperdonabili, violenza brutale e amori perduti, Noodles torna da anziano nei luoghi della sua giovinezza per svelare il mistero che ha distrutto la sua vita e capire chi lo ha manipolato per decenni.
Sergio Leone firma il suo requiem per il cinema e per il mito americano. La struttura narrativa è un labirinto temporale complesso, in cui il tempo non scorre linearmente ma si dilata e si contrae seguendo il flusso della memoria associativa (un esempio magistrale è lo squillo del telefono che unisce passato e presente). La teoria che l’intera parte del 1968 sia un sogno d’oppio di Noodles nel 1933 aggiunge un livello di tragica grandezza: il film diventa l’allucinazione di un uomo che cerca di riscrivere il proprio fallimento e il tradimento dell’amico Max.
Visivamente, il film è un poema di malinconia. La fotografia di Tonino Delli Colli e la colonna sonora struggente di Ennio Morricone lavorano in simbiosi per creare un senso di perdita irreparabile. Leone non giudica i suoi gangster, ma ne mostra la crudeltà e l’umanità disperata, riflettendo su come il tempo eroda tutto: le ambizioni, i legami e persino la verità. È un’opera monumentale sulla memoria come unica forma di possesso possibile in una vita destinata a svanire.
Paris, Texas (1984)
Un uomo, Travis, riappare nel deserto del Texas dopo essere scomparso per quattro anni. È muto e affetto da amnesia. Suo fratello Walt lo riporta a Los Angeles, dove Travis si riunisce con il figlio di sette anni, Hunter. Insieme, padre e figlio intraprendono un viaggio attraverso il sud-ovest americano alla ricerca di Jane, la moglie di Travis e madre di Hunter, per cercare di ricomporre i pezzi di una famiglia e di una memoria in frantumi.
Il capolavoro di Wim Wenders è un road movie che trascende il genere per diventare una meditazione poetica sull’alienazione, la memoria e il mito americano. La sua produzione, una collaborazione tra Germania e Francia, gli conferisce uno sguardo esterno e unico sui paesaggi e sull’iconografia degli Stati Uniti. L’indipendenza del progetto è evidente nel suo ritmo lento e contemplativo e nella sua narrazione che privilegia l’immagine e l’atmosfera rispetto all’azione. La fotografia di Robby Müller trasforma i deserti, le autostrade e le città al neon in paesaggi emotivi, specchi dell’anima tormentata di Travis. Il film rifiuta le convenzioni del dramma familiare. Il culmine emotivo non è un confronto urlato, ma una lunga e straziante confessione attraverso il vetro di un peep-show, una scena di un’audacia e di una potenza incredibili. È una scelta profondamente anti-commerciale, che si affida interamente alla forza della parola e alla performance degli attori. Paris, Texas è un’opera che dimostra come il cinema d’autore possa esplorare i grandi temi dell’identità e dell’appartenenza con una grazia e una profondità lirica indimenticabili.
Stranger Than Paradise (1984)
Willie, un hipster newyorkese indolente, ospita controvoglia la cugina ungherese Eva. Insieme all’amico Eddie, i tre intraprendono un viaggio senza meta che li porta dalla claustrofobica New York alla gelida Cleveland fino a una Florida desolata. Non succede quasi nulla di eclatante: mangiano tv dinner, guardano la televisione, perdono soldi alle corse e fissano il vuoto.
Jim Jarmusch definisce con questo film l’estetica del cinema indipendente americano moderno. Girato in un bianco e nero granuloso, il film è composto da lunghi piani sequenza fissi (i “one-shot scenes”) separati da dissolvenze in nero, rifiutando il montaggio convenzionale campo-controcampo. Questa scelta stilistica enfatizza la stasi, la noia e l’assenza di una vera progressione drammatica, creando un ritmo ipnotico basato sui tempi morti.
L’opera è un “anti-road movie”. Jarmusch demistifica il viaggio americano: ovunque vadano i protagonisti, il paesaggio rimane identico, anonimo e privo di significato. Che siano davanti a un lago ghiacciato o su una spiaggia, i personaggi rimangono intrappolati nella loro alienazione. Tuttavia, il film è pervaso da un umorismo deadpan (impassibile) e da una sottile tenerezza per questi outsider che cercano di navigare l’assurdità del quotidiano senza una bussola morale o ambizioni, offrendo una visione dell’America disincantata ma stranamente poetica.
Ran (1985)
Nel Giappone feudale, il potente signore della guerra Hidetora Ichimonji decide di abdicare e dividere il suo regno tra i tre figli. Questa decisione scatena una guerra fratricida devastante, alimentata dalla vanità del padre e dalla perfidia dei figli maggiori. Mentre il regno brucia, Hidetora scivola nella follia, vagando come un fantasma tra le rovine del suo impero, perseguitato dagli errori del passato.
Akira Kurosawa adatta il Re Lear di Shakespeare trasformandolo in un affresco visivo di proporzioni titaniche. Il colore è usato in modo codificato e strutturale: ogni armata ha un colore primario (giallo, rosso, blu), trasformando le scene di battaglia in composizioni astratte di violenza cromatica. Kurosawa porta il nichilismo shakespeariano alle estreme conseguenze: se in Shakespeare c’è ancora un barlume di ordine cosmico, in Ran (che significa “Caos”) gli dei sono spettatori silenziosi e indifferenti (“Sono andati a dormire”, dice il giullare), lasciando l’uomo solo con la sua follia distruttiva.
La scena dell’assalto al terzo castello è uno dei vertici assoluti del cinema: Kurosawa rimuove completamente i suoni della battaglia (urla, spade, zoccoli) lasciando spazio solo alla solenne e tragica colonna sonora di Toru Takemitsu. Questo distacco sensoriale eleva l’orrore a pura tragedia lirica, costringendo lo spettatore a contemplare la guerra non come azione, ma come un’apocalisse estetica e morale inevitabile, frutto della cecità del potere.
Va’ e vedi (1985)
Nella Bielorussia del 1943, il giovane Flyora trova un fucile e si unisce con entusiasmo ai partigiani sovietici, sognando l’eroismo. Quello che lo attende è un’odissea di orrori inimmaginabili attraverso villaggi bruciati, esecuzioni di massa e la brutalità sistematica delle Einsatzgruppen naziste. Il viaggio trasforma fisicamente e psicologicamente il ragazzo, che in pochi giorni invecchia precocemente, diventando un guscio vuoto con il volto segnato da rughe profonde.
Elem Klimov realizza un film di guerra che trascende il realismo per toccare l’allucinazione e l’horror. L’uso rivoluzionario della Steadicam permette alla cinepresa di fluttuare attorno a Flyora, incollandosi al suo volto e costringendo lo spettatore a guardare dritto nell’abisso. Il sound design è aggressivo e soggettivo: ronzii, fischi e distorsioni simulano l’acufene da bombardamento, immergendo il pubblico nel disorientamento sensoriale del protagonista. Non c’è spazio per l’eroismo sovietico tradizionale; c’è solo la nuda esposizione del male.
La sequenza finale, in cui Flyora spara rabbiosamente a un ritratto di Hitler mentre un montaggio a ritroso riavvolge la storia del dittatore fino a farlo tornare un bambino in braccio alla madre, pone un interrogativo morale devastante. Flyora si ferma, incapace di sparare al bambino: nonostante l’inferno attraversato, un frammento di umanità resiste, rifiutando la logica del genocidio preventivo. È un film che non si guarda, si subisce, come un atto di testimonianza necessaria.
Velluto Blu (1986)
Il giovane Jeffrey Beaumont, tornato nella sua tranquilla cittadina natale per assistere il padre malato, trova un orecchio umano in un campo. La sua indagine amatoriale lo porta a conoscere la cantante di night club Dorothy Vallens e lo psicopatico Frank Booth, trascinandolo in un sottobosco di sadomasochismo, droghe e violenza sessuale che si nasconde dietro la facciata rispettabile della provincia americana.
David Lynch squarcia il velo dell’America reaganiana con un film che è al contempo un noir, un mistery e un viaggio psicanalitico. L’incipit è programmatico: dai cieli azzurri e le rose rosse saturate (i colori dell’illusione), la cinepresa scende nel terreno brulicante di insetti neri, rivelando la corruzione che nutre la bellezza di superficie. Il personaggio di Frank Booth, interpretato da un terrificante Dennis Hopper, è l’incarnazione dell’Id freudiano senza freni, una figura paterna oscura che respira gas misteriosi e alterna brutalità e regressione infantile.
Lynch esplora il tema del voyeurismo (Jeffrey che spia dall’armadio) come metafora del cinema stesso: siamo tutti complici affascinati dal buio. L’uso della canzone “Blue Velvet” crea un corto circuito tra romanticismo nostalgico e perversione. Il ritorno finale all’ordine, con il pettirosso meccanico che mangia l’insetto, appare volutamente posticcio e inquietante: l’innocenza perduta non può essere recuperata, ma solo simulata grottescamente.
Full Metal Jacket (1987)
Il film segue un plotone di Marines dall’addestramento brutale a Parris Island, sotto il comando del sergente Hartman, fino agli scontri urbani durante l’Offensiva del Tet in Vietnam. Il soldato Joker, che porta sull’elmetto la scritta “Born to Kill” e sul petto il simbolo della pace, diventa l’osservatore cinico di un processo di disumanizzazione che trasforma ragazzi in macchine da guerra e poi li getta nel caos di un conflitto senza senso.
Stanley Kubrick adotta un approccio strutturalista, dividendo nettamente il film in due atti. . La seconda parte distrugge quella geometria, immergendo i soldati in una guerra urbana, sporca e confusa. Kubrick evita la giungla tipica del genere, ricostruendo il Vietnam in una fabbrica di gas abbandonata a Londra, creando un paesaggio alienante, industriale e freddo.
Il tema centrale è la “dualità dell’uomo”, esplicitamente citata da Joker (riferimento a Jung). Kubrick mostra come la guerra non sia un’avventura epica, ma un lavoro burocratico di morte. La scena finale, con i soldati che marciano tra le rovine in fiamme cantando la sigla del “Mickey Mouse Club”, è una delle immagini più potenti e sarcastiche del cinema: l’infantilismo della cultura pop americana si fonde con l’orrore assoluto, sancendo la regressione definitiva dell’uomo a uno stato di follia collettiva.
Il cielo sopra Berlino (1987)
Damiel e Cassiel sono due angeli che vegliano su una Berlino ancora divisa dal Muro. Invisibili agli umani, possono ascoltare i loro pensieri più intimi e offrire un conforto silenzioso, ma non possono interagire fisicamente con il mondo. Damiel, stanco dell’eternità spirituale e innamorato di una trapezista, decide di rinunciare alla sua immortalità per diventare umano, sperimentare il dolore, il colore e la finitezza della vita.
Wim Wenders crea una poesia visiva dedicata all’atto di “vedere”. La fotografia di Henri Alekan alterna il bianco e nero (la visione angelica: oggettiva, onnisciente ma distaccata) e il colore (la visione umana: soggettiva, limitata ma vibrante). La macchina da presa compie movimenti fluidi e impossibili, attraversando muri e palazzi, suggerendo che solo lo sguardo spirituale può superare le divisioni storiche e politiche che lacerano la città e l’Europa.
Il film è una meditazione profonda sull’incarnazione. Il desiderio di Damiel di “sentire il peso”, di sporcarsi le dita con l’inchiostro, di bere un caffè caldo, rappresenta una rivalutazione radicale dell’esistenza terrena. In un decennio spesso dominato dal materialismo e dall’evasione, Wenders ci ricorda la sacralità delle piccole esperienze quotidiane. La presenza di Peter Falk (nel ruolo di se stesso ed ex-angelo) e la performance di Nick Cave aggiungono strati di meta-cinema e cultura pop che ancorano la favola metafisica alla realtà concreta del 1987.
Nuovo Cinema Paradiso (1988)
Salvatore Di Vita, affermato regista che vive a Roma, riceve la notizia della morte di Alfredo, il proiezionista del suo paese natale in Sicilia. Questo evento scatena un lungo flashback sulla sua infanzia (come Totò) trascorsa nella cabina di proiezione del Cinema Paradiso, dove Alfredo gli ha insegnato i segreti del mestiere e della vita, e sul suo primo amore adolescenziale perduto. Il ritorno al paese per il funerale diventa un confronto doloroso con le radici che ha dovuto recidere per avere successo.
Giuseppe Tornatore realizza un atto d’amore universale verso il cinema come spazio di aggregazione sociale e fabbrica dei sogni. Tuttavia, sotto la patina nostalgica, il film affronta temi amari: la censura ecclesiastica che tagliava i baci dalle pellicole, la povertà del dopoguerra e, soprattutto, la crudeltà necessaria dell’ambizione. Alfredo, figura paterna sostitutiva, spinge Totò ad andarsene e a “non voltarsi mai indietro”, condannandolo alla solitudine affettiva in cambio della realizzazione artistica.
La sequenza finale dei “baci tagliati”, montati insieme da Alfredo come regalo postumo per Salvatore, è uno dei momenti più alti della storia del cinema. È una forma di meta-cinema purissimo: il medium filmico riesce a ricucire ciò che la realtà (e la morale repressiva) aveva diviso, restituendo al protagonista l’emozione pura dell’amore e della passione che la vita reale gli ha negato. È una catarsi che celebra l’immortalità dell’immagine contro la caducità dell’esistenza.
Fa’ la cosa giusta (1989)
Nel giorno più caldo dell’anno a Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, le tensioni razziali ribollono in un isolato multietnico. Il fragile equilibrio tra la comunità afroamericana, i proprietari italoamericani di una pizzeria (Sal e i suoi figli) e la polizia locale si sgretola progressivamente, culminando in un atto di brutalità della polizia e in una rivolta che distrugge il locale.
Spike Lee costruisce una tragedia greca moderna rispettando le unità di tempo e luogo. L’elemento visivo chiave è il calore: il direttore della fotografia Ernest Dickerson utilizza una palette cromatica saturata di rossi, arancioni e gialli, evitando quasi completamente i blu e i verdi, per far “sentire” fisicamente allo spettatore l’afa oppressiva che esaspera gli animi. Le inquadrature oblique (canted angles) destabilizzano costantemente la visione, preannunciando la rottura dell’ordine sociale.
Il film rifiuta le risposte facili. Mookie, il protagonista che lavora per Sal ma lancia il bidone della spazzatura che innesca la distruzione della pizzeria, compie un gesto ambiguo: atto di violenza o diversivo per salvare Sal dal linciaggio fisico? Chiudendo con le citazioni contrapposte di Martin Luther King (sulla non violenza) e Malcolm X (sulla violenza come autodifesa), Lee non offre una soluzione morale, ma costringe il pubblico a confrontarsi con la realtà sistemica del razzismo e con l’inevitabilità del conflitto quando la giustizia viene negata.
Sesso, bugie e videotape (1989)
L’arrivo di Graham, un vecchio amico misterioso e introverso, sconvolge la vita di una coppia borghese insoddisfatta, John e Ann, e della sorella di lei, Cynthia. Graham ha una particolare fetichismo: essendo impotente, trova soddisfazione solo registrando videocassette di donne che confessano i loro segreti sessuali. Questa pratica di voyeurismo tecnologico agisce come un catalizzatore che fa emergere le ipocrisie e i tradimenti che legano gli altri personaggi.
Steven Soderbergh, con questo film che ha vinto la Palma d’Oro a Cannes, segna la nascita ufficiale del cinema indipendente americano degli anni ’90. È un dramma da camera cerebrale che anticipa profeticamente il ruolo della tecnologia nella mediazione dell’intimità. La videocamera diventa un confessionale laico, uno strumento paradossale che permette una verità emotiva impossibile nel faccia a faccia diretto.
Stilisticamente minimalista, il film si affida a primi piani strettissimi che scrutano le micro-espressioni degli attori, creando una tensione erotica fatta di parole e non di atti. Soderbergh decostruisce la sessualità maschile e femminile, mostrando come il desiderio sia indissolubilmente legato alla menzogna e alla narrazione di sé. Graham, l’osservatore distaccato, finisce per essere l’unico personaggio capace di onestà in un mondo di apparenze sociali costruite.
Drugstore Cowboy (1989)
Bob Hughes è il leader superstizioso di una “famiglia” disfunzionale di tossicodipendenti che viaggia attraverso il Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti svaligiando farmacie per procurarsi la droga. Il film segue la loro routine criminale, i rituali legati all’assunzione di sostanze e l’inevitabile disgregazione del gruppo di fronte alla legge e alla tragedia, fino al tentativo di Bob di ripulirsi e tornare a una vita “normale”.
Gus Van Sant rompe radicalmente con i cliché del cinema sulla droga: non c’è giudizio morale, né tragedia melodrammatica esasperata. L’approccio è quasi antropologico: la droga è mostrata come un lavoro, una necessità pragmatica che offre un sollievo temporaneo e crea una comunità alternativa alle regole della società borghese. Le immagini surreali (mucche, case che volano) visualizzano lo stato alterato della mente in modo poetico e non solo disturbante.
Un tema centrale è la superstizione (il divieto assoluto di mettere cappelli sul letto), che introduce una dimensione fatalista: i personaggi sanno di vivere in un tempo “preso in prestito”. La presenza dello scrittore William S. Burroughs nel ruolo di un vecchio prete tossicomane funge da benedizione letteraria, collegando il film alla tradizione della controcultura beat. Van Sant suggerisce che la scelta della dipendenza è, in fondo, una risposta razionale all’insostenibile banalità del vivere quotidiano.
Film drammatici anni ’90
I film drammatici degli anni ’90 hanno catturato un decennio di trasformazioni culturali, inquietudini sociali e nuove poetiche cinematografiche. Tra realismo crudo, storie intime e personaggi memorabili, il dramma ha trovato forme mature e spesso rivoluzionarie.
Schindler’s List (1993)
La vera storia di Oskar Schindler, un industriale tedesco, membro del partito nazista, che arriva in Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale con l’intento di arricchirsi. Sfrutta la manodopera ebraica per la sua fabbrica di smalti. Testimone della crescente e disumana brutalità dell’Olocausto, in particolare durante la liquidazione del ghetto di Cracovia, subisce una profonda trasformazione morale. Rischia la sua vita e la sua intera fortuna per salvare oltre 1.100 ebrei dai campi di sterminio.
Steven Spielberg sceglie di raccontare il dramma dell’Olocausto non attraverso gli occhi di una vittima, ma attraverso quelli di un carnefice che diventa testimone. Il dramma del film è il lento e doloroso risveglio della coscienza di Schindler.
L’uso del bianco e nero non è una scelta estetica, ma etica. Dà al film il peso di un documento storico, di un atto di memoria incancellabile. Il famoso tocco di colore – la bambina con il cappotto rosso – è il momento in cui la Storia smette di essere un’astrazione e diventa un individuo, il momento in cui Schindler non può più distogliere lo sguardo.
Il dramma si condensa nell’oggetto del titolo. La lista, da strumento burocratico della disumanizzazione nazista, diventa nelle mani di Schindler l’esatto opposto: un elenco di vite, un simbolo che “la lista è vita”. Il film è un dramma sull’azione. Non chiede al pubblico solo commozione, ma lo interroga sulla sua stessa inazione di fronte all’ingiustizia. Il crollo finale di Schindler – “Avrei potuto salvarne di più” – è uno dei momenti più potenti della storia del cinema, un lamento sulla responsabilità morale che perseguita anche l’eroe.
Le ali della libertà (The Shawshank Redemption) (1994)
Andy Dufresne (Tim Robbins), un banchiere condannato ingiustamente a due ergastoli per l’omicidio della moglie, viene rinchiuso nel penitenziario di Shawshank. Lì stringe un’amicizia profonda con Red (Morgan Freeman), un altro ergastolano “che sa procurare cose”, e cerca di sopravvivere alla brutalità della prigione aggrappandosi alla speranza. Regia di Frank Darabont.
Nonostante l’insuccesso iniziale al botteghino, è diventato uno dei film più amati di tutti i tempi. È un’opera potente e commovente, un inno alla resilienza dello spirito umano. È da non perdere per la sua narrazione impeccabile, che trasforma una storia di ingiustizia e disperazione in un’epopea sulla speranza, l’amicizia e il potere della mente di restare libera.
Film drammatici anni 2000
I film drammatici degli anni 2000 hanno trasformato il panorama cinematografico con storie audaci, emozioni crude e un rinnovato interesse per i personaggi e le loro fragilità. In un decennio segnato da svolte culturali e da stili registici in evoluzione, il dramma ha esplorato identità, traumi e cambiamenti con un’intensità senza precedenti.
Dogville (2003)
Grace, una donna in fuga da dei gangster, trova rifugio a Dogville, una piccola e isolata comunità tra le Montagne Rocciose. Gli abitanti, inizialmente diffidenti, accettano di nasconderla in cambio di piccoli lavori. Ma la loro apparente benevolenza si trasforma presto in sfruttamento e abuso, spingendo Grace verso un abisso di umiliazione. Quando la verità sulla sua identità verrà rivelata, la vendetta sarà terribile e senza pietà.
L’opera di Lars von Trier è un esperimento cinematografico radicale e una parabola spietata sulla natura umana, un film che poteva essere concepito solo da una mente indipendente e provocatoria. Girato interamente su un palcoscenico spoglio, con edifici e strade disegnati con il gesso sul pavimento, Dogville adotta un’estetica brechtiana che allontana lo spettatore dall’illusione realistica. Questa scelta stilistica non è un vezzo, ma uno strumento per costringere il pubblico a concentrarsi sulla moralità della storia. Rimuovendo ogni distrazione visiva, von Trier mette a nudo i meccanismi del potere, dell’ipocrisia e della crudeltà. Il film è una critica feroce non solo dell’America, ma di qualsiasi comunità che nasconde il proprio lato oscuro dietro una facciata di virtù. La discesa agli inferi di Grace e la sua successiva, apocalittica vendetta, pongono domande scomode sulla colpa, il perdono e la giustizia. È un film difficile, spesso accusato di cinismo e misoginia, ma la sua forza risiede proprio nella sua capacità di disturbare e di costringere a una riflessione morale. È un esempio estremo di come il cinema d’autore possa usare la forma per veicolare un contenuto politico e filosofico dirompente.
Me and You and Everyone We Know (2005)
Christine, artista e autista per anziani, si innamora di Richard, un venditore di scarpe appena separato e padre di due figli. Mentre Christine cerca di entrare in sintonia con lui, i figli di Richard esplorano il mondo delle relazioni a modo loro: il più piccolo, di sette anni, è coinvolto in una bizzarra corrispondenza online, mentre il quattordicenne diventa una cavia per le prove d’amore delle ragazze del quartiere. Le loro storie si intrecciano, esplorando la solitudine e la ricerca di una connessione nell’era digitale.
Il lungometraggio d’esordio di Miranda July è un film indipendente nel vero senso della parola: è la visione singolare e inclassificabile di un’artista che lavora al di fuori di ogni convenzione. Me and You and Everyone We Know sfida qualsiasi etichetta di genere, mescolando commedia, dramma e performance art per creare un ritratto unico della solitudine e della goffa ricerca di connessione nella Los Angeles contemporanea. La sua indipendenza gli permette di esplorare temi delicati e spesso scomodi, come la sessualità infantile e le fantasie adulte, con un’onestà e una stravaganza impensabili in un contesto mainstream. Il film non giudica i suoi personaggi; li osserva con una curiosità quasi antropologica, trovando poesia e umorismo nelle loro stranezze e vulnerabilità. La narrazione è frammentata, composta da una serie di vignette intersecanti che riflettono la natura casuale e spesso bizzarra delle interazioni umane. È un film che crede nella possibilità di momenti magici e connessioni inaspettate, anche in un mondo frammentato e alienante. La sua estetica, che fonde il banale con il surreale, è il risultato di una visione artistica che non ha paura di essere strana, tenera e profondamente umana.
Little Miss Sunshine (2006)
La disfunzionale famiglia Hoover intraprende un viaggio disastroso a bordo di un pulmino Volkswagen scassato per portare la figlia più giovane, Olive, a un concorso di bellezza per bambine in California. Durante il tragitto, le nevrosi e i sogni infranti di ogni membro della famiglia vengono a galla: un padre ossessionato dal successo, un figlio che ha fatto voto di silenzio, uno zio studioso e suicida, un nonno eroinomane e una madre che cerca disperatamente di tenere tutto insieme.
Little Miss Sunshine è un esempio perfetto di come il cinema indipendente possa prendere una struttura familiare, come quella del road movie, e infonderla di un’originalità e un’onestà emotiva che la rendono unica. Nonostante il suo successo e il cast di nomi noti, il film nasce da uno spirito “indie”, evidente nel suo rifiuto del sentimentalismo e nella sua celebrazione dell’imperfezione. La sceneggiatura, che ha circolato per anni prima di trovare finanziamenti, è una critica sferzante alla cultura americana ossessionata dalla vittoria, incarnata dal programma in nove passi del padre Richard. In un film di una major, i personaggi sarebbero stati probabilmente smussati, resi più simpatici e le loro spigolosità addolcite. Qui, invece, la loro disfunzionalità è il cuore della storia. La libertà produttiva ha permesso ai registi Jonathan Dayton e Valerie Faris di mantenere l’umorismo nero e la malinconia del copione, creando un equilibrio delicato tra commedia e dramma. Il culmine del film, la performance di Olive al concorso di bellezza, è un atto di pura ribellione indie. Invece di un trionfo convenzionale, assistiamo a un’esibizione goffa e inappropriata che diventa un momento di catarsi familiare. È un rifiuto gioioso delle norme soffocanti della società e una dichiarazione che il vero successo non sta nel vincere, ma nell’avere il coraggio di essere se stessi, insieme.
Il petroliere (There Will Be Blood) (2007)
All’inizio del XX secolo, Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) è un cercatore d’argento che si trasforma in un magnate del petrolio spietato e misantropo. La sua scalata al potere lo porta in conflitto con un giovane predicatore evangelico, Eli Sunday (Paul Dano), in una battaglia epica per il denaro e la fede. Regia di Paul Thomas Anderson.
È un’opera monumentale, un dramma epico sulla nascita del capitalismo americano, sull’avidità e sulla corruzione dell’anima. È un film imperdibile per la regia magistrale di Anderson e per la performance titanica di Daniel Day-Lewis (premiato con l’Oscar), che incarna in modo terrificante l’oscurità del sogno americano.
Wendy and Lucy (2008)
Wendy, una giovane donna con pochi soldi, sta viaggiando verso l’Alaska in cerca di lavoro, accompagnata dalla sua unica compagna, la cagna Lucy. Quando la sua vecchia auto si rompe in una piccola città dell’Oregon, la sua situazione, già precaria, precipita. Dopo essere stata arrestata per aver rubato del cibo per cani, Wendy scopre che Lucy è scomparsa. Inizia così una ricerca disperata e straziante, mentre le sue risorse e le sue speranze si esauriscono lentamente.
Il film di Kelly Reichardt è un capolavoro di minimalismo, un ritratto silenzioso e devastante della precarietà economica nell’America contemporanea. La sua indipendenza si manifesta nel suo approccio rigoroso e anti-drammatico. Reichardt evita ogni forma di sentimentalismo, raccontando la storia di Wendy con uno stile quasi documentaristico. La narrazione è scarna, composta da piccoli eventi che accumulano un peso emotivo enorme. . Il film è una critica potente a una società che non offre una rete di sicurezza per i più vulnerabili. Ogni ostacolo che Wendy incontra, dalla macchina rotta alla burocrazia, è un piccolo fallimento del sistema. Wendy and Lucy è un’opera che dimostra come il cinema indipendente possa affrontare grandi temi sociali attraverso una storia piccola e intima, un promemoria che il dramma più profondo è spesso quello che si svolge in silenzio.
Fish Tank (2009)
Mia, un’adolescente di quindici anni, vive in un complesso di case popolari nell’East London. È una ragazza arrabbiata, solitaria e in conflitto con la madre e la sorella minore. La sua unica valvola di sfogo è la danza hip-hop, che pratica in un appartamento abbandonato. La sua vita monotona viene sconvolta dall’arrivo di Connor, il nuovo, affascinante fidanzato della madre. Tra Mia e Connor nasce un’attrazione pericolosa che cambierà per sempre il fragile equilibrio della famiglia.
Fish Tank di Andrea Arnold è un esempio folgorante di realismo sociale britannico, un film che vibra di un’energia cruda e di un’autenticità quasi documentaristica. La sua indipendenza è palpabile in ogni fotogramma, dall’uso della telecamera a mano che segue da vicino la protagonista, quasi invadendo il suo spazio personale, alla scelta di un’attrice esordiente, Katie Jarvis, scoperta per caso a una stazione ferroviaria. Queste decisioni creano un’immersione totale nel mondo di Mia, un mondo fatto di cemento, rabbia e desideri inespressi. Il titolo stesso è una metafora potente: Mia è come un pesce in un acquario, intrappolata in un ambiente limitato, ma piena di una vita e di un’energia che lottano per emergere. Il film non giudica i suoi personaggi, ma li osserva con un misto di durezza e tenerezza. La relazione tra Mia e Connor è trattata con una complessità che evita facili moralismi. Non è solo una storia di seduzione, ma un racconto confuso sul bisogno di una figura paterna e sull’incapacità di gestire l’amore quando non lo si è mai ricevuto. È un film che dimostra come il cinema indipendente possa dare voce a chi non ne ha, raccontando storie dal basso con una forza e una verità che il cinema mainstream raramente riesce a raggiungere.
Film drammatici anni 2010
I film drammatici degli anni 2010 hanno ridefinito il modo di raccontare il dolore, la crescita e l’ambiguità umana. In un decennio segnato da autori visionari e nuove sensibilità narrative, il dramma ha trovato forme più intime, realistiche e spesso spietate. Questa lista raccoglie alcune delle opere più potenti del periodo, quelle che hanno lasciato un segno per intensità emotiva, qualità registica e capacità di restare nella memoria molto dopo i titoli di coda.
Melancholia (2011)
Il film è diviso in due parti, intitolate alle due sorelle protagoniste, Justine e Claire. La prima parte segue il disastroso ricevimento di nozze di Justine, la cui profonda depressione emerge e manda in frantumi la celebrazione. La seconda parte si concentra su Claire, che cerca di mantenere una parvenza di normalità mentre un pianeta errante chiamato “Melancholia” si avvicina minacciosamente alla Terra, minacciando una collisione apocalittica. Paradossalmente, mentre il mondo precipita nel panico, Justine trova una strana calma di fronte alla fine imminente.
Lars von Trier crea un “bel film sulla fine del mondo”, un’opera che unisce una bellezza visiva mozzafiato a una rappresentazione viscerale della depressione. La sua indipendenza gli permette di fondere generi diversi – il dramma familiare, il film catastrofico, il poema visivo – in un’opera unica e inclassificabile. Il prologo, una serie di quadri in slow-motion accompagnati dalla musica di Wagner, è un pezzo di puro cinema d’autore che anticipa la fine fin dall’inizio. Questa scelta narrativa elimina la suspense convenzionale del film catastrofico, spostando l’attenzione dalla domanda “cosa succederà?” a “come reagiranno i personaggi?”. Melancholia è una delle più potenti rappresentazioni cinematografiche della depressione. La malattia di Justine non è un semplice stato di tristezza, ma una lente attraverso cui vede il mondo con una lucidità terribile. Di fronte all’annientamento, le convenzioni sociali e le paure di Claire si rivelano inutili, mentre la malinconia di Justine diventa una forma di saggezza. È un film che esplora la psiche umana di fronte al disastro, un’opera d’arte visionaria che trova una bellezza terribile e sublime nell’apocalisse.
Una separazione (A Separation, 2011)
Una coppia della classe media di Teheran, Nader e Simin, è in crisi. Simin vuole lasciare l’Iran per offrire un futuro migliore alla figlia, ma Nader si rifiuta di abbandonare il padre malato di Alzheimer. La loro separazione innesca una catena di eventi che li coinvolge in un conflitto con un’altra famiglia, di estrazione sociale più bassa. Una bugia, un incidente e un’accusa di omicidio trasformano un dramma domestico in un thriller morale senza via d’uscita.
Il capolavoro di Asghar Farhadi è un esempio lampante di come un film, prodotto in modo indipendente al di fuori del sistema occidentale, possa raggiungere una risonanza universale attraverso la pura forza della sua narrazione. Una separazione utilizza un dramma familiare come microcosmo per esplorare le complesse faglie della società iraniana contemporanea: le divisioni di classe, le tensioni religiose e il peso della burocrazia. La sua indipendenza è cruciale, poiché consente a Farhadi di offrire uno sguardo critico e sfumato sul suo paese, senza cadere nel didascalismo o nella propaganda. La genialità del film risiede nella sua ambiguità morale. Non ci sono eroi o cattivi, solo persone comuni intrappolate in circostanze difficili, costrette a prendere decisioni impossibili. La sceneggiatura, tesa come quella di un thriller, costruisce la suspense non attraverso l’azione, ma attraverso il peso delle scelte e delle loro conseguenze. Ogni personaggio ha le sue ragioni, e il film si rifiuta di prendere posizione, lasciando allo spettatore il compito di giudicare. Questa complessità psicologica e questo realismo intransigente sono i frutti preziosi della libertà creativa, che hanno permesso a Una separazione di trascendere i confini culturali e di essere acclamato in tutto il mondo come un’opera fondamentale del cinema del XXI secolo.
Amour (2012)
Georges e Anne sono una coppia di ottantenni, ex insegnanti di musica, la cui vita colta e serena viene sconvolta quando Anne viene colpita da un ictus che la lascia paralizzata su un lato del corpo. Georges, fedele alla promessa di non farla tornare in ospedale, si dedica completamente alla sua cura. Mentre la salute di Anne peggiora inesorabilmente, il loro appartamento parigino diventa il teatro di una straziante prova d’amore, dignità e sofferenza.
Il film di Michael Haneke è un’esplorazione intransigente e profondamente umana della vecchiaia, della malattia e della fine della vita. La sua indipendenza è essenziale per il suo approccio rigoroso e privo di sentimentalismo. Haneke rifiuta qualsiasi tipo di abbellimento melodrammatico, confinando quasi tutta l’azione all’interno dell’appartamento della coppia. Questa scelta claustrofobica trasforma lo spazio domestico, un tempo simbolo di amore e cultura, in una prigione e, infine, in una tomba. Un film di una major avrebbe cercato momenti di catarsi, flashback nostalgici o una colonna sonora commovente per alleviare la durezza del tema. Haneke, invece, si affida a lunghi piani sequenza, a un silenzio assordante e alle performance monumentali di Jean-Louis Trintignant ed Emmanuelle Riva. Lo sguardo del regista è quasi clinico, ma mai crudele. È un atto di rispetto verso la realtà della sofferenza, che si rifiuta di distogliere lo sguardo. Amour non è un film sulla morte, ma, come ha detto lo stesso Haneke, su “come gestire la sofferenza di una persona che ami. È un’opera che richiede coraggio allo spettatore, un capolavoro del cinema d’autore che affronta le domande più difficili dell’esistenza con una lucidità e una compassione indimenticabili.
Frances Ha (2012)
Frances Halladay è una ballerina di 27 anni che naviga con goffaggine la vita a New York. Quando la sua migliore amica e coinquilina, Sophie, decide di trasferirsi, il mondo di Frances viene sconvolto. Senza un lavoro stabile, un appartamento fisso o una relazione sentimentale, Frances si lancia in una serie di avventure impulsive, da un breve soggiorno a Parigi a un ritorno al suo vecchio college, cercando di trovare il suo posto nel mondo e di dare un senso alla sua identità in evoluzione.
Girato in un bianco e nero che evoca la Nouvelle Vague francese, Frances Ha è una celebrazione dell’amicizia femminile e un ritratto affettuoso e onesto di quella fase della vita in cui ci si sente “non ancora una persona vera. La collaborazione tra Noah Baumbach e Greta Gerwig, che ha co-scritto e interpretato il film, è l’essenza dello spirito indipendente: una visione artistica condivisa e profondamente personale. Il film rifiuta una struttura narrativa convenzionale, optando per una serie di vignette che catturano la natura frammentaria e incerta della vita di Frances. Non c’è un grande conflitto da risolvere o un obiettivo chiaro da raggiungere; il dramma risiede nella lotta quotidiana di Frances per mantenere la sua identità e il suo ottimismo di fronte a una realtà che sembra costantemente deluderla. La scelta del bianco e nero non è un semplice omaggio stilistico, ma una decisione che astrae il film dalla realtà contemporanea, trasformando New York in un paesaggio emotivo e senza tempo. Frances Ha è un film che trova la sua bellezza nella goffaggine, la sua profondità nella leggerezza e la sua verità nel caos. È un’opera che celebra l’essere “non databili”, un inno alla resilienza e alla gioia di trovare il proprio, piccolo posto nel mondo, anche se non corrisponde esattamente al nome che avevi in mente.
Beasts of the Southern Wild (2012)
Hushpuppy, una bambina di sei anni, vive con il padre malato e irascibile in una comunità isolata nella baia della Louisiana, chiamata “la Vasca da Bagno”. Quando una tempesta epocale sommerge la loro terra, e la salute del padre peggiora, il mondo di Hushpuppy si sgretola. Armata del suo ottimismo infantile e di una straordinaria immaginazione, che evoca creature preistoriche chiamate Aurochs, la piccola eroina deve imparare a sopravvivere e a trovare il suo posto in un universo che sembra andare in pezzi.
L’opera prima di Benh Zeitlin è un’esplosione di realismo magico, un poema visivo di una bellezza selvaggia e di una potenza emotiva travolgente. Realizzato con un budget ridottissimo e un cast di attori non professionisti, il film è l’epitome del cinema indipendente americano. La sua estetica, che mescola una fotografia cruda e quasi documentaristica con immagini fantastiche, crea un mondo unico e indimenticabile. La libertà creativa di Zeitlin gli permette di raccontare una storia di sopravvivenza attraverso la prospettiva lirica e soggettiva di una bambina. La “Vasca da Bagno” non è solo un luogo di povertà, ma una comunità fiera e resiliente, un simbolo di resistenza contro un mondo che li ha dimenticati. Il film è una potente allegoria del cambiamento climatico e della fragilità del nostro ecosistema, ma è anche una storia universale sulla perdita, sul coraggio e sulla connessione tra gli esseri umani e la natura. La performance della giovanissima Quvenzhané Wallis è un miracolo di naturalezza e forza. È un film che dimostra come l’indipendenza possa dare vita a opere visionarie e profondamente originali.
Nebraska (2013)
Woody Grant, un anziano e alcolizzato del Montana, è convinto di aver vinto un milione di dollari a un concorso a premi e vuole a tutti i costi andare a Lincoln, in Nebraska, per ritirare la vincita. Suo figlio David, stanco di vederlo tentare la fuga a piedi, decide di assecondarlo e di accompagnarlo in un lungo viaggio in auto. Il percorso li porta attraverso la città natale di Woody, dove si riuniscono con parenti avidi e vecchi rivali, costringendo David a confrontarsi con il passato e la vera natura di suo padre.
Il film di Alexander Payne è un road movie malinconico e tenero, un ritratto agrodolce dell’America di provincia e dei legami familiari. La sua sensibilità è profondamente indipendente, evidente nella scelta radicale di girare in bianco e nero. Questa decisione estetica non è un vezzo, ma uno strumento per catturare la desolazione dei paesaggi del Midwest e per conferire alla storia una qualità iconica e senza tempo. Il film evita il sentimentalismo, trovando umorismo e umanità nelle situazioni più squallide e nei personaggi più scontrosi. La libertà del regista gli permette di mantenere un tono che oscilla tra la commedia e il dramma, senza mai cadere nel patetico. La performance di Bruce Dern nel ruolo di Woody è straordinaria, un ritratto di un uomo testardo e confuso, ma con una dignità nascosta. Il viaggio non è tanto per il milione di dollari, ma per il desiderio di Woody di lasciare qualcosa di sé, di avere un’ultima occasione di essere visto come qualcuno che conta. Nebraska è un film che dimostra come il cinema indipendente possa trovare l’epica nel piccolo, raccontando una storia sulla famiglia, la memoria e la ricerca di un senso alla fine della vita.
Short Term 12 (2013)
Grace è una giovane supervisore in un centro di accoglienza per adolescenti a rischio. Con passione e fermezza, si prende cura dei ragazzi, aiutandoli a navigare i loro traumi. La sua dedizione, però, nasconde un passato doloroso che riemerge con l’arrivo di Jayden, una nuova ospite con cui Grace sviluppa un legame profondo e conflittuale. Mentre cerca di salvare Jayden, Grace è costretta a confrontarsi con le proprie ferite non ancora guarite.
Short Term 12 è un piccolo miracolo del cinema indipendente, un film che affronta temi difficili come l’abuso e il trauma con una sensibilità e un’onestà disarmanti. Nato come cortometraggio basato sull’esperienza diretta del regista Destin Daniel Cretton, il film mantiene un’autenticità quasi documentaristica, resa possibile solo da una produzione libera da vincoli commerciali. La sua forza risiede nel suo approccio focalizzato sui personaggi. Non c’è una trama complessa o colpi di scena elaborati; tutto è al servizio dell’esplorazione emotiva di Grace e dei ragazzi che assiste. Il film riesce a bilanciare magistralmente momenti di umorismo e leggerezza con un dramma straziante, riflettendo la resilienza e la complessità della vita reale. Questa gestione tonale, che passa senza soluzione di continuità dal riso al dolore, è una testimonianza della libertà creativa del regista. La performance di Brie Larson, che ha lanciato la sua carriera, è un tour de force di vulnerabilità e forza. Short Term 12 è un potente promemoria del fatto che il cinema indipendente è spesso il luogo in cui le storie più necessarie e umane trovano la loro voce, dimostrando che la gentilezza e l’empatia possono essere le forze più rivoluzionarie.
Ida (2013)
Polonia, 1962. Anna, una giovane novizia cresciuta in un convento, sta per prendere i voti quando scopre di avere una zia ancora in vita, Wanda, un’ex procuratrice comunista cinica e disillusa. L’incontro rivela ad Anna la sua vera identità: il suo nome è Ida e le sue origini sono ebraiche. Insieme, le due donne intraprendono un viaggio alla ricerca della verità sul tragico destino della loro famiglia durante l’occupazione nazista, un percorso che metterà in discussione le certezze di entrambe.
Il film di Paweł Pawlikowski è un’opera di una bellezza austera e di una potenza silenziosa, un perfetto esempio di come il cinema indipendente possa utilizzare il minimalismo per esplorare temi enormi come l’identità, la fede e il peso della storia. Girato in un bianco e nero rigoroso e con un formato 4:3, Ida crea un’atmosfera malinconica e contemplativa che riflette sia la vita claustrofobica del convento sia il clima politico desolato della Polonia del dopoguerra. Queste scelte estetiche, lontane da ogni logica commerciale, sono fondamentali per il tono del film. La narrazione procede per sottrazione, affidandosi più alle immagini e ai silenzi che ai dialoghi. La libertà del regista si manifesta nel suo rifiuto di spiegare ogni cosa, lasciando che le emozioni e le verità emergano lentamente. Il contrasto tra Ida, l’innocente e devota, e Wanda, la peccatrice tormentata dal passato, non è mai schematico. Entrambe sono personaggi complessi, le cui certezze vengono erose dal loro viaggio. Il film non offre facili consolazioni o risposte definitive, ma si conclude con un’immagine potente e ambigua: Ida che cammina, forse verso il convento, forse verso un futuro incerto. È un finale che racchiude la forza del cinema d’autore: la capacità di porre domande profonde senza la presunzione di avere tutte le risposte.
Boyhood (2014)
Girato nell’arco di dodici anni con gli stessi attori, Boyhood segue la vita di Mason Evans Jr. dall’età di sei anni fino ai diciotto. Il film documenta la sua crescita, i traslochi, le dinamiche familiari con i genitori divorziati e la sorella, i primi amori, le delusioni e la ricerca della propria identità. Non è un racconto di eventi straordinari, ma un ritratto intimo e realistico del flusso ordinario della vita e del passaggio inesorabile del tempo.
L’opera monumentale di Richard Linklater è un esperimento la cui esistenza stessa è un manifesto del cinema indipendente. Nessuno studio di Hollywood avrebbe mai finanziato un progetto così rischioso, dipendente dalla dedizione a lungo termine di un cast e di una troupe per oltre un decennio. Questa indipendenza produttiva non è solo un dettaglio tecnico, ma il cuore pulsante del film, ciò che gli permette di raggiungere un livello di autenticità senza precedenti. Boyhood sovverte la struttura narrativa tradizionale, che seleziona e drammatizza i momenti salienti della vita. Al contrario, il film abbraccia la banalità del quotidiano, trovando una profonda risonanza emotiva nei piccoli momenti: una conversazione in macchina, una lite familiare, un consiglio paterno. La sua struttura episodica, priva di indicatori temporali espliciti, costringe lo spettatore a percepire il tempo come lo viviamo noi, un flusso continuo in cui il cambiamento è graduale e spesso impercettibile. In questo, il film è una critica silenziosa alla mascolinità americana, mostrando come il padre, Mason Sr., maturi insieme ai figli, abbandonando lentamente un’adolescenza prolungata. La vera epica di Boyhood non risiede in un climax drammatico, ma nella totalità dell’esperienza. È un film sulla memoria, sulla formazione dell’identità e sulla natura effimera dell’esistenza, che utilizza il cinema per scolpire il tempo stesso. È un’opera che poteva nascere solo dalla visione ostinata e dalla libertà di un regista indipendente.
The Lobster (2015)
In una società distopica, le persone single vengono arrestate e trasferite in un hotel dove hanno 45 giorni per trovare un partner. Se falliscono, vengono trasformate in un animale a loro scelta. David, un uomo appena lasciato dalla moglie, viene mandato all’hotel e sceglie di diventare un’aragosta in caso di insuccesso. Per sopravvivere, cerca di formare una relazione basata su una caratteristica comune, ma presto scopre che anche la fuga nella foresta, tra i ribelli “Solitari”, impone regole altrettanto rigide e assurde.
Il film di Yorgos Lanthimos è una satira surreale e feroce sulle pressioni sociali legate alle relazioni e alla conformità, un’opera che poteva nascere solo nell’universo eccentrico e senza compromessi del cinema indipendente. La sua premessa, tanto bizzarra quanto geniale, è una metafora della nostra ossessione per l’accoppiamento e della stigmatizzazione della solitudine. La libertà creativa del regista greco gli permette di costruire un mondo grottesco, regolato da leggi assurde e dialoghi impassibili, che espone l’artificialità delle nostre convenzioni sociali. In un film mainstream, una premessa del genere sarebbe stata probabilmente sviluppata come una commedia romantica stravagante. Lanthimos, invece, la usa per creare un’atmosfera di disagio e alienazione, costringendo lo spettatore a riflettere sulla natura delle proprie relazioni. Il film critica sia la tirannia della coppia (l’Hotel) sia quella dell’individualismo forzato (i Solitari), suggerendo che ogni sistema rigido è una prigione. The Lobster è un esempio di come il cinema d’autore possa utilizzare l’assurdo e l’allegoria per formulare una critica sociale profonda e inquietante, lasciando lo spettatore con più domande che risposte.
Mustang (2015)
In un villaggio remoto della Turchia, cinque sorelle orfane vivono con la nonna e lo zio. All’inizio dell’estate, un gioco innocente con dei ragazzi sulla spiaggia viene interpretato come un atto di impudicizia, scatenando uno scandalo. La loro casa si trasforma progressivamente in una prigione: le lezioni di economia domestica sostituiscono la scuola e vengono organizzati matrimoni combinati. Spinte da un irrefrenabile desiderio di libertà, le sorelle lottano contro le restrizioni imposte da una società patriarcale.
Il film di Deniz Gamze Ergüven è un inno vibrante e ribelle alla sorellanza e alla libertà, un’opera che unisce la leggerezza di una favola estiva con la durezza di un dramma sociale. La sua produzione, sostenuta da finanziamenti europei, gli ha garantito l’indipendenza necessaria per affrontare temi delicati e controversi della società turca contemporanea. Il film è stato paragonato a Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola, ma il suo tono è meno malinconico e più combattivo. Le sorelle non sono vittime passive, ma forze della natura, piene di vita, energia e un’incontenibile voglia di ribellione. La regia di Ergüven cattura questa vitalità con una fotografia luminosa e un ritmo incalzante. Nonostante la crescente oppressione, il film è pervaso da momenti di gioia e solidarietà tra le sorelle. Mustang è un potente atto d’accusa contro una cultura che cerca di sopprimere la libertà femminile, ma è anche una celebrazione della resilienza e della forza dello spirito umano. È un film che dimostra come il cinema indipendente possa essere uno strumento potente per la critica sociale, senza mai rinunciare alla bellezza e alla poesia.
Tangerine (2015)
È la vigilia di Natale a Los Angeles. Sin-Dee Rella, una prostituta transgender appena uscita di prigione, scopre che il suo fidanzato e protettore, Chester, l’ha tradita con una donna cisgender. Furiosa, si lancia in una ricerca sfrenata per le strade di Hollywood per trovarli e regolare i conti, trascinando con sé la sua migliore amica, Alexandra. La loro odissea li porterà a incrociare le vite di un tassista armeno e della sua famiglia, in un crescendo di caos e dramma.
Il film di Sean Baker è un’esplosione di energia e un tour de force tecnico, un’opera che ha ridefinito le possibilità del cinema indipendente a basso budget. Girato interamente con tre iPhone 5S, Tangerine dimostra come la limitazione tecnologica possa diventare una forza estetica. La qualità grezza e la mobilità degli smartphone conferiscono al film un’immediatezza e un’urgenza che si adattano perfettamente alla sua narrazione frenetica. La sua indipendenza è evidente anche nella scelta del cast e della storia. Il film dà voce a una comunità, quella delle sex worker transgender di colore, che è stata quasi completamente ignorata o stereotipata dal cinema mainstream. Le performance di Kitana Kiki Rodriguez e Mya Taylor sono autentiche, divertenti e commoventi. Baker non tratta le sue protagoniste come vittime, ma come eroine complesse e resilienti. È un film che mescola commedia, dramma e realismo sociale con una vitalità contagiosa, un esempio di come il cinema indipendente possa essere innovativo, inclusivo e incredibilmente divertente.
Manchester by the Sea (2016)
Lee Chandler è un uomo solitario e taciturno che lavora come tuttofare a Boston, tormentato da un passato tragico. Quando suo fratello maggiore muore improvvisamente, è costretto a tornare nella sua città natale, Manchester-by-the-Sea, per occuparsi del nipote adolescente, Patrick. Lì, Lee deve affrontare i fantasmi della sua vita precedente e la comunità che ha lasciato, mentre cerca di gestire un dolore che sembra impossibile da superare.
Il capolavoro di Kenneth Lonergan è uno studio devastante sul dolore, un film che poteva essere realizzato solo con la libertà e la pazienza del cinema indipendente. A differenza delle produzioni mainstream, che spesso trattano il lutto come un ostacolo da superare attraverso un arco narrativo catartico, Manchester by the Sea si immerge nella sua permanenza, nella sua capacità di definire e paralizzare una vita. La struttura del film, che intreccia presente e passato attraverso flashback improvvisi e frammentari, riflette il modo in cui il trauma agisce sulla mente. Non sono semplici esposizioni, ma schegge di memoria che invadono il presente di Lee, rendendo impossibile qualsiasi forma di guarigione lineare. Questa scelta narrativa, complessa e non convenzionale, è il frutto di una visione d’autore che non ha paura di sfidare lo spettatore. Il film è radicato in un realismo crudo, dalle conversazioni banali sulla logistica di un funerale alla rappresentazione onesta e non giudicante di un uomo che “non può superarlo”. Lee Chandler non è un eroe in cerca di redenzione; è un uomo spezzato che cerca solo di sopravvivere. L’indipendenza del progetto ha permesso a Lonergan di mantenere questo tono intransigente, rifiutando un finale consolatorio a favore di una verità emotiva più complessa e dolorosa. È un’opera che dimostra come il cinema d’autore possa esplorare le profondità più oscure dell’esperienza umana con una grazia e un’onestà ineguagliabili.
Moonlight (2016)
Il film racconta la vita di Chiron in tre capitoli distinti: infanzia, adolescenza ed età adulta. Cresciuto in un quartiere difficile di Miami, Chiron lotta per trovare il suo posto nel mondo, affrontando l’abuso emotivo e fisico mentre fa i conti con la sua identità e la sua sessualità repressa. Il suo percorso è segnato da incontri cruciali con figure che ne plasmano il destino, da uno spacciatore che gli fa da padre a un amico d’infanzia che rappresenta il suo primo e unico legame intimo.
Moonlight di Barry Jenkins è forse l’esempio più puro e potente del cinema indipendente contemporaneo. Incarna perfettamente l’essenza di una storia personale e di nicchia, un racconto che le grandi case di produzione avrebbero quasi certamente evitato per la sua specificità e la sua quieta intensità. Il film rifiuta la narrazione convenzionale per abbracciare una struttura tripartita e lirica, che privilegia l’atmosfera e l’evoluzione interiore del personaggio rispetto a una trama densa di eventi. Questa scelta, permessa solo dall’indipendenza produttiva, consente al film di immergersi completamente nella psicologia del suo protagonista, rendendo il suo dolore e la sua speranza quasi tangibili. L’estetica del film è un magnifico esempio di come i vincoli possano generare innovazione. La fotografia fluida e la palette di colori unica, che rende “i ragazzi neri blu al chiaro di luna”, non è un semplice vezzo stilistico, ma un potente strumento tematico. Trasforma la dura realtà di Liberty City in un paesaggio onirico e malinconico, elevando la lotta di Chiron a una dimensione universale di vulnerabilità e ricerca d’identità. La storica vittoria all’Oscar come Miglior Film non è stata solo un trionfo per un’opera a basso budget, ma un momento di svolta culturale. Ha dimostrato che una voce indipendente, focalizzata su un’esperienza sottorappresentata, poteva raggiungere il più alto riconoscimento dell’industria, sfidando il canone mainstream e, come solo il grande cinema d’autore sa fare, plasmando il gusto del pubblico e aprendo la strada a nuove forme di narrazione.
Paterson (2016)
Paterson è un autista di autobus nella città di Paterson, New Jersey. La sua vita scorre secondo una routine semplice e rassicurante: si sveglia, va al lavoro, ascolta le conversazioni dei passeggeri, torna a casa dalla sua amorevole moglie Laura, porta a spasso il suo bulldog Marvin e si ferma per una birra al bar. In segreto, Paterson è anche un poeta, e trae ispirazione dalla bellezza nascosta nei dettagli della sua vita quotidiana, annotando le sue osservazioni in un taccuino.
Il film di Jim Jarmusch è una meditazione poetica sulla creatività e sulla bellezza dell’ordinario, un’opera che incarna l’essenza più pura del cinema indipendente. In un’epoca dominata da narrazioni ad alta velocità e conflitti drammatici, Paterson osa essere un film sulla quiete, sulla ripetizione e sulla contemplazione. La sua struttura ciclica, che segue una settimana nella vita del protagonista, rifiuta deliberatamente l’arco narrativo tradizionale. Non ci sono grandi eventi o crisi da superare; il dramma è interiore, legato al processo creativo e alla fragile esistenza dell’arte. Questa scelta radicale è possibile solo grazie all’indipendenza di Jarmusch, che da sempre opera ai margini di Hollywood. Il film celebra l’idea che l’arte non debba nascere da grandi sofferenze o avventure, ma possa emergere dalla semplice attenzione al mondo che ci circonda. Paterson, l’uomo, trova la poesia in una scatola di fiammiferi, mentre Paterson, la città, diventa una musa silenziosa. La distruzione del taccuino di poesie da parte del cane Marvin, che in un film convenzionale sarebbe un disastro, qui diventa un’opportunità per un nuovo inizio. Paterson è un film profondamente ottimista e gentile, un promemoria che la creatività è un processo continuo di perdita e rinnovamento, e che la poesia può essere trovata ovunque, se solo ci si prende il tempo di guardare.
American Honey (2016)
Star, un’adolescente che vive in una casa disastrata, abbandona tutto per unirsi a una sgangherata squadra di vendita di abbonamenti a riviste che viaggia attraverso il Midwest americano. Trascinata in un mondo di feste sfrenate, piccole illegalità e giovani amori, Star si lega a Jake, uno dei venditori più carismatici, e si scontra con la dura realtà di un’esistenza precaria, cercando il suo posto in un’America tanto vasta quanto indifferente.
Il film di Andrea Arnold è un road movie epico e immersivo, un ritratto febbrile e sensoriale di una gioventù perduta ai margini del sogno americano. La sua indipendenza è la chiave della sua estetica radicale. Girato in un formato quasi quadrato e con una telecamera a mano che non abbandona quasi mai la protagonista, il film crea un’esperienza visiva e sonora totalizzante. La colonna sonora, un mix di trap, hip-hop e country, non è un semplice sottofondo, ma il motore pulsante del film, l’espressione della vitalità e dell’energia dei personaggi. La libertà di Arnold le permette di adottare una struttura narrativa libera e quasi documentaristica, seguendo il flusso degli eventi senza una trama rigida. Il film è una critica socio-economica all’America neoliberista, ma è anche una celebrazione della bellezza effimera, della connessione con la natura e della resilienza dei giovani. È un’opera che dimostra come il cinema indipendente possa essere al tempo stesso un’analisi sociale e un’esperienza sensoriale, catturando la contraddizione di un paese pieno di promesse e di desolazione.
God’s Own Country (2017)
Johnny Saxby gestisce la fattoria di famiglia nello Yorkshire rurale, anestetizzando la sua solitudine e frustrazione con alcol e sesso occasionale. La sua vita cambia con l’arrivo di Gheorghe, un lavoratore immigrato rumeno assunto per la stagione dell’agnellatura. Inizialmente ostile, Johnny sviluppa gradualmente un rapporto intenso con Gheorghe, che non solo risveglia in lui emozioni sconosciute, ma gli insegna anche a vedere la bellezza e la possibilità di un futuro nella terra che aveva sempre disprezzato.
L’opera prima di Francis Lee è un film di una bellezza aspra e di un’onestà viscerale, radicato nel paesaggio e nella cultura dello Yorkshire. La sua indipendenza è fondamentale per il suo approccio naturalistico. Lee, cresciuto in quella stessa regione, cattura la durezza e la sensualità della vita contadina con un’autenticità quasi tattile. Il film è stato paragonato a Brokeback Mountain, ma la sua sensibilità è distintamente britannica e profondamente personale. A differenza di un dramma hollywoodiano, la comunicazione è scarna, quasi monosillabica. Le emozioni non vengono spiegate, ma espresse attraverso il lavoro fisico, i gesti e gli sguardi. La relazione tra Johnny e Gheorghe si sviluppa in modo organico, nascendo dalla vicinanza forzata e dalla condivisione della fatica. La regia di Lee è sottile, capace di trasmettere il cambiamento interiore di Johnny attraverso il modo in cui interagisce con gli animali e con la terra. Non è solo una storia d’amore, ma un racconto sulla rinascita e sulla possibilità di trovare la speranza nei luoghi più inaspettati. È un esempio di come il cinema indipendente possa raccontare storie d’amore potenti e universali, radicate in una specificità culturale e geografica che le rende uniche e indimenticabili.
The Florida Project (2017)
Moonee è una bambina di sei anni esuberante e piena di vita che trascorre l’estate combinando guai con i suoi amici nei dintorni del “Magic Castle”, un motel viola brillante alla periferia di Disney World. Mentre Moonee vive le sue avventure con l’innocenza dell’infanzia, sua madre Halley, giovane e ribelle, lotta per sbarcare il lunario e proteggere la figlia da una realtà sempre più precaria. A vegliare su di loro c’è Bobby, il manager del motel, una figura paterna burbera ma protettiva.
Il film di Sean Baker è un’opera di un’energia e di un’umanità travolgenti, un ritratto vivido e colorato della povertà nascosta all’ombra del “luogo più felice della Terra. La sua indipendenza è evidente nel suo stile immersivo e nel suo approccio non giudicante. Girato con colori ipersaturi che contrastano con la squallida realtà che descrive, il film cattura il mondo interamente dal punto di vista dei bambini. Per loro, il motel non è un luogo di disperazione, ma un parco giochi infinito. Questa prospettiva infantile, permessa dalla libertà creativa di Baker, è ciò che rende il film così potente e commovente. Nonostante la durezza della situazione, il film è pieno di gioia, umorismo e momenti di pura bellezza. The Florida Project non offre soluzioni o facili moralismi. È uno spaccato di vita che espone una realtà sociale scomoda senza mai perdere l’empatia per i suoi personaggi. .
Call Me by Your Name (2017)
Estate 1983, da qualche parte nel nord Italia. Elio, un diciassettenne italo-americano precoce e sensibile, trascorre le vacanze nella villa di famiglia. La sua estate viene sconvolta dall’arrivo di Oliver, un affascinante studente americano venuto a lavorare con il padre di Elio, professore di archeologia. Tra i due nasce un’attrazione improvvisa e potente che si trasforma in un primo amore indimenticabile, un’esperienza che segnerà profondamente la vita di Elio.
Il film di Luca Guadagnino è un’evocazione sensuale e struggente del primo amore, un’opera che cattura la pigrizia e l’intensità delle estati italiane. Prodotto in modo indipendente, il film si prende il tempo necessario per far sbocciare la relazione tra Elio e Oliver in modo naturale e credibile. La regia di Guadagnino è lussureggiante e immersiva, utilizzando la luce, i suoni e i paesaggi della campagna lombarda per creare un’atmosfera quasi tattile. . La storia è ambientata in un ambiente colto e accettante, permettendo al film di esplorare le sfumature universali del desiderio, della scoperta di sé e del dolore della perdita. La libertà del regista si manifesta nel suo approccio non voyeuristico e profondamente empatico. Il culmine emotivo del film non è un incontro fisico, ma il monologo finale del padre di Elio, un momento di straordinaria saggezza e compassione che eleva il film a un livello superiore. È un’opera che celebra la bellezza e il dolore di ogni grande amore, un classico istantaneo del cinema d’autore.
The Rider (2017)
Brady Blackburn, un giovane cowboy e astro nascente del rodeo, subisce un grave infortunio alla testa che pone fine alla sua carriera. Tornato a casa nella riserva di Pine Ridge, in South Dakota, Brady si trova di fronte a un futuro incerto, incapace di fare l’unica cosa che sente di saper fare: cavalcare. Mentre lotta per trovare una nuova identità, deve fare i conti con la sua famiglia, i suoi amici e il profondo legame che lo unisce ai cavalli.
Il film di Chloé Zhao è un’opera di una bellezza e di un’autenticità sconvolgenti, un neo-western che ridefinisce il genere. La sua indipendenza è totale, manifestandosi nell’approccio quasi documentaristico e nella scelta di utilizzare attori non professionisti che interpretano versioni di se stessi. Il protagonista, Brady Jandreau, è un vero cowboy che ha subito un infortunio simile a quello del suo personaggio. Questa fusione tra finzione e realtà conferisce al film una verità emotiva rara e preziosa. La regia di Zhao è contemplativa e lirica, catturando la maestosità dei paesaggi del South Dakota e l’intimità del rapporto tra l’uomo e l’animale. A differenza dei western tradizionali, The Rider non si concentra sull’azione, ma sull’interiorità del suo protagonista. È un film sulla mascolinità, sull’identità e sulla necessità di ridefinirsi quando il proprio sogno viene infranto. La libertà della regista le permette di raccontare una storia piccola e personale che assume una risonanza universale, un ritratto indimenticabile di un’America raramente vista al cinema.
A Ghost Story (2017)
Un musicista, C, muore in un incidente d’auto. Si risveglia all’obitorio come un fantasma, coperto da un lenzuolo bianco con due buchi per gli occhi. Incapace di comunicare con il mondo dei vivi, torna nella casa che condivideva con sua moglie, M, e la osserva mentre lei affronta il lutto e va avanti con la sua vita. Legato a quel luogo, il fantasma intraprende un viaggio cosmico attraverso il tempo, testimone silenzioso del passato, del presente e del futuro della casa, ossessionato da un biglietto che la moglie ha lasciato per lui.
Il film di David Lowery è una meditazione poetica e audace sull’amore, la perdita e il passare del tempo, un’opera che poteva essere realizzata solo con la totale libertà del cinema indipendente. La sua premessa, che prende l’immagine quasi comica di un fantasma da lenzuolo e la carica di un peso esistenziale, è una scommessa vinta. Girato in un formato 4:3 che accentua la sensazione di claustrofobia e intrappolamento, il film si affida a lunghi piani sequenza e a un dialogo minimo. La famosa scena in cui Rooney Mara mangia una torta per quasi cinque minuti è un atto di coraggio cinematografico, un’immersione senza filtri nel dolore del lutto. La narrazione non è lineare, ma si muove avanti e indietro nel tempo, esplorando temi come la memoria, l’attaccamento ai luoghi e la ricerca di un significato di fronte all’eternità. A Ghost Story è un film che dimostra come l’indipendenza possa dare vita a opere profondamente originali e filosofiche, capaci di trasformare una semplice storia di fantasmi in un’epopea cosmica sul senso della vita.
Columbus (2017)
Jin, un traduttore coreano, si ritrova bloccato a Columbus, Indiana, quando suo padre, un celebre architetto, cade in coma. Lì incontra Casey, una giovane appassionata di architettura che ha rinunciato ai suoi sogni per prendersi cura della madre. Mentre aspettano notizie dall’ospedale, i due esplorano la città, famosa per i suoi edifici modernisti, e attraverso le loro conversazioni sull’architettura, iniziano a confrontarsi con i loro sentimenti, le loro responsabilità e i loro desideri per il futuro.
L’esordio alla regia di Kogonada è un film di una bellezza e di una quiete straordinarie, un’opera che utilizza l’architettura come metafora delle strutture emotive che governano le nostre vite. La sua sensibilità è profondamente d’autore, evidente nella regia meticolosa e contemplativa. Ogni inquadratura è composta con la precisione di un architetto, trasformando gli edifici di Columbus in personaggi che dialogano con i protagonisti. Un film mainstream avrebbe probabilmente inserito una storia d’amore convenzionale. Kogonada, invece, si concentra su un tipo di connessione più rara e intellettuale, un’amicizia basata sulla condivisione di una passione e sulla comprensione reciproca. Il film si prende il suo tempo, affidandosi a dialoghi intelligenti e a lunghi silenzi, permettendo allo spettatore di immergersi nell’atmosfera della città e nello stato d’animo dei personaggi. Columbus è un’opera che dimostra come il cinema indipendente possa trovare il dramma nella contemplazione e la poesia nella geometria, un invito a guardare il mondo che ci circonda con occhi nuovi.
Eighth Grade (2018)
Kayla Day è una tredicenne all’ultima settimana delle scuole medie. Lotta con l’ansia e cerca disperatamente l’accettazione sociale, ma a scuola viene votata come “la più silenziosa”. Per far fronte alle sue insicurezze, pubblica video motivazionali su YouTube che nessuno guarda. Mentre naviga tra feste in piscina, cotte e l’onnipresenza dei social media, Kayla cerca di trovare la sua voce e di connettersi con suo padre, che fa del suo meglio per capirla.
L’opera prima del comico Bo Burnham è un ritratto incredibilmente onesto e empatico dell’adolescenza nell’era digitale. La sua sensibilità è puramente indipendente, evidente nella sua capacità di catturare l’ansia e l’imbarazzo di quell’età con una precisione quasi dolorosa. A differenza dei film per adolescenti prodotti dalle major, che spesso si affidano a cliché e a trame idealizzate, Eighth Grade è radicato in una realtà riconoscibile. Il film esplora in modo intelligente come i social media modellino l’identità dei giovani, mostrando come la ricerca di approvazione online possa amplificare le insicurezze del mondo reale. La performance di Elsie Fisher è di una naturalezza disarmante. Burnham, grazie alla sua libertà creativa, non ha paura di soffermarsi sui momenti più imbarazzanti e scomodi, perché è lì che si trova la verità del suo personaggio. È un film che non giudica, ma comprende, e che riesce a essere al tempo stesso esilarante e straziante. È un’opera che dimostra come il cinema indipendente sia il luogo ideale per raccontare le storie del presente con autenticità e cuore.
Capernaum (2018)
Zain, un ragazzino di circa dodici anni che vive negli slum di Beirut, decide di fare causa ai suoi genitori. La sua accusa? Averlo messo al mondo. Attraverso un lungo flashback, il film ripercorre la sua vita di stenti, segnata dalla povertà, dall’abbandono e dalla necessità di sopravvivere per strada. Dopo essere fuggito di casa, Zain trova rifugio presso Rahil, un’immigrata etiope senza documenti, e si prende cura del suo bambino, Yonas, vivendo un breve momento di famiglia surrogata prima che la realtà torni a bussare.
Il film di Nadine Labaki è un pugno nello stomaco, un’opera di un realismo quasi insopportabile che dà voce ai bambini invisibili delle periferie del mondo. La sua natura indipendente è evidente nell’approccio quasi documentaristico e nella scelta di attori non professionisti, le cui vite reali si intrecciano con quelle dei personaggi che interpretano. Lo stesso protagonista, Zain Al Rafeea, era un rifugiato siriano che viveva per strada. Questa scelta conferisce al film un’autenticità sconvolgente, cancellando il confine tra finzione e realtà. La libertà produttiva ha permesso a Labaki di immergersi completamente in questo mondo, senza filtri o edulcorazioni. La telecamera, ad altezza di bambino, ci costringe a vedere il mondo attraverso gli occhi di Zain, un mondo caotico, ingiusto e privo di speranza. Nonostante la durezza dei temi, Capernaum non è un film nichilista. È un atto d’accusa contro una società che abbandona i suoi figli, ma è anche una celebrazione della resilienza e della dignità umana. La determinazione di Zain, la sua capacità di amare e proteggere Yonas, è un raggio di luce in un’oscurità profonda. È un film che dimostra il potere del cinema indipendente come strumento di denuncia sociale e di profonda empatia.
Shoplifters (2018)
In un angolo affollato di Tokyo, una famiglia allargata vive ai margini della società, sopravvivendo grazie a piccole truffe e furti nei supermercati. Nonostante la povertà, i legami che li uniscono sembrano forti e affettuosi. Una notte, il “padre” Osamu trova una bambina abbandonata al freddo e decide di portarla a casa. La piccola viene accolta nel gruppo, ma la sua presenza farà emergere segreti nascosti e metterà in discussione la vera natura di quella famiglia improvvisata.
Il capolavoro di Hirokazu Kore-eda, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, è un’esplorazione delicata e profonda del concetto di famiglia. Come gran parte del suo lavoro, il film è prodotto in modo indipendente, permettendo al regista di sviluppare la sua visione personale senza compromessi. Kore-eda mette in discussione l’idea che i legami di sangue siano gli unici a definire una famiglia, suggerendo che l’amore, la cura e la scelta possano essere fondamenta altrettanto, se non più, solide. Il film non idealizza i suoi personaggi; sono ladri e imbroglioni, ma le loro azioni sono dettate dalla necessità e da un profondo bisogno di connessione. La regia di Kore-eda è sottile e osservazionale, catturando i piccoli momenti di intimità e tenerezza che rivelano la forza dei loro legami. Invece di un dramma urlato, Shoplifters è un film di sussurri e sguardi, che si affida alla sensibilità dello spettatore. La sua indipendenza gli permette di porre domande complesse senza offrire risposte semplici: cosa rende una famiglia tale? È meglio una famiglia imperfetta ma amorevole di una “normale” ma abusiva? È un’opera che dimostra come il cinema d’autore possa affrontare grandi temi sociali con una grazia e una profondità ineguagliabili.
An Elephant Sitting Still (2018)
In una grigia città industriale nel nord della Cina, le vite di quattro persone si intrecciano nell’arco di una singola, desolata giornata. Un adolescente che ha spinto un bullo giù dalle scale, il suo amico tormentato, una ragazza coinvolta in una relazione con un insegnante e un anziano cacciato di casa dal figlio. Tutti sono intrappolati in un’esistenza senza speranza, e la loro unica, flebile via di fuga è la leggenda di un elefante a Manzhouli che siede immobile, indifferente al mondo.
L’opera prima e unica del regista Hu Bo, che si è tolto la vita poco dopo averla completata, è un film monumentale e devastante, un’immersione di quasi quattro ore in un mondo di disperazione esistenziale. La sua esistenza è un atto di pura indipendenza artistica, un rifiuto totale di ogni compromesso commerciale. La durata, i lunghi piani sequenza e il ritmo lento e contemplativo sono scelte radicali che creano un’esperienza cinematografica totalizzante e quasi ipnotica. Il film è un ritratto spietato di una società in cui l’empatia è assente e la violenza è latente in ogni interazione. I personaggi sono anime perse, alla deriva in un paesaggio urbano e morale desolato. L’elefante di Manzhouli diventa un simbolo potente: una metafora della resilienza, della capacità di sopportare il dolore, ma anche un’immagine di apatia e rassegnazione. Nonostante la sua cupezza, il film non è privo di una bellezza straziante. La fotografia cattura la poesia nascosta nel degrado, e le performance degli attori sono di una sensibilità commovente. È un’opera difficile, che richiede pazienza e dedizione, ma che ricompensa con una visione del mondo potente e indimenticabile, un testamento tragico e magnifico di un grande talento.
Burning (2018)
Jong-su, un giovane aspirante scrittore che vive di lavoretti, incontra per caso Hae-mi, una sua ex vicina di casa. I due iniziano una relazione, ma lei parte per un viaggio in Africa e torna in compagnia di Ben, un uomo enigmatico e facoltoso. Ben rivela a Jong-su un hobby inquietante: bruciare serre abbandonate. Quando Hae-mi scompare improvvisamente, Jong-su si convince che Ben sia coinvolto e inizia un’ossessiva ricerca della verità, sprofondando in un abisso di paranoia e sospetto.
Il film di Lee Chang-dong è un thriller psicologico magistrale, un’opera che brucia lentamente per poi esplodere in un finale ambiguo e inquietante. La sua indipendenza gli permette di sovvertire le convenzioni del genere. Invece di affidarsi a colpi di scena e a un ritmo incalzante, Burning costruisce la tensione attraverso l’atmosfera, l’incertezza e la psicologia dei personaggi. Il film è un’esplorazione complessa della rabbia di classe, della gelosia e della natura sfuggente della realtà. La narrazione è filtrata interamente attraverso il punto di vista di Jong-su, un protagonista inaffidabile la cui percezione degli eventi potrebbe essere distorta dalla sua frustrazione e dal suo senso di inferiorità nei confronti di Ben. Questa soggettività radicale lascia lo spettatore nel dubbio: Ben è davvero un criminale o è solo una proiezione delle paure di Jong-su? Il mistero della serra bruciata e della scomparsa di Hae-mi non viene mai risolto in modo definitivo. Lee Chang-dong non è interessato a fornire risposte, ma a esplorare lo stato d’animo di una gioventù disillusa, intrappolata tra il desiderio e la realtà. È un film che si insinua sotto la pelle e continua a tormentare lo spettatore molto tempo dopo la visione.
Portrait of a Lady on Fire (2019)
Bretagna, fine del XVIII secolo. Marianne, una pittrice, viene ingaggiata per realizzare il ritratto di nozze di Héloïse, una giovane donna appena uscita dal convento e destinata a un matrimonio che non desidera. Poiché Héloïse si rifiuta di posare, Marianne deve osservarla di giorno e dipingerla di nascosto di notte. Tra le due donne, in un’isola isolata e in assenza di sguardi maschili, nasce un amore intenso e fugace, destinato a consumarsi prima della partenza di Marianne.
Il film di Céline Sciamma è un’opera di una bellezza e di un’intelligenza abbaglianti, un manifesto del “female gaze” (sguardo femminile) e una riflessione profonda sull’arte, la memoria e l’amore. La sua indipendenza è cruciale per il suo approccio radicale alla rappresentazione del desiderio femminile. Il film è costruito interamente dalla prospettiva delle donne, eliminando quasi del tutto la presenza maschile e, con essa, lo sguardo oggettivante che ha dominato la storia del cinema e dell’arte. La relazione tra Marianne e Héloïse non è solo una storia d’amore, ma un processo di creazione reciproca. Marianne dipinge Héloïse, ma è anche “dipinta” dal suo sguardo. Il loro amore è un dialogo tra pari, un’esplorazione della soggettività che si oppone alla tradizionale dinamica tra artista e musa. La regia di Sciamma è di una precisione pittorica, ogni inquadratura è composta come un quadro. Il film esplora anche la solidarietà femminile, come nella potente scena dell’aborto, trattata con una normalità e una delicatezza prive di giudizio. Portrait of a Lady on Fire è un’opera che dimostra come il cinema indipendente possa creare nuovi linguaggi visivi e narrativi per raccontare storie che sono state a lungo messe a tacere.
The Souvenir (2019)
Londra, anni ’80. Julie, una giovane e timida studentessa di cinema, inizia una relazione con Anthony, un uomo più grande, carismatico e misterioso che lavora al Foreign Office. Mentre cerca di trovare la sua voce come artista, Julie si innamora profondamente di lui, ignorando i segnali preoccupanti e le menzogne che circondano la sua vita. La loro relazione, intensa e tumultuosa, la porterà a confrontarsi con la dura realtà della dipendenza e del tradimento, rischiando di distruggere i suoi sogni.
Il film di Joanna Hogg è un’opera semi-autobiografica di una sincerità e di una vulnerabilità quasi dolorose, un ritratto intimo della formazione di un’artista. La sua indipendenza è la chiave del suo approccio non convenzionale alla memoria. Il film non è una ricostruzione lineare degli eventi, ma un mosaico di frammenti, di momenti e di sensazioni, che riflette il modo in cui ricordiamo il passato. La regia di Hogg è ellittica e misurata, spesso lasciando che le scene si svolgano in lunghi piani sequenza che catturano le sfumature delle interazioni. La libertà della regista le permette di evitare i cliché del dramma romantico. La relazione tra Julie e Anthony non è idealizzata; è complessa, tossica e profondamente reale. Il film non giudica Julie per la sua ingenuità, ma esplora con empatia come l’amore possa accecare e come l’esperienza, anche quella più dolorosa, sia fondamentale per la crescita artistica e personale. È un’opera che dimostra come il cinema d’autore possa trasformare la memoria personale in un’esperienza universale.
The Farewell (2019)
Billi, una giovane scrittrice cino-americana che vive a New York, scopre che alla sua amata nonna, Nai Nai, in Cina, restano solo poche settimane di vita. La famiglia decide di nascondere la diagnosi alla matriarca, organizzando un finto matrimonio come pretesto per riunirsi tutti e dirle addio. Combattuta tra il dovere di mantenere il segreto e l’impulso occidentale di dire la verità, Billi torna in Cina e si confronta con le complesse dinamiche familiari e culturali.
Basato su una “bugia vera” della vita della regista Lulu Wang, The Farewell è un film profondamente personale che esplora il divario culturale tra Oriente e Occidente attraverso la lente di una singola famiglia. La sua indipendenza è fondamentale, poiché permette a Wang di raccontare una storia culturalmente specifica senza la necessità di annacquarla o di spiegarla eccessivamente per un pubblico occidentale. Il film non giudica nessuna delle due prospettive; piuttosto, le esplora con empatia e umorismo. La decisione della famiglia di nascondere la verità a Nai Nai, radicata in una concezione collettivista del dolore, si scontra con l’individualismo di Billi, per cui la verità è un diritto inalienabile. Questa tensione è il motore emotivo del film. The Farewell evita i cliché del dramma familiare, trovando l’umorismo nell’assurdità della situazione e la commozione nei piccoli gesti. La regia di Wang è misurata e attenta, catturando le sfumature delle interazioni familiari e il senso di spaesamento di Billi, divisa tra due mondi. È un’opera che dimostra come il cinema indipendente sia il terreno ideale per le voci di registi che attingono alla propria esperienza per raccontare storie universali sulla famiglia, l’identità e il significato di “casa.
Film drammatici anni 2020
L’alba degli anni 2020 ha segnato per la cinematografia mondiale un punto di non ritorno, un confine temporale tracciato non solo dal calendario ma da uno sconvolgimento sistemico senza precedenti nella storia recente. La pandemia globale, le crisi geopolitiche riemergenti e la radicalizzazione delle disuguaglianze economiche hanno agito come catalizzatori per una nuova sensibilità artistica. Il cinema drammatico di questo decennio non si limita più a raccontare storie; esso funge da archivio emotivo di un’umanità in stato di shock, dislocata fisicamente e psicologicamente.
Un altro giro (Another Round, 2020)
Quattro insegnanti di liceo, annoiati e insoddisfatti delle loro vite, decidono di mettere alla prova la teoria di uno psicologo secondo cui l’uomo nasce con una carenza di alcol nel sangue. Iniziano così un esperimento: mantenere un tasso alcolemico costante durante il giorno per ritrovare la creatività e la gioia di vivere. Inizialmente, i risultati sono sorprendenti e positivi, ma l’esperimento presto sfugge di mano, portando a conseguenze tanto esilaranti quanto tragiche.
. La sua produzione indipendente è evidente nel suo approccio tonale complesso e non giudicante. Invece di offrire una semplice morale sui pericoli dell’alcol, il film celebra la vita e l’amicizia, pur riconoscendo il potenziale distruttivo dell’esperimento dei protagonisti. Un film di una major avrebbe probabilmente virato verso una commedia farsesca o un dramma ammonitore. Vinterberg, invece, mantiene un equilibrio precario, permettendo allo spettatore di provare empatia per i personaggi anche quando le loro azioni diventano sconsiderate. La performance di Mads Mikkelsen è straordinaria, capace di trasmettere sia la disperazione che la ritrovata euforia del suo personaggio. Il finale, con la sua danza esplosiva e catartica, è un momento di puro cinema d’autore. È un finale ambiguo, che può essere interpretato come un trionfo o una ricaduta, e che si rifiuta di fornire risposte facili. Questa apertura all’interpretazione è un lusso che solo il cinema indipendente può permettersi, un invito a riflettere sulla complessità della vita piuttosto che a ricevere una lezione preconfezionata.
Nomadland (2020)
Dopo aver perso tutto nella Grande Recessione, Fern, una donna sulla sessantina, decide di abbandonare la sua vita convenzionale. Carica i suoi averi su un furgone e si mette in viaggio attraverso il vasto paesaggio dell’Ovest americano, unendosi a una comunità di nomadi moderni. Vivendo ai margini della società, Fern impara a sopravvivere, a trovare lavoro stagionale e a creare nuovi legami, mentre cerca un nuovo senso di “casa” e di appartenenza.
Il film di Chloé Zhao, vincitore dell’Oscar, si colloca in quella zona di confine tra cinema indipendente e produzione di studio, essendo distribuito da Searchlight Pictures. Tuttavia, il suo spirito è inequivocabilmente “indie”. L’approccio quasi documentaristico, che mescola la finzione con la realtà attraverso l’uso di veri nomadi che interpretano versioni di se stessi, conferisce al film un’autenticità straordinaria. La libertà della regista si manifesta nel suo rifiuto di una struttura narrativa tradizionale. Nomadland non ha un inizio, uno svolgimento e una fine chiari; è un film ciclico ed episodico, che riflette il ritmo della vita nomade, fatto di partenze, incontri e addii. La regia di Zhao è contemplativa, catturando la bellezza maestosa e malinconica dei paesaggi americani, che diventano un personaggio a sé stante. Il film è un ritratto empatico di una comunità invisibile, una critica silenziosa a un sistema economico che scarta le persone, ma anche una celebrazione della resilienza, della solidarietà e della libertà di scegliere un percorso di vita alternativo.
The Father – Nulla è come sembra (2020)
Florian Zeller, nel suo debutto cinematografico, compie un’operazione di radicale riposizionamento del punto di vista. The Father non è un film sulla demenza, ma un film che simula l’esperienza della demenza dall’interno. Attraverso un montaggio disorientante e una scenografia mutevole, lo spettatore viene intrappolato nel labirinto cognitivo di Anthony (Anthony Hopkins). L’appartamento londinese, che dovrebbe essere il luogo della sicurezza e della memoria, si trasforma in uno spazio ostile e cangiante: i colori delle pareti mutano dal blu all’ocra, i mobili spariscono o cambiano disposizione, e la planimetria stessa sembra riconfigurarsi.
Al centro del film vi è una profonda indagine sulla dissoluzione dell’identità maschile patriarcale. Anthony è un uomo che ha costruito la sua vita sull’autorità e sull’indipendenza (“I am not leaving my flat!”, “Non lascerò il mio appartamento!”), e la malattia rappresenta per lui un’umiliazione intollerabile prima ancora che una sofferenza fisica. Il film esplora con crudeltà necessaria il ribaltamento dei ruoli genitoriali: il padre diventa figlio, richiedendo cure e pazienza, mentre la figlia è costretta a diventare madre del proprio genitore.
Drive My Car (2021)
In Drive My Car, diretto da Ryusuke Hamaguchi, la Saab 900 turbo rossa del protagonista non è un semplice mezzo di trasporto, ma un vero e proprio personaggio, uno spazio liminale e protetto dove avviene l’elaborazione del lutto. Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), attore e regista teatrale, ha un rapporto quasi sacro con la sua auto: è il luogo dove memorizza le battute ascoltando le registrazioni della moglie defunta, Oto. Quando è costretto ad affidare la guida a una giovane autista, Misaki Watari (Toko Miura), la violazione di questo spazio privato diventa il catalizzatore per un processo di guarigione condivisa.
La messa in scena di Zio Vanja di Cechov all’interno del film offre un livello di lettura ulteriore. Hamaguchi utilizza un cast multilingue, dove gli attori recitano ciascuno nella propria lingua madre (giapponese, mandarino, tagalog, coreano, lingua dei segni), senza comprendersi verbalmente ma connettendosi attraverso l’emozione e il testo.18 Questa scelta stilistica riflette il tema centrale dell’incomunicabilità e del superamento delle barriere.
Gli Spiriti dell’Isola (The Banshees of Inisherin, 2022)
Martin McDonagh ambienta The Banshees of Inisherin su un’isola fittizia al largo della costa irlandese nel 1923, mentre sulla terraferma infuria la guerra civile. Sebbene i cannoni si sentano solo in lontananza, il conflitto bellico trova una sua perfetta miniaturizzazione nella rottura improvvisa dell’amicizia tra Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson). La decisione di Colm di tagliare i ponti non per un torto subito, ma per una vaga aspirazione intellettuale e artistica (“Sei noioso”, dice a Pádraic), innesca una spirale di violenza che rispecchia l’assurdità delle guerre fratricide.
Al cuore del conflitto vi è uno scontro filosofico tra due visioni dell’esistenza. Colm è ossessionato dal lascito, dalla paura di essere dimenticato e dalla convinzione che solo l’arte (la musica) possa garantire l’immortalità. Per lui, la “gentilezza” di Pádraic è sinonimo di mediocrità, una perdita di tempo prezioso. Pádraic, al contrario, incarna un’etica della cura e della semplicità, dove il valore di una vita si misura nella bontà verso gli altri e verso gli animali (la sua amata asina Jenny).
Tár (2022)
Con Tár, Todd Field realizza uno dei ritratti più complessi e controversi del potere nell’era contemporanea. Cate Blanchett interpreta Lydia Tár, una direttrice d’orchestra all’apice della carriera, figura titanica che domina il mondo della musica classica. Il film si distingue per il rifiuto di dipingere Tár semplicemente come una “vittima” della cancel culture o come un mostro predatorio. Essa è entrambe le cose: un genio musicale capace di intuizioni sublimi e una manipolatrice narcisista che abusa della sua posizione per ottenere favori sessuali e professionali.
Un tema centrale è l’ossessione di Tár per il controllo del tempo. Come direttrice, il suo compito è “iniziare l’orologio”, piegare il tempo alla sua volontà interpretativa (“You cannot start without me. I start the clock”).32 Tuttavia, la narrazione mostra il collasso progressivo di questo controllo. Il passato irrisolto, sotto forma delle accuse legate al suicidio di una ex allieva (Krista), invade il presente.
Past Lives (2023)
L’esordio di Celine Song, Past Lives, introduce nel cinema mainstream occidentale il concetto coreano di In-Yun (provvidenza o destino relazionale), che suggerisce come ogni incontro tra due persone sia il risultato di migliaia di interazioni nelle vite precedenti. Il film segue Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) attraverso tre decenni, dall’infanzia a Seoul alla separazione, fino al ricongiungimento a New York. A differenza delle tipiche narrazioni romantiche hollywoodiane basate sul conflitto e sulla conquista, Past Lives è un film sulla rinuncia e sull’accettazione delle “vite non vissute”.
Past Lives è profondamente radicato nell’esperienza della diaspora. L’incontro con Hae Sung costringe Nora a confrontarsi con la perdita della sua identità culturale originaria. Come notato dalla critica, Nora non sta solo piangendo un amore perduto, ma sta “negoziando i sentimenti della perdita della sua cultura” e della bambina che ha dovuto lasciare indietro per diventare l’adulta che è oggi.
Killers of the Flower Moon (2023)
Con Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese compie una scelta narrativa audace discostandosi dalla struttura “whodunit” (giallo investigativo) del libro di David Grann per concentrarsi sulla relazione tossica tra Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) e Mollie Kyle (Lily Gladstone). Il film non cerca di nascondere i colpevoli; sappiamo fin dall’inizio che William Hale (Robert De Niro) e suo nipote Ernest stanno orchestrando il genocidio degli Osage per appropriarsi dei diritti petroliferi. Il vero mistero, e l’orrore del film, risiede nella domanda: come può Ernest professare amore per Mollie mentre la avvelena quotidianamente con l’insulina “corretta”?.
Il film ha sollevato un importante dibattito sulla rappresentazione delle voci indigene. Sebbene Scorsese abbia lavorato a stretto contatto con la nazione Osage, integrando lingua e costumi, alcuni critici hanno lamentato che la sofferenza di Mollie e delle altre vittime (come Anna Brown e Rita Smith) sia spesso mostrata attraverso lo sguardo dei carnefici, rischiando di estetizzare il trauma.46 Mollie, pur magnificamente interpretata da Gladstone, passa gran parte del film in uno stato di sofferenza fisica e semi-incoscienza, limitando la sua agenzia narrativa.
Anatomia di una Caduta (Anatomy of a Fall, 2023)
Il vincitore della Palma d’Oro di Justine Triet, Anatomia di una Caduta, utilizza il tropo del dramma giudiziario per decostruire le dinamiche di potere all’interno della coppia moderna. Quando Samuel viene trovato morto ai piedi dello chalet, la moglie Sandra (Sandra Hüller) diventa l’unica sospettata. Il processo che segue non è un’indagine balistica, ma un’autopsia sociologica e morale della vita di Sandra. La sua bisessualità, il suo successo professionale superiore a quello del marito, la sua presunta “freddezza” e la sua infedeltà vengono presentate dall’accusa come prove indiziarie di una natura omicida.
Il film espone come il sistema giudiziario (e la società in generale) fatichi ad accettare una donna che non si conforma ai ruoli tradizionali di vittima o di madre devota. La scena centrale, un litigio registrato da Samuel il giorno prima della morte, viene analizzata in tribunale parola per parola. Qui emerge il tema della “verità” come narrazione: le parole, decontestualizzate, diventano armi. Samuel si sentiva “evirato” dal successo di Sandra, accusandola di “plagio” e di “imposizione” nella gestione del tempo e della famiglia, mentre Sandra difende il suo diritto a non scusarsi per le sue ambizioni.
Una visione curata da un regista, non da un algoritmo
In questo video ti spiego la nostra visione


